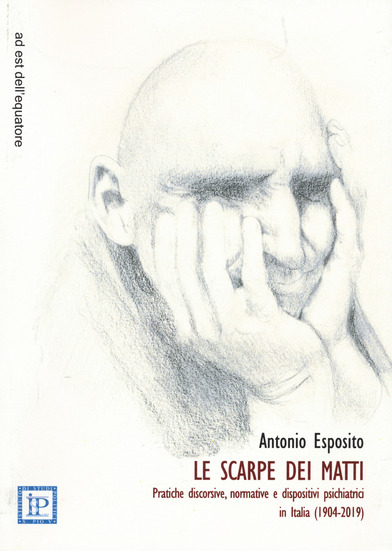È indubbiamente curioso intitolare un volume di 676 pagine – dal raro rigore storiografico, documentaristico ed accademico – a delle scarpe, le scarpe dei matti.
È indubbiamente da Antonio Esposito, ricercatore indipendente che si occupa di esclusione sociale, razzismo e storia della psichiatria.
Dopo tutto, Le scarpe dei matti è in primo luogo un inestimabile lavoro archeologico, con un sogno ben impresso nella mente, ad ogni riga. Quasi solo sfiorato a parole, onnipresente: disseppellire quelle scarpe dal sotterraneo delle Reali Case dei Matti di Aversa una ad una, con l’assurda quanto incrollabile pretesa di restituirle a chi le ha avute ai piedi un giorno.
Un granello di sabbia alla volta, l’Autore è chino per anni sulle rovine – sepolte e non – della psichiatria italiana.
Le scarpe dei matti è un ritratto pieno di fedeltà, in cui i punti di luce sono accurati quanto quelli d’ombra. Tanto curato da renderlo simile solo al ritratto dell’amante per l’amato. E come sola sa fare l’arte se per essa ci si è sporcati davvero le mani, dà la sensazione di esser quasi troppo intima per mostrarsi. «[…] non posso davvero esporlo. Vi ho messo dentro troppo di me» confessa Basil a Lord Henry, il ritratto di Dorian Gray davanti ai loro occhi. Al contrario di Basil, nonostante non abbia fatto alcuno sconto al volto più tetro delle evocazioni che genera un contatto profondo con la follia, Esposito apre la porta del ripostiglio, solleva il telo broccato e lascia che la luce tagli il volto del suo Dorian.
Sognando fortemente di diventare psichiatra, ho provato spesso la sensazione poco confortevole che «psichiatra» sia quasi una parolaccia, una cosa che non sta bene a dirla troppo forte. Che siano mosse dallo stigma, dal ruolo di carceriere-custode, oppure dalla violenza istituzionale che questa figura sembra incarnare costitutivamente, le opinioni in materia mi hanno fatto vacillare più e più volte.
Ma della psichiatria Le scarpe dei matti è insieme processo e apologia.
Senza incedere in riduzionismi di sorta, il testo oscilla continuamente – così come oscillano le psichiatrie nella storia – in un fluido quanto precario equilibrio tra i due poli opposti di custodia e cura.
È dunque processo alla psichiatria del paradigma paternalistico correttivo-morale, allo psichiatra «strumento della paura collettiva, della ripugnanza e del fastidio dell’uomo sano per l’uomo “diverso”», all’eugenetica con l’abito vecchio di epoca fascista e all’eugenetica con l’abito nuovo della ricerca bioingegneristica sui determinanti biologici e neurogenetici delle malattie: citando un polemico Lewontin, «quelle che in precedenza immaginavamo fossero complicate questioni morali, politiche ed economiche si rivelano alla fine non essere altro che il frutto di un’occasionale sostituzione di nucleotidi». Ancora, è processo alla psicofarmacologia «cosmetica», alla responsabilizzazione biogenetica del malato in nome di un’«ideologia riduzionistica [che] serve ad addossare i problemi sociali all’individuo, “biasimando la vittima” invece di esplorare le radici sociali e le determinanti dei fenomeni che ci riguardano». Al nocciolo della questione, è infine processo allo psichiatra che, ieri o oggi, non permette all’ansia e alle evocazioni terrifiche evocate in lui dalla follia di interrogarlo, e piuttosto fa sparire le sue emozioni dalla scena terapeutica col somministrare l’ultima benzodiazepina in commercio, che ottiene un duplice magico effetto «sull’ansia malata, come sull’ansia di chi cura».
È però anche apologia del sogno e del mandato interiore di vedere la persona nel paziente, dello psichiatra ogni qualvolta nella storia o nel presente metta radicalmente in discussione la sua cultura e le sue azioni, tenendo bene a mente il rischio di cristallizzarsi sulle proprie posizioni. È apologia della psichiatria che non arretra di un passo di fronte alla complessità epistemologica, razionale e morale che questo lavoro comporta, alla psichiatria che ogni giorno muore alle sue certezze e ogni giorno rinasce, in virtù di uno «sguardo utopico, che contrasta il pessimismo della ragione con l’ottimismo della prassi».
E allora, Le scarpe dei matti è un librone che mi insegna che «psichiatra» non è una parolaccia e che posso dirlo forte, il mio sogno, ma anche che ho scelto una vita difficile. Come tra i pionieri degli psicofarmaci, come per Basaglia nei Giardini di Abele e per Antonucci a Cividale – dove l’Autore mi conduce per mano per poi rimanerne spettatore – anche oggi, ora, è drammaticamente facile ritrovarsi a impastare la calce tra i mattoni del manicomio, mentre si brinda sulle sue macerie.
Così, da Le scarpe dei matti si possono imparare anche le insidie e le illusioni di questo roseto spinoso che è la psichiatria. Perché il manicomio, molto prima di essere nel passato e molto prima di essere in luoghi sempre altri dalle nostre patinate cliniche urbane, è sotto al nostro naso, in molte delle cliniche per disabili, RSA, REMS, Spdc dei nostri giorni. Ancora, molto prima di esser sotto al nostro naso, il manicomio è sopra al nostro naso: il più duro a morire – e il più bravo a risuscitare – dei manicomi che abbiamo da abbattere è quello nei nostri occhi.
Allora, quella che offre Esposito con il suo minuzioso lavoro di archeologo diventa un’opportunità, che non si limita affatto agli “addetti ai lavori”.
Se è vero infatti che la follia è in primo luogo uno dei mille volti dell’esclusione, se il matto «lo facciamo sparire» perché ci atterrisce la sua diversità esteriore, così simile al nostro più inaccettabile io interiore, allora questo è un problema che ci chiama in causa in virtù della sola appartenenza alla società civile.
Ci si potrebbe a questo punto domandare come possa accendere tali riflessioni di ordine epistemologico e morale quello che, banalizzato all’estremo, si potrebbe dire un libro di storia. Personalmente, se quando l’ho aperto per la prima volta ho provato quel solito “imbarazzo” per questa mia velleità psichiatrica, quando l’ho chiuso mi è rimasto un pensiero, timido ma potente: Si può fare. È difficile, come non nasconde il film di Fabio Bonifacci che reca questo ambizioso titolo, molto difficile, ma si può fare.
E perciò, umilmente, senza troppe pretese, per la mia generazione-senza-rivoluzione Le scarpe dei matti è anche una scuola di piccola rivoluzione. Tra le sue pagine, a passeggio nei luoghi delle molte psichiatrie italiane, si può imparare l’alfabeto del pensiero critico, a riconoscere la forma del cambiamento sin dal suo stato più embrionale, a immaginare il profumo del narciso dal bulbo polveroso.
Perché ho bisogno che qualcuno mi dica che si può fare? Da millennial, mi permetto una considerazione impopolare: non penso che i giovani rifiutino l’esistenza di “maestri”, non credo che il vuoto di valori coincida con la massima possibilità di scelta. L’indifferentismo è la trappola del mio tempo, è la maschera di libertà dietro la quale c’è il più subdolo dei determinismi. Forse, noi millennials ci siamo infine accorti che «Dio è morto»; forse, ci vergogniamo ad ammetterlo ma nelle profondità della nostra coscienza ogni tanto sentiamo la voce dell’«uomo folle» di Nietzsche, di colui che accende «una lanterna alla chiara luce del mattino». E la voce sepolta ci interroga, come l’uomo folle al mercato, «Chi ci dètte la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? […] Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina?».
Studiare i “maestri” di cui la storia ci parla consente a noi, studenti di ogni tempo, di vivere molte più vite dell’unica concessa, e di sceglierne una; serbare dei “maestri” è invece indispensabile per tentare di superarli per poi superare noi stessi, ogni giorno.
Come il significato di “dromo” stesso suggerisce, il testo di Esposito è l’orizzonte che non vogliamo strusciar via, non con un solo colpo di spugna.
Vogliamo forse piuttosto puntarlo ben saldo negli occhi, mentre ci sporgiamo in punta di piedi oltre la siepe dei muri vecchi e nuovi dei nostri luoghi di cura.
Vogliamo piuttosto prendere il pennello che la spugna, per scegliere il colore da aggiungere.
E se il libro di Antonio Esposito restituisce le scarpe a chi non le ha potute scegliere, le scarpe ritrovate non sono scarpe con suole rumorose che invadono il lettore.
Sono piuttosto scarpette da ballerina, cucite ad arte per permettere una danza che sfiori appena il terreno. Come quella di Paolo e Francesca al vento della bufera infernale, è una danza sottile di anime leggere, esistenze troppo lievi al vento della vita.
pietà mi giunse, e fui quasi smarrito
I’ cominciai: «Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ‘nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggieri».
Ed elli a me: «Vedrai quando saranno
più presso a noi; e tu allor li priega
per quello amor che i mena, ed ei verranno».
La Divina Commedia, Inferno – canto V