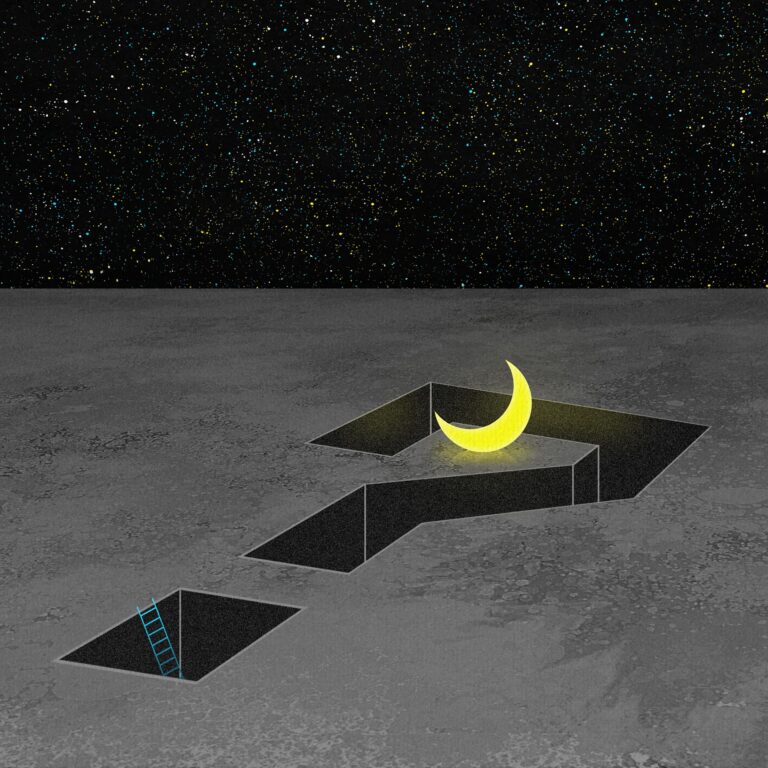Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna (Gv 3,16)
La promessa della vita eterna ricorre insistente nei Vangeli e nelle lettere apostoliche ed è forse il messaggio più caratterizzante della fede cristiana, pur nella pluralità di interpretazioni e sfumature possibili. Il tema del significato della morte e della relazione tra morte e peccato sono approfonditi in modo particolare da Paolo di Tarso nella lettera ai Romani.
La morte sarebbe entrata nel mondo in seguito alla trasgressione compiuta da Adamo.
«Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato.» (Rm 5,12)
La relazione tra peccato e morte è strettissima e la resurrezione di Gesù ha aperto per tutti gli uomini un’alternativa. Il tema del «peccato originale» inteso come caduta e decadenza da uno stato di grazia di cui l’uomo godeva al momento della creazione, è ampiamente attestato nella letteratura successiva, non solo religiosa, ma risulta in effetti assente dall’Antico e dal Nuovo Testamento, ad eccezione dei passi paolini qui citati e del libro della Sapienza (2, 23).
«Perché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore» (Rm 6, 23).
Non è evidentemente questa la sede per una trattazione del tema dal punto di vista teologico. Quello che muove questo articolo è piuttosto una curiosità letteraria. Dal testo della lettera ai Romani sembrerebbe evincersi che se Adamo non avesse disobbedito lui e tutto il resto dell’umanità avrebbero goduto dell’immortalità.
È davvero così?
Un’occasione persa per sempre
«Yhwh Elohim piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l’uomo che aveva plasmato. Yhwh Elohim fece spuntare dal suolo ogni albero bello a vedersi e buono da mangiare, l’Albero della Vita in mezzo al giardino e l’Albero della Conoscenza del Bene e del Male[1]» (Gen 2, 8-9).
Esaminando ordinatamente il racconto della Genesi, una prima considerazione riguarda il fatto che gli alberi notevoli nel giardino sono due e non uno soltanto: questo particolare risulterà fondamentale nei versetti conclusivi della narrazione, per la comprensione del senso dell’intero episodio. Tuttavia, l’Albero della Vita non viene più menzionato nei versetti successivi e gli eventi principali sembrano riguardare un albero soltanto: il frutto di quel solo albero in mezzo al giardino viene proibito ad Adamo già prima della creazione della donna; un solo albero viene nominato nella conversazione tra Eva e il serpente e poi nei versetti successivi, fino al versetto 22 del capitolo terzo.
Le parole insinuanti del serpente, la più astuta tra le creature di Dio, descrivono efficacemente l’effetto del frutto dell’albero proibito:
«Elohim sa che quando mangerete da esso [cioe`: il frutto dell’albero] i vostri occhi si apriranno e voi sarete come Elohim, conoscerete il bene e il male» (3, 5).
Questo interessante discorso non solo sortisce l’effetto voluto, ma si rivela anche veritiero: al v. 22 Yhwh constata l’accaduto («Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male»), ne è preoccupato («che non stenda la sua mano per prendere anche il frutto dell’Albero della Vita e, mangiatolo, viva per sempre!») e prende gli opportuni provvedimenti:
«Yhwh Elohim lo cacciò dal giardino di Eden… e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada volteggiante[2] (?) che custodissero la strada verso l’Albero della Vita» (Gen 3, 23-24).
Come ha osservato James Barr,[3] questa narrazione non racconta l’origine del peccato e del male, ma descrive piuttosto come l’uomo sia arrivato a un passo dalla conquista dell’immortalità, ma l’abbia poi persa definitivamente. Dal racconto della Genesi non si ricava in effetti l’impressione che l’uomo sia stato creato immortale e che la sua disobbedienza l’abbia portato alla mortalità: l’uomo e la donna, infatti, non mangiavano abitualmente del frutto dell’Albero della Vita, che anzi era loro vietato. L’allontanamento dei due dal giardino è volto ad evitare che l’uomo, oltre alla conoscenza, ottenga anche la vita eterna. Le parole della punizione divina (Gen 3, 16-19) non sembrano introdurre la mortalità umana come realtà nuova nell’esistenza di Adamo (la parola morte è del tutto assente da questo discorso di Dio), ma descrivono piuttosto le nuove modalità dell’esistenza: il lavoro, la fatica, la sofferenza. Contro l’uomo e la donna Yhwh non pronuncia nemmeno una formula di maledizione vera e propria, come quelle che destina al serpente e alla terra.
Le condizioni di vita descritte sono certo molto dure e richiamano da vicino la concezione della dimensione umana quale è espressa da testi babilonesi[4]: l’uomo è stato creato per la fatica (nel caso di alcuni miti mesopotamici, esattamente per liberare gli esseri divini dalla fatica quotidiana che la normale manutenzione del mondo prevede). La storia sembra iniziare da questo momento, con l’instaurarsi di condizioni di vita tristemente «umane»: è significativo che solo a questo punto Adamo assegni alla donna il nome Eva, «perché è diventata la madre di tutti i viventi».
La conoscenza del bene e del male e un vestito nuovo
Vorrei ora attirare l’attenzione su un particolare piuttosto singolare del racconto. Nonostante la sua ira, «Yhwh Elohim fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì» (Gen 3, 21). Questa attenzione è per lo meno curiosa, dopo le dure parole di condanna appena pronunciate: a riprova della stranezza del gesto divino, si può osservare che nelle rappresentazioni iconografiche della cacciata dal paradiso, compresa quella michelangiolesca della Cappella Sistina, Adamo ed Eva al momento della cacciata sono raffigurati nudi, mentre spesso vengono ritratti vestiti nel momento precedente alla cacciata (a volte, ad esempio in alcune icone bizantine, addirittura in abiti regali). Anche l’interpretazione rabbinica ha cercato di smorzare questa apparente bizzarria intendendo l’espressione “tuniche di pelle” come una perifrasi per indicare la pelle del corpo. Ma il testo biblico è molto chiaro a riguardo: se prima Adamo ed Eva erano nudi, in seguito alla loro trasgressione sono stati vestiti.
Sembrerebbe che Dio stesso riconosca che Adamo e la sua compagna abbiano raggiunto un nuovo status, in virtù del quale la loro condizione di nudità non è più adeguata. L’attribuzione della veste corrisponde apparentemente alla constatazione del v. 22: «Ecco l’uomo è diventato come uno di noi».
In cosa consiste questa somiglianza, che eleva Adamo dalla semplice condizione umana?
Le interpretazioni dell’espressione «conoscenza del bene e del male» sono comprensibilmente numerosissime, in considerazione della pregnanza che essa assume per l’esegesi dell’intero brano. Nella lingua ebraica, l’espressione «conoscere il bene e il male» può avere l’accezione di «conoscere tutto», nel senso di riuscire a riconoscere gli opposti. Questa prerogativa eccezionale, nella cultura del Vicino Oriente antico, era una caratteristica delle figure regali, che in virtù della loro funzione erano dotate di facoltà superiori a quelle dell’uomo comune. In particolare, risulta utile il confronto con un passo del secondo libro di Samuele (2 Sam 14, 27), in cui una saggia donna di Tekoa si rivolge al re Davide allo scopo di intercedere a favore di Assalonne:
«…poiché come un angelo di Dio, così è il mio signore il re per udire il bene e il male; Yhwh Dio tuo sia con te».
Il punto essenziale che viene ben evidenziato in questa frase è la capacità di distinguere tra bene e male, una prerogativa essenziale al sovrano quando riveste la sua funzione giudiziaria, uno dei tratti più tipici della regalità nel Vicino Oriente antico.
Un re di Israele rinomato per la sua proverbiale sapienza è naturalmente Salomone: tale dote viene esemplificata nei libri biblici specialmente attraverso aneddoti relativi alla straordinaria capacità di amministrare la giustizia. Si veda il celebre episodio del giudizio di Salomone (1 Re 3, 16-28), che si chiude con il significativo versetto:
«E tutto Israele ascoltò il giudizio pronunciato dal re ed ebbero timore di lui, perché videro che in lui c’era la sapienza di Elohim per amministrare la giustizia».
La sapienza universale come attributo della regalità è un concetto ben radicato nella letteratura del Vicino Oriente antico. Gilgamesh, re di Uruk, sovrano ideale del mondo mesopotamico, «in ogni cosa raggiunse la completa saggezza» ed è questa prerogativa (e non l’immortalità) che lo distingue dall’uomo comune. Del re di Shurrupak, sopravvissuto al diluvio in un noto mito sumerico, non si ricorda nemmeno il nome proprio: l’epiteto Atramhasis, «il Molto Saggio», è sufficiente a caratterizzarlo.
La conoscenza del bene e del male sembra dunque aver elevato Adamo a una condizione in qualche misura regale[5]. Anche se la vita eterna gli è sfuggita di un soffio, Adamo attraverso la sua trasgressione è riuscito a rendersi simile agli dei («come uno di noi», dice di lui Yhwh) e questo comporta che sia vestito adeguatamente. L’indumento utilizzata sembra confermare l’interpretazione qui proposta. Nel caso della tunica consegnata ad Adamo il termine adoperato, ketonet, suggerisce qualcosa di più di un semplice vestito. La ricorrenza di ketonet al posto del più comune beged «veste» è nella Bibbia indice di una funzione particolare e privilegiata di chi indossa l’indumento. I più attestati indossatori di ketonet sono i sommi sacerdoti: nei passi relativi alla vestizione e alla consacrazione di Aronne e dei suoi figli (Es 28 e 29) si evince chiaramente che l’indumento denominato ketonet è un tipo particolare di veste, una veste sacra. In un oracolo del profeta Isaia, risulta indossare un ketonet anche Shebna, il «maggiordomo». Dal testo si evince chiaramente il nesso tra la tunica e il potere, di cui il personaggio viene bruscamente privato:
«Ti rimuoverò dalla tua carica e ti rovescerò dal tuo posto: in quel giorno chiamerò il mio servo Eliaqim figlio di Hilqiyahu e lo rivestirò della tua tunica (ketonet), lo cingerò con la tua cintura e porrò il tuo potere (memshalah) nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Porrò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide e se aprirà nessuno potrà chiudere e se chiuderà nessuno potrà aprire. Lo pianterò come paletto in luogo sicuro e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre» (Is 22, 19-23).
La tunica e la cintura (in ebraico abnet, un termine che ricorre anche in Es 28 e 29 citati sopra) sono evidentemente simboli del potere, della memshalah. E` interessante notare che la memshalah nella Bibbia ebraica è sempre attributo di Dio, re dell’universo, e dei sovrani, suoi rappresentanti sulla terra: in particolare, di Salomone (1 Re 9, 19; 2 Cr, 6), di Ezechia (Is 39, 2; 2 Re 20, 13), di Sennacherib re di Assiria (2 Cr 32, 9), del re di Media (Ger 51, 28), di Nabucodonosor di Babilonia (Ger 34, 1), del «re del mezzogiorno» nella profezia di Daniele (Dan 11, 5) e poi, dopo che il popolo ebraico si è caratterizzato come un popolo senza re, soltanto dei sacerdoti (che sostituiscono l’antico sovrano in molte delle sue funzioni, specialmente quelle connesse al culto)[6].
«La vita che tu cerchi, non la troverai»
La letteratura del Vicino Oriente antico offre molti esempi di personaggi che, come è successo ad Adamo, si sono trovati nella condizione di sfiorare l’immortalità, senza però riuscire ad ottenerla. Non è un caso che i protagonisti di queste vicende siano tutti re, o ad essi assimilabili: il problema ideologico sotteso alle numerose narrazioni, di cui si darà qui solo qualche esempio, nasce probabilmente dalla contraddizione teologica che sorgeva tra l’eccezionalità della figura del sovrano, tale perché in rapporto stretto con le divinità, e la mortalità a cui egli era comunque soggetto in quanto uomo.
Dalle narrazioni sumeriche e accadiche sappiamo con certezza che in Mesopotamia l’immortalità era preclusa al re. La figura di Gilgamesh, re di Uruk, è emblematica della vana ricerca della vita eterna, che costituisce il filo conduttore e il tema centrale dell’epopea nella sua versione più completa e organica, quella contenuta nella biblioteca del re assiro Assurbanipal, ma che è già evidente nelle opere sumeriche e paleobabilonesi antecedenti ad essa[7]. In un poema sumerico, ad esempio, viene descritta la morte dell’eroe. Al re, che ha avuto un sogno premonitore riguardo al proprio destino, il dio Enlil spiega:
«Egli ti ha, Gilgamesh, destinato alla regalità; alla vita eterna non ti ha destinato; a causa (della mancanza) della vita eterna, il tuo cuore non sia triste. Non ti abbattere, non essere depresso. Facendo sì che tu emetta giudizio su chi tra gli uomini ha commesso il male, facendo sì che tu emetta giudizio su chi ha fatto il male sciogliendo le tue leggi, ha dato a te il potere di mettere ordine nella luce e nell’oscurità del genere umano, ha dato a te il potere di primeggiare sull’umanità…».
Nella redazione paleobabilonese dell’epopea è la taverniera Siduri a ricordare a Gilgamesh i limiti della condizione umana:
«Gilgamesh, dove stai andando? La vita che cerchi, tu non la troverai. Quando gli dei crearono l’umanità, tennero la vita nelle loro mani. Così, Gilgamesh, riempi il tuo stomaco, giorno e notte datti alla gioia; fai festa ogni giorno. Giorno e notte canta e danza, che i tuoi vestiti siano puliti, che la tua testa sia lavata: lavati con acqua, gioisci del bambino che tiene stretta la tua mano, possa tua moglie godere al tuo petto…»
Nella redazione neoassira, la cosiddetta versione «classica», Gilgamesh affronta un lungo e pericoloso viaggio per incontrare Utanapishtim, l’eroe sopravvissuto al diluvio, perché sa a lui e a sua moglie gli dei hanno concesso di sfuggire alla morte trasportandoli al di là dei confini del mondo. A questo “Noè” mesopotamico tocca però deludere le speranze del re di Uruk:
«Perché ti sei agitato tanto? Cosa hai ottenuto? Ti sei indebolito con tutti i tuoi affanni. Hai soltanto riempito il tuo cuore di angoscia. Hai soltanto avvicinato il giorno lontano della verità. L’umanità è recisa come canne in un canneto…».
Lo rimprovera anzi di aver trascurato, per la sua vana ricerca, la propria dignità regale:
«Tu, che gli dei hanno creato con la carne di dei e di uomini; tu, che gli dei hanno fatto simile a tuo padre e tua madre; proprio tu, Gilgamesh, (ti sei ridotto) come un vagabondo!».
Di conseguenza, Utanapishtim da` istruzioni affinché l’aspetto di Gilgamesh torni adeguato alla sua condizione, nuovamente degno del suo rango regale:
«Poni sul capo un nuovo turbante; fagli indossare un vestito che lo rinobiliti. Fino a che egli non giunga alla sua città, fino a che non compia il suo viaggio, che il suo vestito non si scolori, che sia nuovo, che sia nuovo».
Il messaggio dell’epopea di Gilgamesh, un vero manifesto della regalità mesopotamica, è chiaro: la morte non risparmia nemmeno i re, per quanto grande possa essere la loro gloria. L’uomo, e il re più di altri, può adoperarsi per trovare qualche rimedio, guadagnandosi in terra una buona fama con imprese straordinarie, costruendo – come fa il re di Uruk – mura urbiche e altre opere imponenti, o assicurandosi una discendenza che ne perpetui il ricordo. Ma la morte, propria e delle persone care (la ricerca di Gilgamesh nasce infatti dall’incapacità di rassegnarsi davanti alla morte dell’amico fraterno Enkidu), è comunque una realtà con cui fare i conti. La tradizione mesopotamica ha voluto conservare a Gilgamesh la sua regalità anche nell’Oltretomba, ricordandolo come «signore degli Inferi».
La stessa sorte è attribuita, nell’Odissea, ad Achille, eroico re dei Mirmidoni.
«Prima da vivo ti onoravamo come gli dèi / noi Argivi» − osserva Odisseo − «e adesso tu signoreggi tra i morti, / quaggiù; perciò di essere morto non t’affliggere, Achille».
Ma il re risponde senza esitazione:
«Non lodarmi la morte, splendido Odisseo. / Vorrei esser bifolco, servire un padrone, / un diseredato, che non avesse ricchezza, / piuttosto che dominare su tutte l’ombre consunte».
La regalità risulta ancora una volta sconfitta dall’umana fragilità.
Dall’inizio del mondo, però, l’uomo non si è ancora arreso. Ormai non sono soltanto i re a chiedere:
«Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna?» (Lc 18, 18).
La buona notizia, una promessa democratica
Nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo, Gesù – rivolgendosi ai discepoli di Giovanni Battista – risponde con queste parole alla domanda del profeta se sia proprio lui quello che deve venire:
«andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi vengono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti si risvegliano, i poveri vengono evangelizzati, e beato colui che non si scandalizza di me».
Nell’elenco dei prodigi compiuti da Gesù – così come vengono riportati nell’elaborazione letteraria di Matteo – si riconosce una climax ascendente: dopo le guarigioni miracolose di ciechi, storpi, lebbrosi e sordi, il testo menziona qui prima i morti che si risvegliano e solo dopo i poveri (in greco, ptochoi) che ricevono la buona notizia, che è chiaramente il culmine dell’azione del Messia. Il contenuto del “lieto messaggio” è indicato in un passo del Vangelo di Luca (Lc 4, 17-21), quello in cui Gesù, all’inizio della sua vita pubblica, riferisce a se stesso un passo di una profezia di Isaia:
«Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia e, avendolo aperto, trovò il passo dove era scritto
‘Lo spirito del Signore è sopra di me.
Per questo mi ha unto,
mi ha mandato per annunciare un lieto messaggio agli ptochoi
a proclamare la liberazione per i prigionieri
e la vista per i ciechi,
per rimettere in libertà gli oppressi
e annunciare un anno di grazia del Signore’
e, arrotolato il volume e datolo all’inserviente, si sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano rivolti a lui. Allora cominciò a dire loro: ‘Oggi si è adempiuta questa scrittura (che voi avete udito) nelle le vostre orecchie’»
(Is 61,1-2a, ma con l’inserzione di Is 58, 6).
Molto significativa è l’associazione, già presente nell’oracolo di Isaia e in altri passi della Bibbia ebraica, tra la povertà e l’oppressione[8]. I “poveri” sono costantemente raffigurati come vittime di abuso e di violenza da parte dei forti, dei superbi, degli ingiusti e degli empi, che di solito si identificano con i ricchi. Il possesso di beni sembra, cioè, rappresentare nell’etica ebraica – almeno per come è codificata nei libri biblici – un ostacolo alla piena osservanza delle leggi di Dio, mentre al contrario la povertà e la bassa condizione sociale sono ricorrentemente associate alla virtù e alla pietà religiosa. Naturalmente, gli abusi e le violenze ai poveri possono essere intesi come azioni puramente umane, compiute ai danni dei soggetti più deboli e indifesi del popolo ebraico e nella maggior parte delle ricorrenze è in effetti così. C’è però una nutrita serie di passi biblici – tra i più antichi dell’intero corpus – in cui l’oppressione dei poveri sembra alludere ad un orizzonte tutt’altro che umano. Anche nel passo di Isaia citato nel Vangelo, in effetti, la restituzione della vista ai ciechi non pare del tutto coerente con una dimensione sociale e/o politica e infatti trova il suo compimento nelle guarigioni miracolose descritte nei Vangeli. Ma il contenuto della buona notizia pare andare anche oltre.
L’autore del salmo 107 passando in rassegna coloro che il Signore ha “riscattato dalla mano del nemico”, fa riferimento a quelli che giacevano nelle tenebre e nell’ombra di morte / prigionieri nella povertà (ptocheia) e nel ferro. Nell’intento del redattore, il ‘riscatto dalla mano del nemico’ si riferisce – come nel precedente salmo 106 – ad una fase precisa della storia di Israele, vale a dire la liberazione dalla schiavitù in Egitto; tuttavia molte delle immagini contenute nel salmo richiamano con precisione, anche lessicale, le antiche teomachie siro-palestinesi. In un mio studio precedente[9] ho avuto occasione di censire, contestualizzare e commentare queste immagini, collegandole direttamente alle rappresentazioni degli inferi nelle mitologie vicino-orientali e siro-palestinesi. Non è pertanto azzardato affermare che la prigionia nella ptocheia e nel ferro indichi in realtà la condizione dei defunti, oppressi e prigionieri nel mondo dei morti e che potranno essere salvati solo dall’intervento salvifico di Yhwh.
La ‘buona notizia’ espressa dal verbo evangelizzare nel passo di Isaia consiste allora, in questo senso, nell’annuncio della vittoria di Yhwh sul suo antagonista, il dio della Morte; una vittoria che porta come conseguenza il riscatto e la liberazione di tutti defunti. Citando – sia pure non testualmente – il brano di Isaia tratto dalla LXX, l’evangelista ritrae Gesù in un passaggio cruciale: nel momento, cioè, in cui egli proclama se stesso come colui che è venuto a liberare i prigionieri e gli oppressi, intesi qui, coerentemente con il testo profetico, non solo e non tanto in senso letterale ma in termini escatologici; è questa dunque la ‘buona notizia’: come Yhwh nell’Antico Testamento, così anche suo figlio è sceso sulla terra per riscattare i morti, “poveri” prigionieri e oppressi nel regno degli inferi. Attraverso la sua mortalità (e la sua effettiva morte) egli intende garantire la vita eterna per tutti gli uomini, tanto i vivi quanto i defunti ormai costretti nell’Oltretomba.
Proprio in questa chiave ne parla Paolo di Tarso, nella II Lettera ai Corinzi: «Infatti conoscete la grazia di signore nostro Gesù Cristo, poiché per voi essendo ricco si è fatto povero (ptochos), affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).
Riportando in questi termini il fondamento della predicazione di Gesù di Nazareth, gli evangelisti veicolano cioè al loro pubblico – con un raffinato gioco di rimandi linguistici, citazioni letterarie e memorie mitologiche – un messaggio duplice: per le classi più povere, la promessa di un riscatto dalla marginalità e dall’indigenza materiale; per le élite colte delle comunità greche ellenizzate, la prospettiva di un riscatto dalla morte nell’orizzonte di una religiosità salvifica, alternativa tanto al paganesimo politeistico tradizionale quanto alla cultualità di tipo misterico ormai diffusa in tutto l’oriente romano del I sec. d.C.
In questa seconda prospettiva, esistenziale e escatologica, la promessa della vita eterna continua a parlare anche oggi ai credenti di ogni cultura.
NOTE
[1] – Questa e le traduzioni del testo ebraico che seguono sono dell’autrice.
[2] – Il significato dell’espressione che traduco letteralmente «fiamma della spada volteggiante» è incomprensibile, a causa probabilmente di una corruttela testuale. La parola «cherubini» significa, etimologicamente, «guardiani» e indicava, nella tradizione vicino-orientale antica, quegli esseri mostruosi che proteggevano troni e passaggi, come ad esempio di tori alati raffigurati ai lati delle porte dei palazzi reali assiri. Sull’argomento rimando allo studio di M. Rivaroli, “Le stele di confine: un approccio storico-religioso”, in G. Regalzi (cur.), Le discipline orientalistiche come scienze storiche. Atti del 1° incontro Orientalisti (Roma, 6-7 dicembre 2001), Associazione Orientalisti, Roma 2002, pp. 49-50.
[3] – J. Barr, The Garden of Eden and the Hope of Immortality, Fortress, Philadelphia, 1983, p. 4.
[4] – Nei miti della creazione mesopotamici, in primo luogo il Poema di Atramhasis, l’uomo viene plasmato con il preciso scopo di alleviare gli dei dal lavoro e dunque, fin dall’inizio, la sua esistenza è marcata nettamente da questa finalità. Secondo i testi mitici accadici, l’uomo è plasmato dall’argilla, come Adamo, ma ad essa viene aggiunto un etemmu, cioè lo spirito di un dio ucciso. Si tratta di un marchio di morte, che ricorda all’uomo la caducità della sorte che lo attende. Al contrario, il «segno distintivo» di Adamo sembra essere la vita: nell’argilla di cui è plasmato viene infuso un «alito di vita» (Gen 2, 7).
[5] – Ho analizzato alcune delle connotazioni regali della figura di Adamo nel mio articolo “La regalità di Adamo”: Materia Giudaica VIII/1 (2003), pp. 77-86.
[6] – Il fatto che la vestizione dei sacerdoti descritta nell’Esodo sia ambientata in un passato remoto del popolo ebraico non toglie il fatto che la redazione del testo, certamente successiva all’esilio babilonese, sia relativamente recente.
[7] – Per l’edizione e la traduzione del poema di Gilgamesh, nelle sue diverse stesure, faccio riferimento a G. Pettinato, La saga di Gilgamesh, Rusconi, Milano 1992.
[8] – Per la parte conclusiva di questo articolo ho attinto alla tesi di dottorato di P. Giammellaro “‘Ptochos. Per una teoria della mendicità nella Grecia antica’, Università La Sapienza di Roma, febbraio 2019, e in particolare all’appendice, specificamente dedicata alle occorrenze del termine ptochos nei testi biblici in lingua greca. La maggior parte dei contenuti dell’interessante trattazione, ma purtroppo non l’appendice, sono confluiti nella monografia P. Giammellaro, Il mendicante nella Grecia antica. Teoria e modelli, Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni 23, Morcelliana, Roma 2019.
[9] – C. Peri, “Li ha riscattati dalla mano del nemico: un’interpretazione mitologica del Salmo 107”: Materia Giudaica X/1-2 (2004), pp. 129-136.