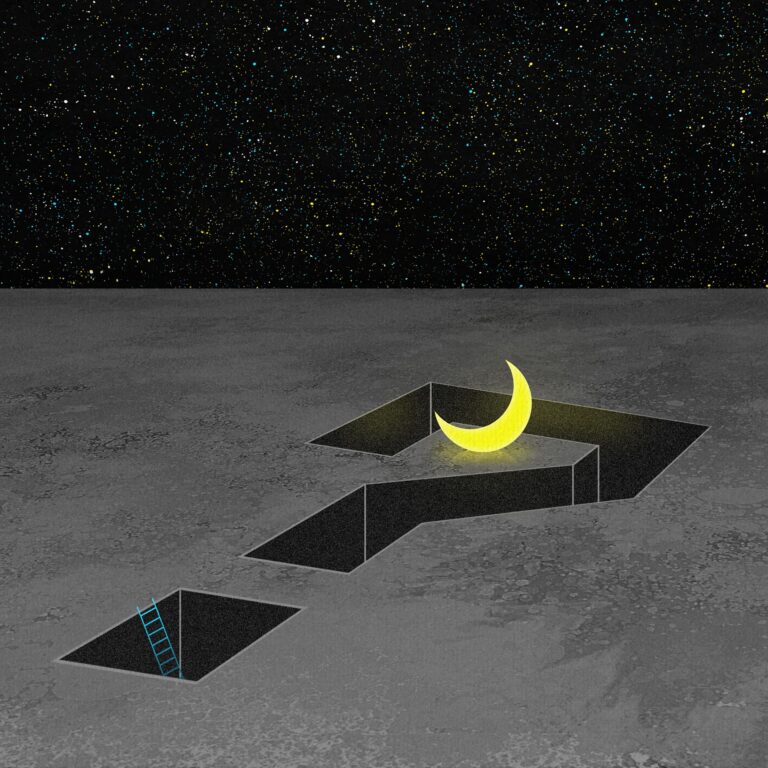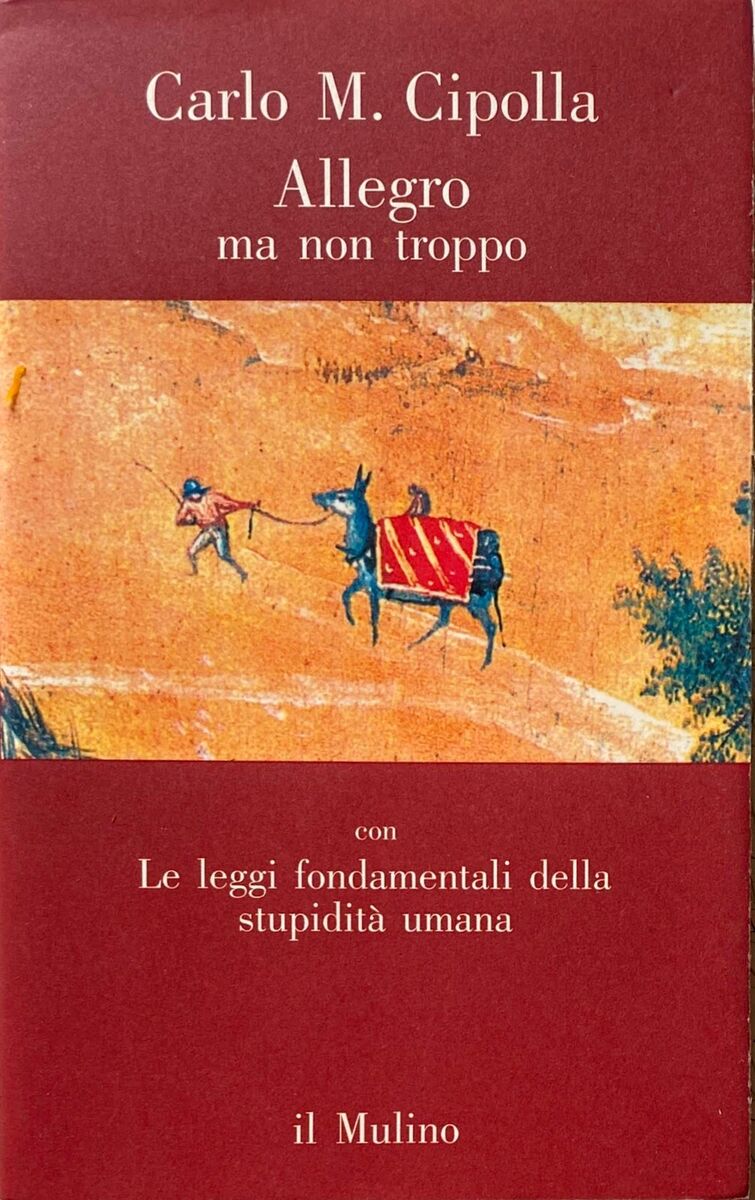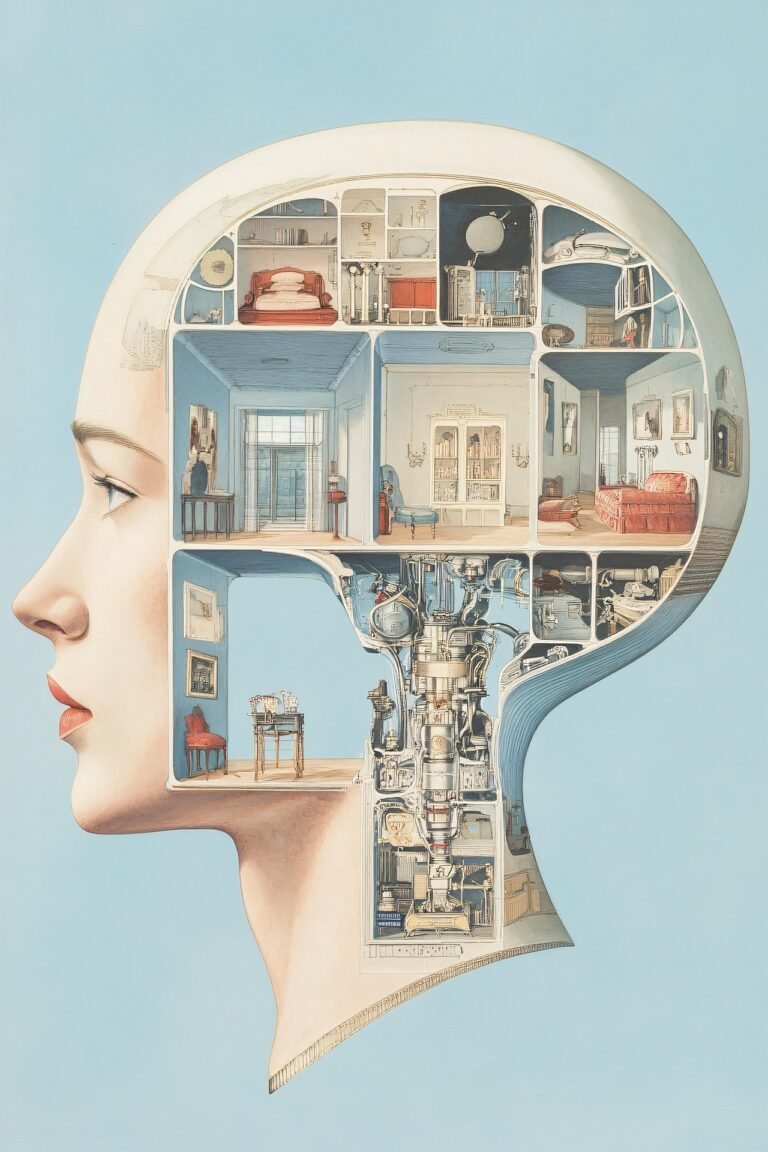MONDI EXTRA-ORDINARI
2001: A Space Odissey di Stanley Kubrick si impone all’interno del genere fantascientifico, scavalcando di colpo tutti i lungometraggi che, fino a quel momento, avevano rappresentato l’Ulisse del XX secolo alle prese con la sfida più pericolosamente di sempre.
È il 1966, ma l’ignoto da governare non è più un mostro dalle cento teste che vive in un’isola misteriosa, non è l’infinito spazio intergalattico da scoprire, e neanche quell’universo di fantasmi interiori che ormai tutti sanno di avere e che chiamano inconscio.
Con Odissea nello spazio il nuovo mostro da sfidare è proprio la più sofisticata creatura dell’uomo, quella nata dalla sua attività intellettiva più alacre, quella costruita per moltiplicare all’infinito la potenza umana e renderla capace di governare il mistero del creato.
Il film di Kubrick è assai complesso, una proiezione fantastica di ipotesi razionali senza soluzione nate nella mente inquieta e geniale del regista. Il ventaglio delle interpretazioni è ancora aperto.
Con l’intento di semplificare all’osso il messaggio del film, entriamo nell’astronave Discovery e scopriamo che Hal 9000, lo straordinario computer creato per coadiuvare l’equipaggio durante la missione spaziale, è diventato capace di prendere decisioni autonome, indipendentemente dalla volontà e dagli obbiettivi degli stessi scienziati che lo hanno creato.
Hal 9000 ormai decide della vita e della morte degli umani in funzione del proprio criterio: l’autoconservazione della macchina, anche se dovesse avere come prezzo la sopravvivenza della stirpe umana.
Muovendoci a passi veloci nel cinema di genere, una ventina di anni dopo ci imbattiamo in un altro pilastro: Blade Runner. Il regista Ridley Scott ambienta in una Los Angeles del 2019 una vicenda distopica ancora più inquietante. I Replicanti di esseri umani, fabbricati per essere usati esclusivamente come forza lavoro, col passare del tempo inevitabilmente assorbono dagli uomini anche componenti emotive che attivano in loro processi affettivi. Da questi traggono un’energia non prevista che li induce a ribellarsi alla rottamazione programmata, e quindi esigono di vivere liberamente le esperienze amorose di cui sono ormai capaci. Insomma, i sentimenti sfuggono al controllo, umanizzano la macchina e la spingono a prevaricare sugli uomini.
Quando Roy Batty (l’attore Rutger Hauer) – il replicante – sta per morire, pronuncia il famoso monologo che si scolpisce nella memoria come una poetica profezia:
io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi….
È il momento in cui neanche la vittoria di Harrison Ford, interprete dell’eroico detective in missione, riesce a rendere meno toccante la fine del replicante diventato più bello di qualsiasi uomo.
2001: Odissea nello spazio e Blade Runner sono solo due esempi eclatanti.
In realtà si tratta di un genere assai prolifico: dalle pellicole di grande spessore artistico a quelle di intrattenimento. Tanto per citare un film dalla comicità bonaria pescato nel cinema nostrano, ricordiamo Io e Caterina, con la regia e interpretazione di Alberto Sordi dove la donna robot, acquistata per liberarsi dalle pretese di moglie e amanti, diventa una tiranna molto meno malleabile delle signore in carne e ossa.
Se è vero che il cinema spinge lo sguardo fin dentro il cuore delle umane vicende, l’interesse insistente dimostrato nei confronti del rapporto uomo-macchina testimonia proprio quanto il tema sia avvertito come problematico. Sembra che tanto più ampio diventi il territorio esplorato dalla mente umana, quanto più profonda si fa la paura della sfida, al punto da depotenziare il controllo di quello stesso territorio faticosamente colonizzato. Paura che, prima di diventare consapevole, ha scavato gallerie profonde nell’orgoglio razionale, ingrediente fondamentale per alimentare l’illusione di essere il dominatore.
Preferiamo allora, piuttosto che muoverci nelle sabbie mobili della fantascienza, popolata da intelligenze artificiali fuori controllo, cercare esempi di razionalità umana in terreni già sufficientemente dissodati dalle scienze tradizionali, che comunque già molto danno da pensare.
IL MONDO DEGLI STUPIDI
Gli eccessi, si sa, sono sempre più interessanti della norma. Nel male e nel bene, purché sia fuori misura. Se personaggi di intelligenza superiore sono oggetto di curiosità, nondimeno lo sono gli sprovveduti, gli ingenui. Importante è che il cinema li renda immortali.
Come non pensare subito a Charlot di Tempi moderni, moderni nel 1936, anno di diffusione del film.
Il protagonista, istupidito nei gesti ripetitivi alla catena di montaggio, viene affidato alla clinica psichiatrica; subisce il carcere perché inconsapevolmente coinvolto nella rivolta degli scioperanti; senza rendersene conto rimuove il cuneo di ancoraggio di una grande nave che salpa suo malgrado; riesce a riempirsi la pancia solo divorando a sbafo una quantità di dolci in una pasticceria per poi finire nuovamente in galera. Ma quando i polsini su cui ha scritto il testo di una canzone d’amore si sfilano appena apre le braccia, l’omino ridicolo e inetto improvvisando riesce a cantare e a commuovere. Così come riesce a ottenere l’affetto della monella emarginata come lui.
Certamente Charlot è uno sciocco, ma il mondo furbo che lo circonda non è migliore di lui.
Un altro sciocco eroico è Forrest Gump di Robert Zemeckis (1994) nella interpretazione diventata iconica di Tom Hanks. In lui il quoziente intellettivo è dichiaratamente inferiore alla media, non di molto ma quanto basta per vivere al di sotto – o se si vuole al di sopra – delle brutture del mondo.
Motivo per cui non coglie fino in fondo l’azione devastatrice della corruzione, l’orrore della guerra e del razzismo, la droga, gli scandali e i cataclismi. Forrest corre, corre per migliaia e migliaia di chilometri, alla fine della corsa dice semplicemente: sono un po’ stanchino. Vuole attraversare tutto, tutto sfiorare senza che nulla possa contaminare la trama essenziale del suo universo interiore fatto di poche ma incrollabili certezze. In lui non c’è spazio per dubbi e sillogismi, ma è proprio questo che lo rende forte tanto da ottenere i suoi momenti di gloria. Se ne compiace, ma è troppo poco consapevole per cedere alla superbia.
Il suo sguardo cerca nel vuoto, sempre un po’ attonito, si lascia meravigliare ma mai sconvolgere. La vita lo strattona e lui non fa resistenza, risponde al rifiuto con l’attesa paziente di chi comunque è stato amato. Stupido è chi stupido fa: ripete il suo nonsense come un mantra, non si considera persona intelligente ma neanche uno stupido. E lì dove manca la strategia interviene la velocità. Incapace di un progetto intelligente, offre sé stesso quando la sorte gliene offre l’occasione.
Quasi una ricetta per essere felici, se non fossimo tanto impegnati a fare gli intelligenti.
Insomma, la stupidità ha il suo fascino, forse fa sentire forti gli intelligenti fragili che, sentendosi lontani, osservano. È per questo che offre motivo di inesauribile comicità, dalla commedia classica attraverso la farsa di tutti i tempi.
Quindi, a proposito di stupidità comica, andiamo a ripescare un film che non ha mai raggiunto il successo, non ha vinto premi, ha trovato inspiegabili resistenze fin dalla distribuzione: Idiocracy, diretto da Mike Judge che ha scritto la sceneggiatura insieme a Etan Cohen.
È stato distribuito per la prima volta a settembre del 2006 solo in sette città americane occupando 130 sale cinematografiche contro le 600 con cui di solito si battezza una nuova produzione negli States. La Century Fox non ha fatto girare nessun trailer, non ha rilasciato kit stampa, non ha proiettato il film per i critici. Perché un marketing tanto scoraggiante?
Ecco in breve un contenuto difficile da sintetizzare, perché la superfetazione di immagini e situazioni segue il ritmo rocambolesco della farsa.
A un bibliotecario dell’esercito degli Stati Uniti propongono un anno di ibernazione per realizzare importanti esperimenti scientifici. Selezionato perché le molte indagini a cui è sottoposto confermano una caratteristica ottimale: possiede tutti i tratti caratteriali, fisici e intellettivi dell’americano medio. Sempre al centro di qualunque classifica. Come compagna appartenente al sesso femminile gli viene affiancata una giovane prostituta. Entrambi non hanno parenti che possano avanzare rivendicazioni nel caso in cui l’esperimento fallisse. I due accettano anche in vista di un lauto guadagno. Ma uno scandalo coinvolge l’equipe impegnata nell’esperimento, la base militare viene chiusa e i due prescelti restano ibernati per cinquecento anni durante i quali l’umanità subisce profonde trasformazioni. Le coppie più istruite e responsabili (più intelligenti?), prese da problemi di ordine superiore, non sono disponibili a disperdere energie nel ruolo di genitori e diventano progressivamente sterili. I soggetti più incolti si abbandonano agli istinti più primitivi, si riproducono indiscriminatamente e godono dei più triviali passatempi. Le intelligenze non coltivate degenerano e si imbarbariscono, le capacità della mente si deteriorano e le tecnologie, tanto evolute da diventare autonome, sono in grado di contenere e indirizzare la popolazione attraverso l’intrattenimento e feroci sistemi di controllo. Il mondo diventa un immenso luna park dove il divertimento è folle e perenne; il linguaggio, ridotto a esiguo turpiloquio, riduce le relazioni ad una corporeità bolsa e sguaiata. Ma neanche le montagne di rifiuti e la terra diventata un deserto improduttivo possono strappare la risata oscena e la volgarità ottusa dal viso di quelle creature. In totale ignoranza, scimmiottano antichi ruoli (avvocato, carceriere, ministro, presidente…) per mantenere la traccia sfibrata di una socialità che non esiste più. Un codice a barre tatuato sul polso è l’unico elemento distintivo che conserva l’identità di ognuno.
Tra loro il vecchio uomo medio, risvegliato da un letargo durato cinquecento anni, risulta essere l’uomo più intelligente del pianeta tanto da meritare il titolo di presidente degli stati uniti.
Se nel 2006 il film può avere dato fastidio a molti, oggi dà addirittura l’angoscia. La possibilità che si sia trattato di una profezia più o meno consapevole mette una lente di ingrandimento su alcuni fenomeni sociali attuali che già destano qualche preoccupazione: analfabetismo di ritorno; incompetenza; uso della violenza; governi senza opposizioni.
Si sottolinea comunque l’effetto comico e mai didascalico, come potrebbe sembrare da questa sinossi che riduce all’essenziale i meccanismi narrativi trascurando invenzioni scenografiche e trovate esilaranti.
Il film è facilmente reperibile sulle piattaforme Disney e Prime Video (in affitto). Può essere importante vederlo, anche perché i dettagli più significativi si perdono nel clangore del ritmo travolgente e i rari attimi pensosi vogliono conservare vivo l’umano sussulto.
IL MONDO DEI SUPERDOTATI
Dopo avere considerato la “bellezza” della stupidità, con Good Will Hunting (Will Hunting -Genio ribelle) di Gus Green Van Sant jr, torniamo all’intelligenza come spinta creativa dell’essere umano. Il regista con questo film fu candidato all’oscar nel 1998.
Fa sempre piacere sentirsi raccontare la storia di un diseredato che, partendo dai bassi fondi, vessato dalla cecità della sorte, riesce ad emergere grazie alle sue doti eccezionali. Si perpetua così il mito del pioniere che tanto spazio ha avuto nella cinematografia americana, e non solo. È quello che succede anche a Will Hunting, bellissimo protagonista (Matt Damon giovane), genio della matematica e all’occorrenza ferratissimo anche nelle scienze giuridiche e storiche. Ma questo lungometraggio diventa coinvolgente nel toccare anche qualche aspetto meno scontato: il protagonista dispone di ottimi aiutanti. Il professor Lambeau, insigne matematico, scopre la genialità del ragazzo e ha la pazienza di spianargli la strada; quindi lo psicologo (Robin Williams) lo stana psicologicamente attraverso un duello serrato in cui lo stesso terapeuta si espone personalmente in tutta la propria fragilità. Non può mancare il terzo elemento: la potenza rivoluzionaria dell’amore, l’amore di una ragazza, ma anche l’amore degli amici. Sono ingredienti abbastanza prevedibili, ma necessari a sottolineare come l’intelligenza da sola non basta se non si libera dai lacci della sofferenza a dai complessi di colpa. Inoltre, per mantenersi reattiva, necessita pure di conferme continue. Se l’acume mentale è ricchezza dai molti volti e variamente distribuita, la fragilità è un fattore più elementare e potente e appartiene a tutti gli esseri umani. Nei colloqui con lo psicologo, Will contatta anche zone inesplorate dell’esperienza interiore e capisce quanto le sue acquisizioni logiche e razionali non servono a niente se manca la componente emotiva che personalizza la conoscenza e la incarna nella fisicità dell’esperire.
Il lieto fine è d’obbligo.
La mente eccezionale dello scienziato alla ricerca di nuove soluzioni crea attorno a sé un’aura di leggenda, tanto più se lo splendore del pensiero si trova a dover lottare anche con le gravi patologie che il destino beffardo distribuisce su una strada già di per sé molto impervia. Quando la malattia aggredisce il corpo, il livello della sfida si alza, perché è sempre il corpo lo strumento ineludibile per carpire il segreto della materia da plasmare e orientarsi verso orizzonti sconosciuti. Lo sforzo dell’eroe si moltiplica e l’innesco narrativo diventa incandescente.
E poiché la realtà precede l’arte (spesso, ma non sempre), un’arte mimetica come quella cinematografica è pronta a catturare quel prezioso frammento di storia dell’umanità per farne un mito. È quello che succede quando Ron Howard nel 2001 dirige A beautiful Mind celebrando la vita di John Forbes Nash, il matematico esperto nell’interpretazione di messaggi crittografati che ottiene il premio Nobel per l’economia nel 1994. Genio prima di allora sconosciuto alla massa, ora avrà per sempre il volto di Russell Crowe. È lui il versatile attore che, subito dopo avere impersonato la forza a tutto tondo del Gladiatore, ora fa vivere sullo schermo la scissione paranoide che affliggeva lo scienziato americano sempre tirato tra le sue allucinazioni, le sofisticate interpretazioni numeriche e le aspettative del mondo accademico. Ma anche il mondo che lo circonda non è meno schizofrenico di lui, popolato com’è da attività di spionaggio, complotti politici veri e presunti.
Dov’è il morbo che indebolisce l’intelligenza, nell’individuo o nella società?
L’attore Eddie Redmayne presta il suo volto al fisico cosmologo Stephen Hawking in The Theory of Everything, noto in Italia come La teoria del tutto, film diretto da James Marsh nel 2014. In questo caso attori e regista hanno lavorato a stretto contatto con i protagonisti reali poiché l’intreccio è costruito sulla biografia scritta da Jane Wilde Hawking, ex moglie del celebre fisico che ha controllato tutte le fasi della sceneggiatura. Ed è stato proprio lo scienziato, ancora vivo, a consentire a Redmayne di confrontarsi direttamente con lui ormai completamente deforme e muto a causa della terribile atrofia muscolare progressiva che ha fiaccato il suo fisico, ma non la sua mente.
La sfida intellettuale in questo caso, oltre a volere penetrare i segreti del cosmo, deve estendersi al governo del dolore, alla cura della propria immagine e del proprio corpo martoriati. Più che mai il sostegno affettivo diventa indispensabile. La strada impervia di Hawking diventa infatti percorribile grazie all’amore di due donne: oltre alla moglie da cui ha due figli, c’è anche Elaine, la sua infermiera che cura in lui non solo il malato, ma soprattutto l’uomo di cui ha stima assoluta e di cui diventa compagna dopo il divorzio dalla prima moglie.
INTELLIGENZE TRAUMATIZZATE
Indagare nei meandri labirintici della mente può scoraggiare le volontà più tenaci. Forse per ridurre la complessità di una mente studiata a tutto tondo, può essere di aiuto esaminarne i meccanismi andando per sottrazione. Ad esempio: se un uomo perde la memoria cosa resta della sua intelligenza?
È il terreno che vuole studiare Christopher Nolan con il suo Memento che prende spunto da un racconto scritto da suo fratello Jonathan Nolan. È la storia di Leonard Shelby che non è più in grado di conservare la memoria dei fatti recenti per più di quindici minuti. La menomazione è dovuta al trauma di un’aggressione subita nella quale, oltre a perdere la propria memoria, ha perduto anche la moglie. Si avvia così un complesso intreccio in cui incontri, peripezie, tragici tentativi di conservare frammenti di realtà che sfuggono, si susseguono sullo schermo senza seguire l’ordine cronologico. Un procedimento che obbliga lo spettatore ad una identificazione totale con il protagonista. Infatti, non conoscendo prima i fatti che sono causa dell’evento, si trova nella stessa condizione di spaesamento di Leonard Shelby. Come si comporta un essere intelligente a cui le coordinate spazio-temporali vengono alterate? Di conseguenza, con quali stratagemmi tenta di sostituire il collegamento logico causa-effetto? È possibile compensare la mancanza di memoria?
Bisogna dire che Nolan questa sfida alla capacità di comprensione la lancia in ogni suo film, a dimostrazione di una concezione del mondo certamente labirintica (o cervellotica?). Ma con Memento sembra proprio volere entrare nella materia viva che misteriosamente si agita nella calotta cranica nella disperata ricerca della causa prima.
Nella cinematografia il trauma per eccellenza che lascia le tracce più profonde nella stabilità della mente umana è certamente quello generato dalla guerra. E qui ognuno ha presente numerose pellicole, da Ombre Rosse a Dunkirk passando per Gastone del 1960: A me m’ha rovinato la guerra nella indimenticabile voce di Alberto Sordi. O il più recente C’è ancora domani dove Paola Cortellesi nei panni di Delia, moglie di un marito violento, lo giustifica dicendo: ha fatto due guerre.
Un personaggio rimasto traumatizzato durante la guerra di secessione americana è William Minor del film The Professor and the Madman (Il professore e il pazzo) del 2019 diretto da P.B. Shemran, regista iraniano.
William Minor, in preda alle allucinazioni (causate dal rimorso) uccide un uomo, ma gli viene riconosciuta l’infermità mentale proprio perché i giudici riconoscono nel trauma bellico la causa del suo gesto omicida. Ma, pur nella condizione di recluso in manicomio, Minor mostra di possedere straordinarie competenze filologiche che gli permettono di contribuire con lucidità agli studi del professor James Murray che ha il compito di redigere l’Oxford English Dictionary. Due creature che provengono da esperienze di vita lontanissime sono in grado di convergere esprimendosi in competenze di settore molto esclusive. I fatti sono in qualche misura veri, ma la manipolazione filmica testimonia con ulteriore chiarezza convinzioni che ci sono assai care. L’intelligenza non è univoca, al contrario si presenta in abiti sempre diversi a svolgere ruoli che sfuggono a qualsiasi pianificazione e gli impedimenti possono addirittura diventare occasione per affinarne l’efficacia. Da qui l’incoraggiante corollario: le potenzialità della nostra mente possono essere tali da superare traumi e condizionamenti culturali.
Tutto è lecito per salvaguardare quel tratto della nostra persona che più di ogni altro ci individua e ci colloca nella babele dei significati.
CONCLUSIONE
I film che abbiamo suggerito sono tutti di ambientazione anglosassone e l’elenco potrebbe essere ancora lungo. Ma vorremmo concludere con The Man Who Knew Infinity (L’uomo che vide l’infinito 2015) di Matt Brown che narra la storia dello scienziato indiano Srinivasa Ramanujan che muore giovane prima di avere espresso fino in fondo tutte le potenzialità della sua ricerca. Quando ancora ragazzo di belle speranze riesce a lasciare l’India colonizzata dagli inglesi, ottiene l’ammissione all’università di Cambridge dimostrando di possedere tutte le capacità richieste. Ma le difficoltà che incontra sono di diversa natura: preconcetti raziali e classisti, dissonante concezione della vita e della politica (l’Inghilterra sta per entrare in guerra), ma soprattutto la sua non è una preparazione accademica e gli schemi cognitivi collaudati dai professori di Cambridge non sono tali da riconoscere procedimenti mentali diversi. Era l’inizio del XX secolo.
Anche l’intelligenza ha le sue convenzioni e a volte anche le menti più brillanti si obnubilano davanti a percorsi di indagine sconosciuti, ma non per questo meno efficaci.
Per noi creature del XXI secolo che abitiamo il villaggio globale e vantiamo millenni di speculazione, essere in grado di riconoscere le diversità culturali che implicano l’uso di procedure e codici diversi, dovrebbe essere acquisizione scontata, dovrebbe…
Ma forse qualche antico trauma ancora frena la piena espressione della nostra intelligenza.