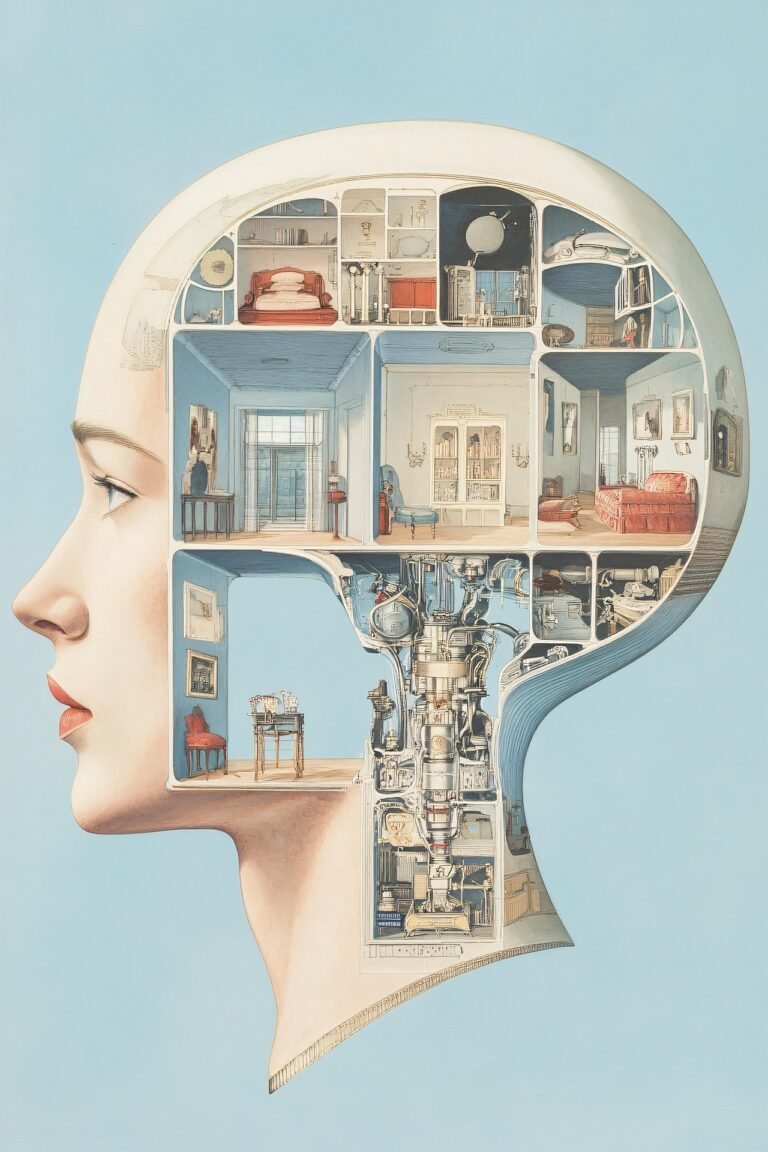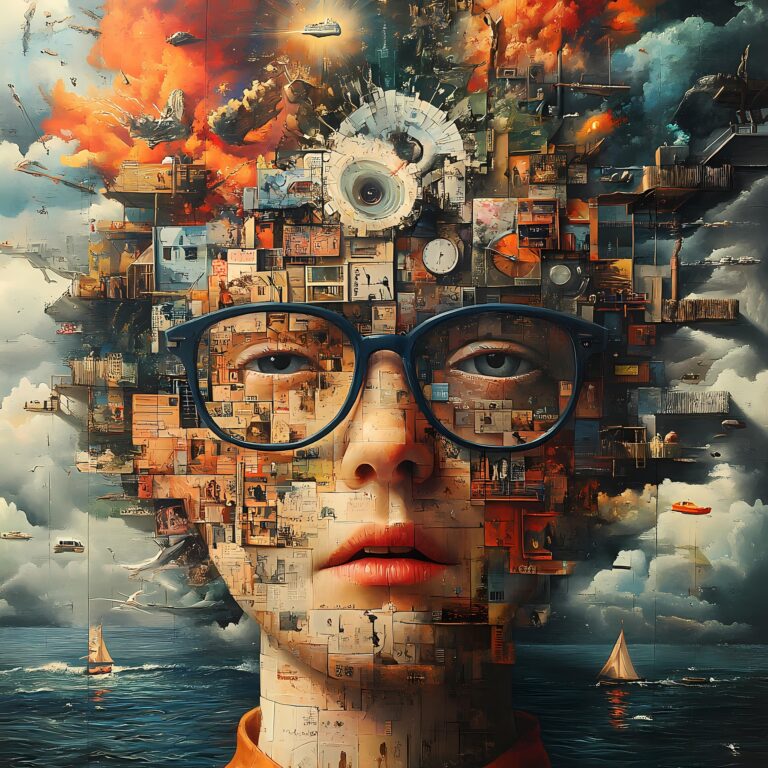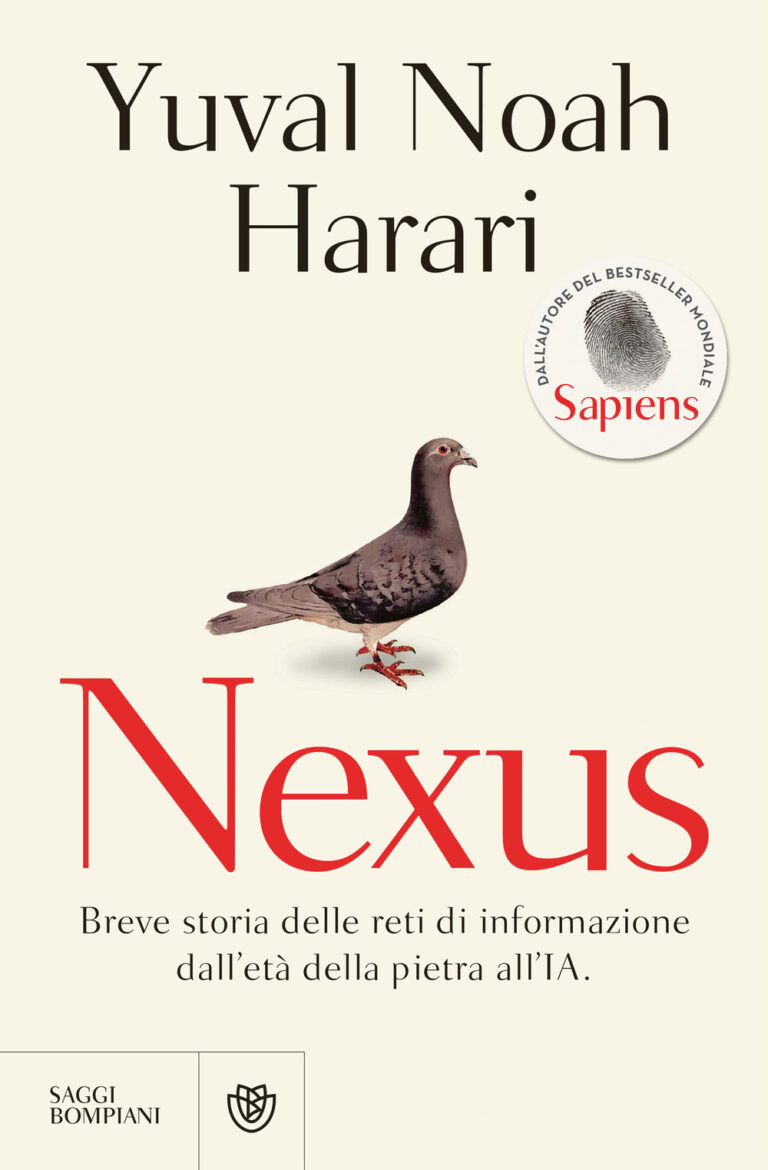ORFEO:
È andata così. Salivamo il sentiero tra il bosco delle ombre. Erano già lontani Cocito, lo Stige, la barca, i lamenti. S’intravvedeva sulle foglie il barlume del cielo. Mi sentivo alle spalle il fruscìo del suo passo. Ma io ero ancora laggiù e avevo addosso quel freddo. Pensavo che un giorno avrei dovuto tornarci, che ciò ch’è stato sarà ancora. Pensavo alla vita con lei, com’era prima; che un’altra volta sarebbe finita. Ciò ch’è stato sarà. Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo traversato e che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere ancora? Ci pensai, e intravvidi il barlume del giorno. Allora dissi “Sia finita” e mi voltai. Euridice scomparve come si spegne una candela[1].
Alcuni personaggi della letteratura di tutti i tempi lasciano una scia di fascino indistruttibile, forse perché, secondo una delle caratteristiche attribuite da Italo Calvino ai classici “non hanno mai finito di dire quel che hanno da dire”.
In particolare, si prestano ad un’intelligenza (intus legere, leggervi dentro) di tempo in tempo diversa e sfaccettata, in cui si condensano le istanze le passioni le culture che con loro si confrontano, quasi indipendentemente dal loro “creatore”.
Ulisse o Amleto, insomma, o don Chisciotte o Madame Bovary, esprimono i cammini di espressione e comprensione della vita di generazioni umane nella storia: a prescindere da chi per primo quei personaggi se li è inventati.
“Capire” le loro storie diventa un’operazione, quindi, che mette in campo memoria, idee, modi di sentire e conoscenze individuali e collettive. E soprattutto mette in campo il “come” si prende la vita, che cosa si ritiene indispensabile per uno stare al mondo consapevole e qualitativamente difendibile, che ci porti a riconoscerci in esempi di un vivere capace di sfidare la precarietà, la fluidità del tempo e delle memorie, la morte.
“e aver piegato l’Ade con il canto…” : il verso di una poesia di Fiorenza Mormile[2] concentra ai nostri giorni in un’azione, intelligente e appassionata, le qualità di un mito senza tempo, la figura di Orfeo, che riesce a trascinare fuori dall’Ade la sua amata Euridice, dopo che il suo canto, la sua musica, la sua arte è riuscita a toccare il cuore e le emozioni anche ai signori degli Inferi[3]. Poi però, sembrerebbe in maniera poco intelligente, rompe le regole che gli prescrivono di non girarsi a guardarla per tutta la risalita dall’Ade. E la perde, di nuovo e per sempre. Virgilio ci dice che in lui in quel momento ha prevalso il furor, la passione d’amore che non controlla l’istinto e sopraffà l’approccio sapiente legato all’intelligenza capace di autoregolarsi. Ma la domanda – che travalica la vicenda affascinante del personaggio (peraltro plurirappresentata nelle arti, dalla letteratura alla pittura alla musica) – di perché Orfeo si sia voltato, ha attraversato i secoli e interrogato generazioni: davvero l’amore e il canto sono più forti della morte?
E allora come possono essere annientati da un gesto di leggerezza e sconsideratezza?
E quindi, in ultima analisi, di stoltezza e scarsa lungimiranza?
Cesare Pavese, nel 1947, intende rispondere a questa domanda in quelle deliziose conversazioni immaginarie tra personaggi del mito, con cui si propongono letture moderne e attuali delle storie destinate a parlarci in ogni tempo. Pavese ci dà un’altra versione della storia di Orfeo: che in realtà, proprio per estrema intelligenza del senso ultimo dell’esistenza, si è voltato. Che senso avrebbe avuto riavere con sé Euridice per poi perderla di nuovo e provare – solo rinviato nel tempo – quello stesso dolore che ha provato al momento in cui lei è scomparsa nel mondo dell’Ade? E’sensato e coraggioso accettare la propria e altrui condizione, senza illusioni o abbagli. Il ritorno alla vita non è possibile dopo la morte, e capirlo e accettarlo rende degni di appartenere alla condizione umana. Compresa nella pienezza, complessità e contraddittorietà della sua dimensione.
La presenza di Euridice rimane nel canto di Orfeo, che esprime il dolore dell’assenza e la fedeltà senza tempo all’amore; persino quando la vita di Orfeo – ci racconta Ovidio – si interrompe violentemente, e il suo corpo viene fatto a pezzi, la sua testa trasportata dal mare resta, e con essa l’intramontabilità del canto. La mente e il cuore, l’intelligenza e l’amore insieme, segnano il destino intramontabile dell’appartenenza all’umano, dentro la vita e la storia, dentro e oltre il tempo. Attraverso la poesia e il canto, capaci di ammaliare e stregare chi ascolta, persino i signori della morte.
Potere raccontare e poter leggere, poter cantare e suonare rende umani anche in un contesto che voglia annientare l’umanità. Ce lo ricorda, in uno dei momenti più cupi della storia dell’Occidente, anche un altro grande personaggio mitico, il simbolo delle intelligenze umane necessarie a vivere e capaci di diventare artefici del proprio e altrui destino: Ulisse, l’eroe dai molti volti e dalle molte qualità “intelligenti”, che attraversa il mare della nostra memoria collettiva così come Orfeo e il suo canto attraversano il Mediterraneo per non spegnerne la continuità e la potenza.
In un capitolo del romanzo di Primo Levi Se questo è un uomo[4], compare un Ulisse, quello raccontato da Dante nel canto XXVI dell’Inferno.
Dentro l’orrore e la fatica della condizione quotidiana del campo di Aushwitz, il protagonista narra del suo incontro con Jean, uno studente alsaziano compagno di prigionia di Levi a cui i Tedeschi hanno affidato l’incarico di “Pikolo”, un “fattorino-scritturale , addetto alla pulizia della baracca, alle consegne degli attrezzi, alla lavatura delle gamelle, alla contabilità delle ore di lavoro del Kommando”[5] ossia di trasportatore del rancio agli internati”. Un giorno che sceglie lui, Primo, come aiutante nella distribuzione del rancio, gli chiede di insegnargli l’italiano. E Primo – contento di farlo – comincia, nel percorso di un’ora che porta dalla cisterna interrata alle cucine, proprio dal canto di Ulisse della Commedia. Quello gli è venuto in mente e di quello parla, il suo amico capirà: “non abbiamo tempo di scegliere, quest’ora già non è più un’ora”
Traducendo nella lingua del suo compagno, il francese, Primo utilizza il personaggio di Ulisse per far leva sul senso di appartenenza all’umano, sull’intelligenza audace e duttile che sia capace di affrontare la logica dello sterminio nazista che ogni briciola di umano cerca di annientare, riducendo uomini e donne a un numero di matricola, violentando ogni dignità. I ricordi, la memoria, aiutino allora a ritrovare sé stessi, a fare affiorare potente il senso di appartenenza all’umano, che nessun malvagio potere di distruzione può davvero cancellare. L’invito di Ulisse[6] ai compagni della “compagnia picciola” della sua nave, in Dante, è fatto poco prima di sparire nell’essere tutti inghiottiti dal mare, oltre i confini del mondo fino ad allora conosciuto; ma conta, quell’invito, anzi è determinante, ci dice Levi, per la qualità della vita di ogni uomo, anche e soprattutto poco prima di essere inghiottiti, quotidianamente, in quell’abisso di folle disumanità di chi progetta e attua la logica dello sterminio ad Aushwitz.
“…Ma misi me per l’alto mare aperto.
“Di questo sì, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere perché “misi me” non è “je me mis”, è molto più forte e più audace, è un vincolo infranto, è scagliare sé stessi al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo impulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è quando l’orizzonte si chiude su sé stesso, libero diritto e semplice, e non c’è ormai che odore di mare: dolci cose ferocemente lontane. […] «Mare aperto». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: «quella compagna Picciola, dalla qual non fui diserto», ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, sono costretto a raccontarlo in prosa: un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi: … Acciò che l’uom più oltre non si metta. «Si metta»: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, « e misi me»”[…] Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca :
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.”
Intelligenza e consapevolezza, passione della conoscenza, capacità di trasmetterla ai propri compagni di navigazione, oltre “le colonne d’Ercole” , i limiti stabiliti dalle norme, dalle convenzioni, dalle ideologie o dalle religioni: questo, anche questo, è stato – già nel racconto di Dante e sicuramente nelle sue innumerevoli riletture nelle arti e nella storia – il personaggio di Ulisse.
Ecco perché, nella lettura del canto XXVI dell’Inferno, da sempre prevale, nei tempi e nelle generazioni successive, una grande empatia con il personaggio di Ulisse, modello senza tempo dell’instancabile volontà di comprendere, esplorare, dominare e discernere la realtà. Il personaggio si è incarnato nei tanti Ulissi che nei secoli hanno preso la sua voce, dall’eroe “bello di fama e di sventura” della poesia di Ugo Foscolo[7], ai versi di Umberto Saba[8]:
“Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore“
In secondo piano, e a volte quasi in sordina, o persino con l’accusa velata a Dante di giudizio anacronistico e moralistico – giudizio “figlio”, presunto, di un Medioevo poco lungimirante – risulta, nella lettura, quella collocazione del personaggio tra le anime dei dannati, nello specifico tra i “consiglieri fraudolenti”. A Ulisse, insomma, va immediatamente e subito tutta la simpatia del lettore contemporaneo della Commedia, nel focalizzarsi sull’ascolto della storia del personaggio, campione dell’umanità consapevole, acuta, instancabilmente dedita alla ricerca del senso dell’esistere. Peccato, però, che Dante non lo abbia messo tra i beati!
Eppure l’aspetto per cui, nell’architettura della Commedia, Ulisse è collocato nelle zone più basse dell’Inferno, riguarda un tema su cui, in termini moderni, secondo le motivazioni profonde del vivere oggi, e dunque al di fuori di una logica di colpe e meriti, è giusto e sacrosanto riflettere.
Esempio indiscusso dell’intelligenza come qualità sfaccettata e complessa dell’essere umano nel suo adattarsi alla vita, Ulisse quell’intelligenza ha utilizzato per ingannare, per violare persino le regole della guerra, per combattere e far combattere con un mezzo sleale pur di ottenere la vittoria. Ulisse è punito nell’Inferno per l’idea del cavallo di legno, strumento subdolo di cui i Troiani – che pure sono i nemici – divengono vittima. E’ come se Dante ci dicesse che anche le guerre devono essere combattute con lealtà, a viso aperto.
Facendo un grande salto di spazi e tempi, l’argomento ci suggerisce che la capacità di trovare soluzioni al vivere assieme e, più in generale, di esplorare i confini della scienza, di conquistare ad essa nuovi spazi di azione e di manovra è di per sé fascinosamente insita nelle capacità umane; ma richiede, più che mai oggi, di accompagnarsi a scelte morali, a un’etica che alla mente sappia far corrispondere il cuore, al capire e scoprire sappia unire il senso dell’appartenenza comune ad una realtà che ci comprende e ci travalica; e che soprattutto sappia imporre che il bene collettivo, la qualità della vita di tutti, sia sprone e anche limite ad ogni agire. Già Dante attribuisce a Dio l’unione inscindibile di “intelletto e amore”. Secondo la filosofia aristotelica, infatti, la visione di Dio nel XXXIII canto del Paradiso, l’ultimo della Commedia, è un movimento dinamico, una “circulazione” di intelligenza, sapienza e amore
“O luce etterna che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi![9]“
E l’essere umano, fatto ad immagine del Creatore, per realizzare la vita in pienezza deve poter somigliare a chi lo ha creato, perché essere figli nel linguaggio biblico è somigliare ai padri nei comportamenti. E dunque a quell’essenza di inscindibile unione tra sapienza e amore.
Detto oggi con parole nostre, si potrebbe ricordare la necessità che l’intelligenza del singolo, per brillare davvero, persino ai fini della propria personale riuscita, debba non essere scissa da un’etica alta, che abbia la logica della condivisione e del servizio agli altri come scopo, che lavori per il bene comune e la costruzione combattendo le distruzioni e le violenze e inventando vie di pace in un mondo di guerre. Cercare e trovare strade perché l’umanità tutta si salvi, insieme all’ambiente con cui è in simbiosi, questa potrebbe oggi essere la ricerca da “osare”, le colonne d’Ercole da sfidare, il “volare alto” che è chiesto in ogni tempo agli umani che portano dentro la scintilla del divino.
Ulisse rappresenta l’intelligenza e la mente libera dell’uomo , all’inizio del Novecento, oltre che in altre opere letterarie, anche in un poema che, impresa di scrittura originale e monumentale, racconta il seguito della sua vicenda e di quella dell’uomo contemporaneo, sempre alla ricerca di nuove visioni per la salvezza del mondo : si tratta di un’Odissea[10] che si presenta come ambiziosa continuazione della prima, raccontata dal poeta cretese Nikos Kazantakis, con riferimenti alla contemporaneità riecheggiati anche nelle voci, anche lessicali, che mescolano il greco moderno con tanti termini popolari antichi rimasti solo nella lingua parlata e a rischio di estinzione, e vengono raccolti dalla bocca di pastori, contadini pescatori ed abitanti anche non acculturati di villaggi e isole del Mare Egeo.
Durante i “marosi” della pandemia, proprio quel poema rilegge lo scrittore Erri De Luca, che, in un articolo recente[11] incontra– attualizzata e anche inattuale – la figura di Ulisse, e dei suoi viaggi, nell’Odissea di Kazantakis: un Ulisse che può diventare, sparso per i nostri mari poco accoglienti, tutti i poveri Ulissi , se solo qualcuno ne scrivesse la storia, il poema.
“Leggo l’Odissea di Nikos Kazantzakis, vasto poema sui viaggi di Ulisse, immaginati dopo il rientro a Itaca. Salpa su un legno insieme a una ciurma di marinai disposti a seguirlo in capo al mondo. È un’opera grandiosa scritta nella prima metà del 1900. Conta 33.333 versi, numero ottenuto con il doloroso taglio di circa diecimila versi. Alcuni poeti si infliggono mutilazioni. L’Ulisse di Dante viaggia verso occidente, supera Gibilterra e si perde nell’Oceano. Kazantzakis lo indirizza a sud, in Africa, a risalire il Nilo e proseguire oltre. Le restrizioni dell’epidemia mi hanno istigato a letture solenni. Scandiscono il tempo a ritmo di fasi lunari. L’Ulisse di Kazantzakis è inattuale. Siamo contemporanei di viaggiatori scaraventati a catapulta fuori dalle patrie, perseguitati da sbarramenti accaniti. Le miriadi arrivano al Mediterraneo, ultima salita, Ulisse lo lascia alle spalle. Opposto ai profughi, viaggia per non fermarsi. Da lettore ammiro Ulisse, Sindbad, Marco Polo, Chisciotte. Da cittadino invece ho sentimenti di fraternità per chi nel viaggio è stato trascinato dalle forze maggiori che lanciano le vite allo sbaraglio, come semi su un campo, che attecchiscano o no. Ulisse ha un nome conficcato nei poemi, gli altri hanno perso il loro nelle fosse comuni. Da lettore aspetto chi scriva il poema delle loro Odissee”
L’intelligenza e la passione guidano comunque, in qualsiasi condizione di qualsiasi Ulisse, il viaggio della vita, attraverso i mari che riconducono a Itaca. Anche e soprattutto questo esprime la poesia di Costantino Kavafis[12], con la quale mi piace congedarmi da questo disordinato ventaglio di ritratti di un personaggio, capace , oltre recinti di categorie, tempi e spazi e fuori da interpretazioni univoche, per loro natura fuorvianti nell’approccio ad un personaggio della letteratura, di attraversare, anche oggi, ogni nostro “mare” di esistenza:
“Se ti metti in viaggio per Itaca
augurati che sia lunga la via,
piena di conoscenze e d’avventure.
Non temere Lestrigoni e Ciclopi
o Posidone incollerito:
nulla di questo troverai per via
se tieni alto il pensiero, se un’emozione
eletta ti tocca l’anima e il corpo.
Non incontrerai Lestrigoni e Ciclopi,
e neppure il feroce Posidone,
se non li porti dentro, in cuore,
se non è il cuore a alzarteli davanti.
Augurati che sia lunga la via.
Che siano molte le mattine estive
in cui felice e con soddisfazione
entri in porti mai visti prima;
fa’ scalo negli empori dei Fenici
e acquista belle mercanzie,
coralli e madreperle, ebani e ambre,
e ogni sorta d’aromi voluttuosi,
quanti più aromi voluttuosi puoi;
e va’ in molte città d’Egitto,
a imparare, imparare dai sapienti.
Tienila sempre in mente, Itaca.
La tua meta è approdare là.
Ma non far fretta al tuo viaggio.
Meglio che duri molti anni;
e che ormai vecchio attracchi all’isola,
ricco di ciò che guadagnasti per la via,
senza aspettarti da Itaca ricchezze.
Itaca ti ha donato il bel viaggio.
Non saresti partito senza lei.
Nulla di più ha da darti.
E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso.
Sei diventato così esperto e saggio,
e avrai capito che vuol dire Itaca”.
NOTE
[1] Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, L’inconsolabile, Torino 1947
[2] Fiorenza Mormile, Vizietto Orfico, in Le calibrate spine, Roma 1999
[3] La vicenda di Orfeo è narrata, in età augustea, da Virgilio nel IV libro delle Georgiche e da Ovidio nel X Libro delle Metamorfosi
[4] Primo Levi, Se questo è un uomo, Torino 1947
[5] Primo Levi, Se questo è un uomo, Torino 1947
[7] Ugo Foscolo, A Zacinto
[8] Umberto Saba, Ulisse, in Mediterranee, Torino Einaudi 1948
[9] Dante, Paradiso XXXIII, vv124-26
[10] Nikos Kazantakis, Odissea, trad. di N. Crocetti, Milano Crocetti 2023
[11] Erri De Luca, Ulisse e gli altri, in «Avvenire» del 20.09.2024
[12] Costantino Kavafis, Itaca, in Poesie scelte, trad. N.Crocetti, Milano Crocetti 2020