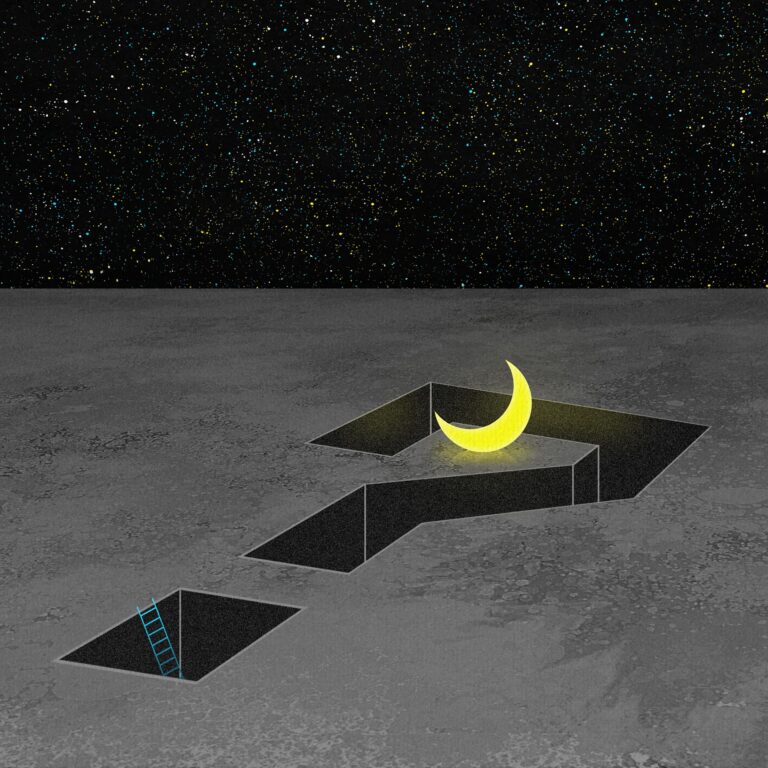IL CIBO COME STRUMENTO DI ‘NORMALIZZAZIONE’, RIBELLIONE, ASTENSIONE
Anche per chi non avesse l’abitudine alle pratiche carcerarie, è cosa nota che la questione del vitto, in ambito detentivo, è cruciale soprattutto per chi trascorre lunghi periodi in carcere: cinema e letteratura evidenziano come, nella storia degli Istituti Penitenziari, il vitto scadente o insufficiente possa diventare un potente detonatore per dare avvio a rivolte ed innalzare barricate, innestandosi su insoddisfazioni già presenti e pronte ad esplodere, in un misto di rabbia e impotenza repressa, quando vengano superati i livelli minimi di accettabilità nell’erogazione ed offerta del cibo quotidiano.
D’altra parte, nella gestione del vitto in carcere, oltre alle possibili, insorgenti complicazioni legate a risvolti igienico-sanitari ed economici, può farsi strada, consciamente o inconsciamente, l’aspetto del controllo sul corpo dei detenuti, come è stato ben evidenziato nella riflessione filosofica di Michel Foucault[1] relativa alla normalizzazione di chi viene considerato ‘deviante’ e si trova all’interno di istituzioni totali[2], prima fra tutte il carcere.
Com’è noto, infatti, secondo Foucault, la sistematica imposizione di rigide regole disciplinari di comportamento, a livello sociale e in particolare negli approcci alla popolazione detenuta, attraverso le tecniche di oggettivazione dei corpi e assoggettamento alla norma, è volta a creare e ridurre alla ‘normalizzazione’ gli individui ed a standardizzarne i comportamenti. Questo coinvolge, da sempre, non solo chi ha commesso reati ma anche molte persone portatrici di semplici anomalie o divergenze di pensiero con i conseguenti atteggiamenti etici e comportamentali.
Nella storia, dai tempi antichi fino ai giorni nostri, alla sanzione della privazione della libertà, erogata in base al codice penale a chi abbia commesso un reato, vengono spesso ad accostarsi, di fatto – non sempre in presenza di una volontà precisa – anche ‘pene’ e disagi non necessari ed aggiuntivi, cosicché le detenute e i detenuti si trovano costantemente in stato di soggezione, esposti al controllo e – spiace dire – in molti casi all’arbitrio, di chi ha il potere di decidere per loro dove stare, cosa fare e, ça va sans dire, cosa e quanto mangiare.
Ovviamente l’Ordinamento Penitenziario[3] in vigore nel nostro Paese prevede tutt’altro in materia di alimentazione carceraria, e indica anzi la tutela di precisi diritti, come da Costituzione e da Convenzioni internazionali, ma il monito foucaultiano, che evoca la difficoltà di mantenere un equilibrio tra sorvegliare e punire, tra ordine, controllo e, aggiungeremmo oggi, (ri)educazione ed approccio riabilitativo, è sostenuto da un atavico bisogno sociale, che caratterizza in particolare le già citate istituzioni totali – e non solo – di normalizzare ed assoggettare gli individui che deviano dai percorsi regolamentari, per piegarne le volontà e a rendere corpi e menti docili e malleabili.
Questo può avvenire anche attraverso il cibo, la sua qualità e quantità, le modalità di preparazione e presentazione: ma gli strumenti scelti ed utilizzati per certi scopi non sempre e non per tutti ottengono le conseguenze e gli esiti desiderati, da qui disordini e malcontenti che possono richiedere interventi repressivi o portare a conseguenze estreme per chi si senta privato, oltre che della libertà, anche di parte della propria dignità.
L’insoddisfazione nei confronti del cibo in carcere, in questo senso, può avere diversi effetti: da un lato la lenta rassegnazione, la remissività di un corpo/mente che non riconosce più, a poco a poco il bello e il buono, e si lascia andare alla rassegnazione e all’automatismo[4], dall’altra l’esplosione della rabbia e della vendetta che può sfociare in disordini e rivolte, infine lo sciopero della fame[5], strumento, sia pur deleterio, paradossalmente di autoconservazione del sé e della propria possibilità di scelta: tre risoluzioni che si configurano come estreme, tutte da aborrire in una società civile.
Del resto secondo l’autore, per ottenere questo risultato con gli individui e con i gruppi si deve instaurare il principio di coercizione in diversi campi, uno di questi è certamente avere la possibilità di osservare e controllare anche i corpi, perché la disciplina, come detto sopra, crea ‘corpi docili’ e garantisce l’interiorizzazione dei suoi dettami, senza bisogno di imporsi con eccessiva forza.
Foucault evidenzia, fra gli altri dispositivi di controllo, il Panopticon[6] di Jeremy Bentham, che realizza nel Settecento un modello di carcere in cui ogni detenuto può essere costantemente tenuto sotto osservazione senza che veda, a sua volta, chi lo osserva, con il doppio obiettivo coercitivo e trasformativo: in questo caso, senza uso della forza, si mette in atto una modalità di soggezione che s’inserisce in un più vasto sistema di controllo generale operato dalla società, tramite le sue principali istituzioni.
Un esempio di quanto sopra detto è raccontato in un ‘classico’ della letteratura penitenziaria di tutti i tempi, The Prison community di Donald Clemmer, sorta di compendio su un penitenziario statunitense del 1936, stampato nel 1940 e ristampato nel 1958, che descrive tutti gli aspetti della vita in una comunità chiusa e le modalità per mantenere l’ordine durante i pasti.
“<…> I detenuti entrano nella sala da pranzo disposti in doppia fila e marciano ai loro posti. Si siedono immediatamente, e gli uomini che sono entrati per primi vengono serviti quando tutti gli altri hanno preso posto. una guardia accompagna ciascuna squadra di lavoro, e sono presenti diversi ufficiali. Seduto in alto rispetto alla popolazione, su un trespolo protetto da sbarre, c’è un altro ufficiale munito di lacrimogeni e armi da fuoco per il caso che scoppi una rivolta.ai detenuti non è permesso parlare durante i pasti, e la visione di 1.200 uomini che <…> stoicamente mangiano in silenzio è disturbante. I detenuti camerieri passano tra i tavoli con delle grosse pentole che sostengono per mezzo di cinghie di pelle legate intorno al collo. Versano con un mestolo i cibi più liquidi e consegnano il pane a ciascun detenuto con le mani. Tutti i cibi sono disposti sopra un unico piatto metallico, e spesso ne risulta un intruglio dall’aspetto sgradevole. Il caffè o il tè sono versati nelle tazze di latta che gli uomini portano con sé. di solito è possibile ottenere una seconda razione, anche se vige la regola che i piatti debbano essere ripuliti. la quantità del cibo è adeguata, ma la monotonia della dieta e la preparazione e presentazione poco invitanti sono causa di parecchie lamentele.”[7]
Le lamentele non sempre si trasformano in proteste o rivolte ma certo fomentano il malcontento, come si vede dal brano sopra riportato. Ovviamente anche i costi vanno tenuti in considerazione e i pasti dei detenuti sono pagati meno della metà di quelli del personale, con l’opzione di poter acquistare, per chi abbia denaro per comprarli, dei generi extra allo spaccio, il cosiddetto ‘sopravvitto’[8] dei giorni nostri.
“Il costo dei pasti per persona nel 1934 era di 11 centesimi al giorno, comparati ai 23 centesimi al giorno della mensa del personale. I costi si basano sui prezzi di mercato, perché l’azienda agricola, che opera con modalità industriali, vende i prodotti secondo i prezzi correnti. la domenica non c’è il pasto serale, ma al pranzo di mezzogiorno ogni uomo riceve un panino che può portare in cella per cena, anche lo spaccio dei detenuti vende generi alimentari per coloro che si possono permettere di comprarli, e spesso questi generi sono usati per il pasto della domenica sera.”[9]
OLTRE IL VITTO E IL SOPRAVITTO, LA TUTELA DEI DIRITII
In termini carcerari, per chi ha dimestichezza con il linguaggio e le normative penitenziarie, viene definito ‘vitto’ l’insieme degli alimenti che compongono i pasti giornalieri delle persone detenute. Come recita l’Ordinamento penitenziario, all’art.9:
“Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso. <…> La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall’amministrazione penitenziaria.” [10]
La realizzazione di tabelle vittuarie, conquista relativamente recente nella storia degli Istituti detentivi, che prevede l’alternarsi di alimenti adeguati, in base a scelte fatte da esperti nutrizionisti per assicurare una dieta sana ed equilibrata alle persone detenute, non sembra storicamente aver risolto il problema atavico del vitto in carcere.
Infatti, oltre al ricorrente emergere di speculazioni finanziarie da parte delle ditte, che spesso si assicurano gli appalti offrendo tre pasti al giorno per i detenuti da realizzarsi con due-tre euro complessivi[11], non si è certo abbattuto il triste fenomeno del sopravvitto, cioè di quel di più che i detenuti possono comprare a proprie spese (talvolta in maniera compulsiva) e che viene venduto a prezzi molto elevati all’interno del carcere, generando un circuito nocivo sia per la salute (ricerche di Antigone del 2014 parlano di un crescente fenomeno di obesità fra le detenute e i detenuti)[12] e sia per le diseguaglianze generate dalle differenti possibilità economiche delle persone in carcere.
A fronte di quanto detto sopra, ciò che appare forse ancor più grave, riflettendo sulla situazione ad un altro livello, è che la sostanziale scarsa attenzione alla qualità e quantità del cibo erogato ai detenuti[13] (ovviamente non sempre e dovunque ma purtroppo con una certa frequenza) indica, insieme ad altre disattenzioni, l’affermazione saltuaria, e non certa ed equanime, della tutela dei diritti di chi è in stato detentivo (fra cui il diritto alla salute) e di un trattamento non sempre aderente al rilievo costituzionale della dignità della persona umana.
Se già Amartya Sen[14] distingueva fra l’equità della salute e l’equità della cura, dove la prima rappresenta ‘soltanto’ la concreta disponibilità di servizi sanitari e medici adeguati per chi ne ha bisogno, ma solo la seconda realizza la ‘cura’, cioè il raggiungimento dell’obiettivo di salute e di cura della persona che esprime un’esigenza sanitaria finalizzata al proprio benessere, si potrebbe dire altrettanto per la validità delle tabelle vittuarie che, in assenza di concreta applicazione ed idoneo utilizzo dei generi alimentari in esse indicati, sufficienti in quantità ed adeguati in qualità, non attuano pienamente il dettato normativo, ma piuttosto lo enunciano, tramite un metodo e un servizio predisposti, esprimendo soltanto la possibilità che la persona detenuta mangi in maniera sana ed equilibrata: in altre parole rappresentano un’offerta formale che spesso non viene, in sostanza, attuata.
Ed emerge proprio in questi giorni, invocata a gran voce dall’attualità dei quotidiani, la concreta realtà di queste affermazioni, legate all’esito di un’indagine portata a termine dalla Guardia di Finanza in un noto Istituto Penitenziario, iniziata con l’esposto di una coraggiosa ex-Garante dei detenuti[15] – necessita qui ricordare che tante sono le persone che, in ambito penitenziario e fuori, si battono in maniera seria per i diritti psico-fisici, educativi, formativi e sanitari dei detenuti – che, avendo constatato di persona la veridicità dei motivi delle tante denunce e proteste fatte dalle detenute e dai detenuti, ha avviato un processo di trasparenza e scoperchiato un vero e proprio scandalo del vitto e del sopravvitto, risultato in mano a ditte appaltatrici senza scrupoli, che annacquavano il latte, portavano in tavola frutta, verdura e carni avariate da mesi e mesi, oltre ad avere in mano anche il controllo dello spaccio del sopravvitto.
Anche quando le procedure si svolgano in maniera corretta, la letteratura di settore (medici penitenziari, come nel brano che segue) ci comunica i limiti e le incongruenze delle tabelle vittuarie e delle mense carcerarie.
“Tuttavia ad un’attenta riflessione di ordine economico-gestionale, nonché merceologico, le tabelle in uso non sembrano rispondere ai bisogni per i quali erano state create. Nelle strutture penitenziarie la lontananza delle cucine dai reparti è già il primo fattore condizionante il consumo del cibo fornito dall’Amministrazione. A questo inconveniente inerente il gusto e le caratteristiche organolettiche, si aggiungono problemi di distribuzione del vitto (orari troppo ravvicinati) e problemi riguardanti il percorso degli alimenti fino alla sede di distribuzione e consumo. <…> Tuttavia l’ottenimento del risultato di far consumare il cibo dell’Amministrazione anziché un abnorme uso dei generi di sopravvitto, è condizionato indubbiamente non solo dal rendere il cibo dell’Amministrazione più gustoso e gradevole nonché igienicamente idoneo ma anche dal rispetto dei criteri di allestimento dei vitti <…> Tuttavia non bisogna trascurare un aspetto psico-sociale, che il ristretto, nell’atto di prepararsi i cibi all’interno della cella, ritrova parte di quell’ambito socio-familiare che le peculiari caratteristiche della pena sistematicamente gli negano.”[16]
LA RESILIENZA NSCOSTA NELLE RICETTE DI FAMIGLIA E NEI SAPORTI DELLA MEMORIA
Tanti i tentativi di soluzione sia degli aspetti più concreti e ‘primari’, legati alla salute, relativi al vitto dei detenuti, sia di quelli più specificamente psico-sociali e giuridici. Ad esempio l’introduzione della Commissione vitto[17], composta anche da detenuti, oltre che da personale dell’amministrazione, ha cercato, per quanto possibile di apporre correttivi ed aprire spiragli di mediazione, ma l’appalto dei pasti a ditte esterne, da parte del carcere, ha limitato molto le reali possibilità di incidere su cibi già acquistati.
Spesso scarseggia il personale addetto alla sanità e non sempre nelle cucine penitenziarie si trovano specifiche professionalità del settore e questo “rende il tema della dietetica in carcere un vulnus della permanenza delle persone detenute nelle carceri”[18]. Ma il tema della resilienza di chi transita e permane nelle strutture detentive (che potrebbe essere oggetto di un approfondimento della pedagogia sociale), ed il desiderio delle detenute e dei detenuti (evocato nella citazione sopra riportata) di cucinare in cella, lontano dalle grandi masse, per ritrovare sapori e atmosfere familiari, ha certamente il suo peso, di fronte alla perdita, reale o percepita tale, dell’olfatto e del gusto ed all’omologazione dei sapori [19].
Tanti i racconti e le sensazioni riportate da chi ha avuto esperienza diretta della condizione detentiva, del trattamento penitenziario e del cibo in carcere.
“Svagarti con la cucina resta uno dei pochi momenti in cui puoi esprimerti in piena autonomia e libertà. Hai il fornellino che puoi fare andare al massimo o al minimo. Puoi cucinare tutto ciò che ti lasciano comprare al sopravvitto e spaziare nella fantasia culinaria provando il piacere di far gustare i tuoi cibi anche agli altri <…> Nessuno ti dice ‘questo non va bene’, quindi sei ancora più libero di quando scrivi una lettera. <…> Che brutta parola ‘trattamento’: ti fa sentire una cosa, un prodotto, un condimento. Ed è appunto pensando a questo, al trattamento e ai condimenti, che m’è venuta in mente la ricetta di ‘sa sevada’, tipico dolce salato tanto apprezzato nell’isola in cui sono nato: la ricetta che ti indico segue rigorosamente gli ingredienti reperibili in carcere.” [20]
La creatività si esprime dunque, in molti casi, nel cercare di replicare in carcere, con i surrogati possibili e con quanto a disposizione, alcune ricette che venivano realizzate in casa, quando si era liberi, con i giusti utensili e con prodotti di qualità, oggi riprodotte con ingredienti acquistabili, adattando il sapore con spezie diverse, usando le pentole ereditate da qualche ex-detenuto o modificando leggermente la ricetta. [21]
Ma talvolta, quando un parente viene a colloquio portando con sé un cibo di ‘famiglia’ – non sempre consentito – allora si ritorna subito, proustianamente, dal profumo che emana o dal gusto inconfondibile, al ricordo di giorni felici o comunque liberi, alla casa avita, per chi ne aveva una, al mondo dell’affettività e della memoria che può, se adeguatamente coltivato, contribuire ad offrire a tutti prospettive di futuro, speranza e possibilità ancora aperte.
“Al colloquio i familiari gli portavano i cibi cucinati da casa. Quei cibi che tante volte, prima di finire recluso, aveva assaporato. Lui si struggeva al solo odore e poi, lentamente, trasognato li gustava. Ecco, sui sentieri dell’olfatto e del gusto, in questi pasti, egli tornava nella cucina della madre e dalla sua bocca uscivano memorie di quando era ragazzo e di prima ancora.” [22]
Elisabetta Colla: PhD in Scienze dell’Educazione – Funzionario della Professionalità Pedagogica.
NOTE
[1] Foucault M., Sorvegliare e Punire, Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976.
[2] Goffman E, “Asylums. Le istituzioni totali: la condizione dei malati di mente e di altri internati”, Giulio Einaudi Torino, 1968. Il grande sociologo americano annovera fra le istituzioni totali l’esercito, la scuola, gli orfanotrofi, gli ospizi, gli istituti psichiatrici e quelli penitenziari, tutti accomunati dalla ‘prisonizzazione’. Tali istituzioni sono dette ‘totali’ perché ogni attività si svolge negli stessi luoghi, sotto una medesima autorità, in mezzo ad altre persone accomunate da identica sorte, cui si richiedono le stesse cose: tutte le fasi del processo risultano strettamente correlate, imposte dall’alto e calcolate nel tempo.
[3] L.354/1975: Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
[4] “Il detenuto di oggi, infatti, crea meno problemi, non contesta, non lotta per migliorare la sua condizione, non pensa ad organizzarsi. È più propenso ad annullarsi, a farsi del male in maniera solitaria o individuale, auto-mutilandosi o togliendosi la vita.” Annino Mele, Mai, Edizioni Sensibili alle foglie, Roma, 2005, pag. 21.
[5] Nel bel saggio, La pena nei luoghi di pena: lo sciopero della fame tra protesta e rifiuto di vivere,(di Alfredo De Risio, Matteo Pio Ferrara, Annateresa Inglese, Valeria Verrastro, in: ‘Quale psicologia’, N. 3 – Settembre 2014 – Nuova Serie), scrivono gli autori: “Nel desiderio di proporre una visione dello sciopero della fame, con adesione a quello che è il suo prestarsi ad un’ottica dimostrativa, si può anzitutto precisare quanto esso non sia configurabile come un rifiuto del cibo sic et simpliciter, ma al contrario richiami ad un obiettivo a valenza sociale, come ad esempio il riconoscimento di alcuni diritti violati. Lo si è anche definito come l’«arma degli impotenti», in correlazione al fatto che sia un agito che trova vita primariamente tra i prigionieri, i detenuti e gli oppressi. <…> L’astensione dal nutrimento dunque si configura come una lotta ad armi impari per la propria dignità.” Da qui il dilemma etico dei medici se rispettare o meno questo tipo di scelta.
[6] Bentham J., Panopticon ovvero la casa di ispezione, Marsilio editori, (1983 1° ed.), 2002.
[7] Clemmer D., The Prison community, 1940, pp.110-111
[8] Per sopravvitto (art.9 L.354/75 e art.14 dpr. 230/2000) s’intende l’insieme dei generi alimentari e di conforto che possono essere acquistati dai detenuti in carcere. Secondo l’Osservatorio adulti sulle condizioni di detenzione di Antigone: “Il sopravvitto include tutti quei prodotti non forniti dall’amministrazione penitenziaria ma acquistati dalle persone detenute con propri soldi e rappresenta uno dei punti critici nel funzionamento delle carceri <…> Il detenuto infatti non è libero di acquistare i prodotti che vuole: può comperare solo quelli forniti da una determinata ditta, all’interno di una lista specifica. A questo si aggiunge un problema di prezzi: nelle strutture, i costi degli alimenti sono ben più alti di quelli che si possono trovare all’esterno e questo produce ancora più discriminazione. Di fatto l’accesso al sopravvitto viene precluso ai detenuti più poveri e si dà vita a meccanismi informali che da un lato rappresentano gesti di solidarietà, dall’altro nascondono dinamiche di potere deleterie”. In: Altreconomia, 28.12.2022, https://altreconomia.it
[9] Clemmer D., op. cit., pp.110-111
[10] Art. 9 Legge 354/75
[11] Aliprandi D., 2017. Colazione, pranzo e cena a 3,90 euro per i detenuti: per il Tar non è garantita la qualità. In: Il dubbio, 3 Novembre. Si è inoltre conclusa in questi giorni una vasta operazione della Guardia di Finanza sulle ditte appaltatrici del vitto di Rebibbia che fornivano da anni pasti scadenti a euro 2,39. Cfr. nota n.16.
[12] https://antigoneonlus.medium.com/alimentazione-e-salute-nelle-carceri-7649fb66add9
[13] Gonin D., Il corpo incarcerato, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1994. Dall’indagine epidemiologica svolta dal dott. Daniel Gonin alla fine degli anni Ottanta nelle carceri di Lione, avvenuta somministrando a circa 1000 ‘nuovi arrivati’ un questionario che indagava sui loro problemi e malesseri durante il primo anno di detenzione, emergeva che l’87% degli intervistati giudicava il cibo insoddisfacente o poco soddisfacente senza variazioni nel tempo.
[14] Sen A., 1988, Etica ed economia, Laterza, Bari.
[15] Gabriella Stramaccioni, l’ex Garante capitolina, aveva già al tempo del suo mandato evidenziato la cosa: «Era tutto vero ciò che avevo denunciato e documentato in totale solitudine e rischiando in proprio. Una situazione opaca che va avanti da anni e che nessuno ha voluto affrontare». Cfr. https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/24_giugno_15/vitto-ai-detenuti-chiesto-il-processo-per-i-vertici-della-ventura-l-accusa-e-frode-nelle-pubbliche-forniture-d6ad2c00-ae71-4da7-974c-981803f07xlk.shtml; https://www.poliziapenitenziaria.it/carceri-roma-vitto-scadente-ai-detenuti-la-ditta-fornitrice-rischia-il-processo.
[16] Abate W., Abate T., Mensa e penitenziario, in ‘Rassegna Penitenziaria e Criminologica’, Numero 1, 3 – 1988
[17] In ogni carcere è prevista una Commissione vitto, istituita con l’art.9 della citata L.354/75, e regolamentata più di recente dal DPR 230/2000 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), composta da tre detenuti scelti a sorte mensilmente in rappresentanza di tutti gli altri, integrata da un incaricato dal direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto (in genere un educatore), che ‘controlla l’applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto’, il ‘regolare andamento del servizio, dalla consegna delle derrate alimentari al controllo della qualità e quantità’ e la ‘qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto.’ Tale Commissione può presentare congiuntamente o disgiuntamente, le proprie osservazioni al direttore: purtroppo, come lamentano numerose detenute e detenuti, capitano in Commissione persone che non sanno leggere e scrivere o che non parlano l’italiano o sulla cui idoneità a denunciare eventuali anomalie del sistema si possono nutrire dubbi. Infatti per un detenuto è rischioso segnalare irregolarità su vitto e sopravvitto e sono riportati dai giornali casi di ritorsioni avvenute a causa della denuncia fatta da uno di loro su eventuali irregolarità rilevate.
[18] Intervista di Paola Ortensi a Sandro Libianchi (Responsabile Unità Operativa di medicina penitenziaria presso la Casa Circondariale Femminile Rebibbia), Alimentazione e salute viste da dentro, in NoiDonne, 5/7/2015. “Una corretta alimentazione – prosegue Libianchi – che risponda ad esigenze cliniche di numerose patologie che possono affliggere le persone detenute (uomini o donne) è una questione che si ripropone spesso, ma non sempre riesce ad avere una risposta adeguata. <…> Per ciò che attiene a scelte razziali o religiose il problema è forse più semplice perché non passa attraverso una prescrizione medica, ma attraverso eventi organizzativi tra la direzione e la cucina. Esiste pertanto il vitto per i musulmani, ecc.”
[19] “Alla pena della reclusione cui si è condannati si applicano pene accessorie che non vengono scritte nella sentenza, ma di fatto fanno parte della condanna. Una delle più gravi, se non la più grave, è il blocco delle emozioni e delle pulsioni che la detenzione provoca <…> Il carcere di fatto elimina o riduce la forza dei sensi che trasmettono emozioni <…> il gusto è come l’olfatto, i sapori si assomigliano tutti, il cibo è come se avesse un unico ‘gusto universale’, un disgustoso ‘non gusto’, Giulia, detenuta della Giudecca, In prigione finiscono anche i cinque sensi, in Vita, 26/03/2003.
[20] Mele A., Mai, Edizioni Sensibili alle Foglie, Roma, 2005, pagg. 37-38.
[21] Dutto D., Marziani M., Il gambero nero. Ricette dal carcere, DeriveApprodi, Roma, 2005. Il volume colleziona tutti i trucchi e gli adattamenti di ricette, utensili e metodi di cottura tramandati dai detenuti per riprodurre ricette familiari.
[22] Curcio R., Valentino N., Petrelli S., Nel bosco di bistorco, Edizioni Sensibili alle foglie, Roma, 1990, pag. 84.