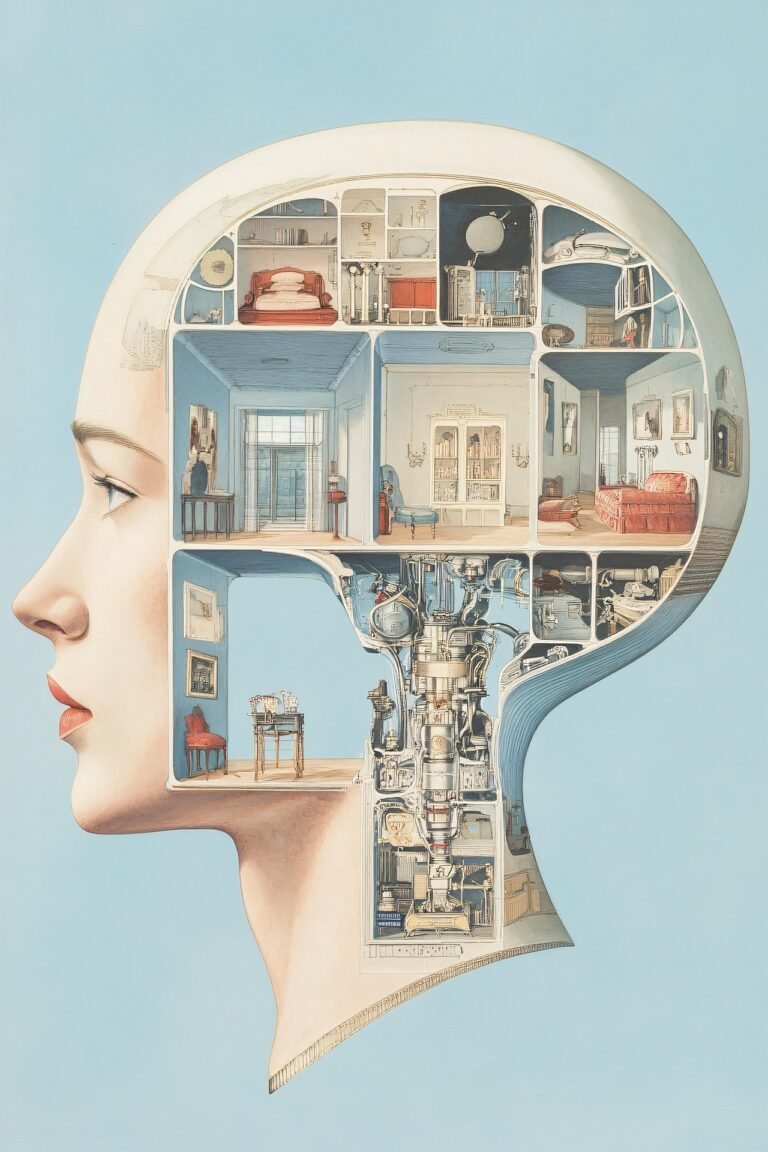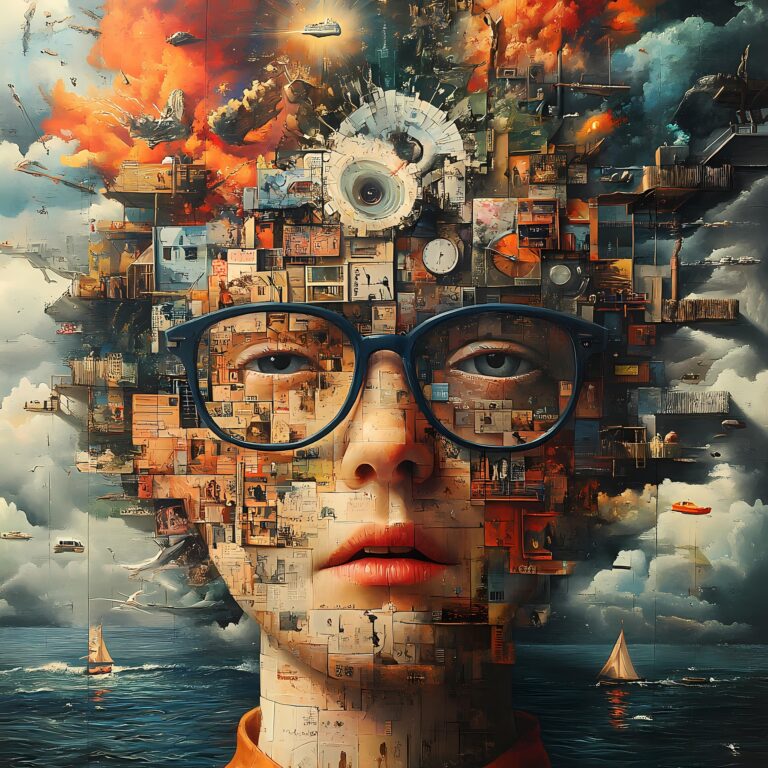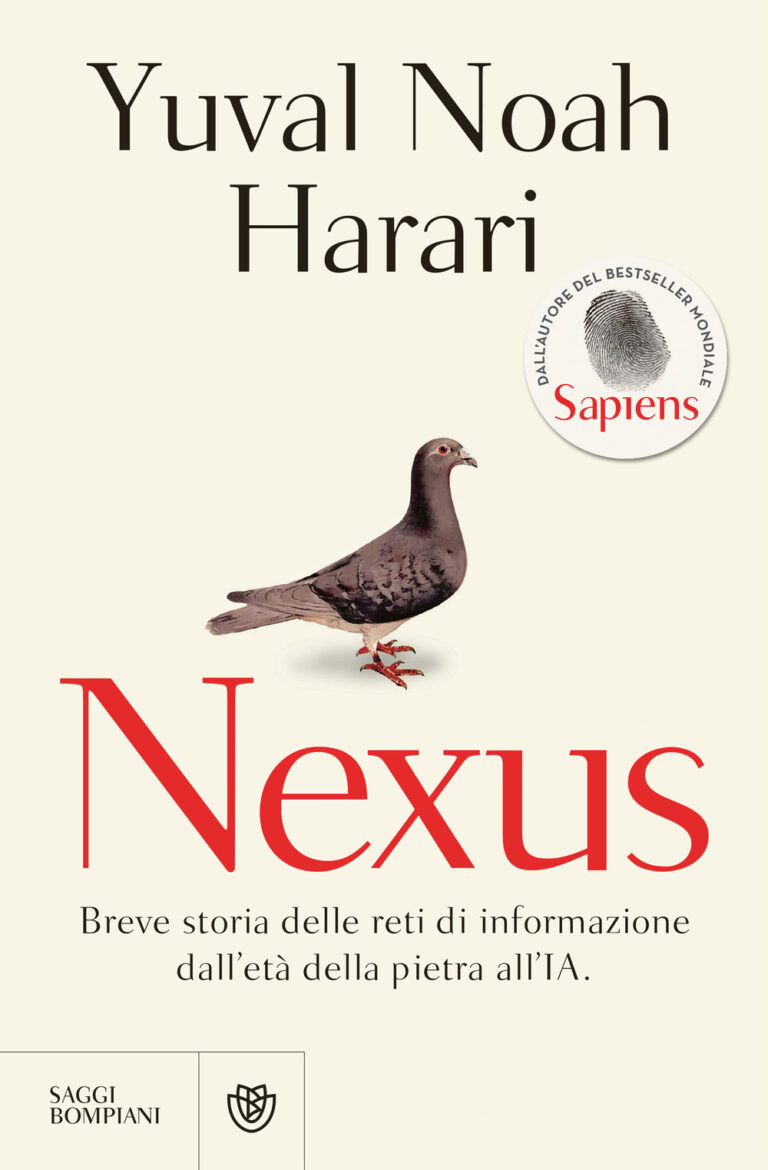“Educare l’uomo vuol dire dargli il senso della prospettiva,
il senso cioè, della gioia per le vie di domani”
A. Makarenko, Poema pedagogico
LO SCENARIO ATTUALE
Lo scenario nel quale siamo immersi è fatto di guerre, populismi identitari con il loro portato in termini di dazi e rivalità commerciali, “inversioni della globalizzazione, drammatici cambiamenti ambientali, accentuata transizione tecnologica e sociale”[1].
Non possiamo soffermarci, in questa sede, sugli effetti che rispetto alle trasformazioni delle democrazie occidentali questa fase comporta, come ad esempio nella mutazione degli assetti di un potere che sempre più sta abdicando a quella dimensione dell’equilibrio fondato sulla mediazione tra sfera giuridica, sociale e politica che aveva rappresentato il modello di democrazia rappresentativa sin dal suo sorgere con l’illuminismo.
Se pertanto la diagnosi attuale risponde a un presente globale “di uno spazio-tempo compresso ma non uniforme, interdipendente ma non euclideo, segnato da nuove (o dal ritorno di vecchie) forme di conflitto e attraversato da un campo di tensione tra gli imperativi antagonistici della mondializzazione e della sovranità, della transterritorialità dei mercati, delle tecnologie, dei flussi migratori e la persistenza (o in alcuni casi la ripresa) delle prerogative potestative e delle logiche territoriali degli Stati”[2], cosa resta delle forme e del modo di trasmettere sapere e conoscenza così come lo abbiamo ereditato dal secolo scorso?
Si tratta di un interrogativo particolarmente urgente al quale rispondere giacché nei processi di digitalizzazione in atto che riguardano ogni sfera dell’organizzazione delle forme del lavoro sempre più l’intelligenza artificiale tende a integrare e/o prendere il posto dei fattori cognitivi e decisionali prima gestiti dalla mente umana.
In questo orizzonte che peso e che senso avrà continuare ad apprendere quando una macchina potrà farlo per noi?
Proviamo a mettere ordine alle questioni sollevate finora.
Innanzitutto è bene partire dallo specificare meglio cosa si intende quando si parla di “neo-liberismo digitale”. Come ha illustrato molto bene nel suo libro la filosofa Emanuela Fornari, Cybercapitalismo, oggi ci troviamo all’interno di un processo di oltrepassamento delle forme del sistema capitalistico finora conosciuto, all’interno di una nuova costellazione in cui governano codici e linguaggi inediti, in un’indistinzione tra cose e merci che assoggetta l’intero mondo e l’intera natura al processo di valorizzazione[3]. Un simile contesto che riguarda anche la finanziarizzazione dei processi economici su scala planetaria, determina un’accelerazione dell’estrazione del plusvalore tale da generare quel fenomeno descritto, dal lato della sfera della circolazione, come “debito al consumo”[4]. L’essere umano sempre più “scomposto” in una molteplicità di sub-soggettività che rispondono ciascuna ai diversi input offerti dal mercato delle merci – ben oltre la già lungimirante diagnosi proposta da Pier Paolo Pasolini circa la società del consumo intesa come abbondanza del superfluo propria dell’ideologia edonista[5] – si posiziona su nuove configurazioni psichiche e ontologiche: un post-soggetto che “risponde alla nuova età globale neoliberale e alle sue più recenti contorsioni”[6].
Ma allora in un simile scenario cosa resta dell’unità individuo-persona?
Occorre ripartire più che mai dalla centralità della soggettività, “che facendo tesoro della storia delle sue avventure e disavventure, sia in grado di mettere in campo tutta la sua potenziale ricchezza di senso, antropomorfica e antropocentrica, per confrontarsi, accompagnandola e guidandola, con la ricchezza del mondo dell’informazione digitale”[7].
Nella società dell’illimitato accesso a una mole enorme di informazioni, vi è ancora di più la necessità di abilitare un soggetto interpretante. Infatti “stringhe, topologie e architetture spaziali di segni che lavorano secondo una sintassi di regole precise di spostamento e di calcolo non possiedono di per sé una semantica, che deve essere loro altresì assegnata dalle intenzioni e dalle utilità specifiche del programmatore che istituisce e organizza le modalità di una determinata accumulazione e elaborazione di dati”[8]. In sostanza l’informazione informatizzata non può stare da sola. Essa ha bisogno “dell’interpretazione, cioè di una attribuzione di senso, che non può derivare dal suo formalismo di regole computazionali”[9].
RESA O PROGETTUALITÀ?
Se ha ragione Hannah Arendt a sostenere che “l’essere umano è fatto per nascere, non per morire” alludendo al fatto che è la struttura ontologica dell’uomo a fornirgli quella disposizione alla costruzione-progettazione del mondo[10], ecco che allora, anche in un presente così angoscioso come quello prima descritto nel quale ci troviamo immersi, è possibile prendere congedo dalle diagnosi più apocalittiche e nichilistiche[11], per guadagnare uno sguardo capace di immaginare una nuova “apertura di senso”. In un importante e recente libro dal titolo emblematico Contro la società dell’angoscia il filosofo coreano Byung Chulhan mette in relazione quel sentimento sempre più diffuso nelle società opulente occidentali di sfiducia nei confronti del futuro e il clima politico governato da paradigmi etnocentrici che alimentano i populismi contemporanei. In sostanza nel suo ragionamento esisterebbe una simmetrica specularità tra l’atteggiamento “difensivista” che ingenera nei singoli angosce pervasive tra le più diffuse, dalla paura dell’altro al senso di minaccia permanente per ogni sorta di pericolo, climatico, batteriologico ecc., e quel ripiegamento nel privato, inteso come luogo del riparo, che caratterizza l’iper-individualismo tipico della società neoliberista.
In sostanza nel suo ragionamento “l’espandersi dell’angoscia e il crescente risentimento innescano una regressione della società nel suo insieme e, in ultima analisi, mettono in pericolo la democrazia”[12].
E ancora afferma:
L’angoscia può trasformare l’intera società in una prigione, metterla letteralmente in quarantena. Da essa provengono solo segnali di avvertimento e di pericolo. Di contro, la speranza erige, crea segni che marcano una direzione, che indicano un tracciato. Solo nella speranza noi siamo in cammino[13]
Occorre allora rimettere al centro del discorso pubblico quelle parole chiave per la costruzione dei legami sociali come speranza e fiducia e che in un suo libro intervista, uscito postumo, il grande sociologo italiano Domenico De Masi considera irrinunciabili[14].
LA SCUOLA PRESIDIO DI DEMOCRAZIA E RICOSTITUZIONE DEL LEGAME SOCIALE
Indubbiamente non vi è luogo più significativo deputato a rappresentare la fiducia nel futuro come la scuola, proprio quella scuola che nel nostro paese ha avuto una lunga storia caratterizzata dal lento processo di affermazione del principio di accesso all’istruzione per ogni essere umano indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, dal genere e dalla razza.
Si pensi all’immediato secondo dopoguerra, il quale segna, anche sul fronte scolastico, una cesura fondamentale sul piano giuridico nel senso di una sua riconfigurazione democratica dopo più di vent’anni di regime fascista. La carta costituzionale che entra in vigore nel 1948, com’è noto, rappresenta l’espressione di quella sintesi delle culture democratiche che avevano concorso alla liberazione del paese dal nazi-fascismo, la socialista e comunista e anche la cattolica riunita attorno al nuovo partito della Democrazia Cristiana.
Anche se in realtà, affinché i principi relativi alla scuola e all’istruzione sanciti dalla Costituzione, ivi compreso l’obbligo scolastico esteso fino al quattordicesimo anno di età che era l’altro richiamo espresso dall’articolo 34, trovassero una piena attuazione, sarà necessario attendere ancora diversi anni.
L’immediato dopoguerra, infatti, è caratterizzato della ricostruzione e del primo consolidamento economico di un paese che rimane ancora “prevalentemente rurale”[15]. Permane inoltre l’ordinamento “duale finalizzato alla riproduzione della stratificazione sociale esistente e alla conservazione dell’egemonia dei gruppi sociali dominanti”[16].
Diverse, altresì in quegli anni, le voci critiche che denunciavano l’assetto fortemente classista della scuola pubblica italiana. Dagli intellettuali di area PCI riuniti intorno alla rivista “Riforma della scuola”, che proprio nel dopoguerra diviene un centro di elaborazione significativo rispetto a un modello di scuola inclusiva e democratica, grazie alla riflessione portata avanti da grandi intellettuali e pedagogisti, tra cui Mario Alighiero Manacorda, Dina Bertoni Jovine, Lucio Lombardo Radice, per citare alcuni dei più noti. Per arrivare anche al celebre Movimento di Cooperazione Educativa (Mce) guidato da Aldo Pettini e Giuseppe Tamagnini, il quale si richiama esplicitamente alla pedagogia popolare di Célestin Freinet e vanta fra i suoi esponenti di spicco Mario Lodi e Bruno Ciari. Esso darà vita ad movimento che dall’interno delle scuole, grazie al sostegno guadagnato via via da moltissimi docenti, porterà un rinnovamento della didattica dal basso davvero innovativo nelle pratiche e nei metodi adottati, non senza guardare anche, come allora facevano diversi esponenti della cosiddetta “pedagogia laica”, tra i quali non possiamo non ricordare alcuni dei più noti come Ernesto Codignola, Lamberto Borghi, Aldo Visalberghi, e contrapposta anch’essa, come quella di area PCI, all’egemonia allora esercitata dal neoidealismo e dal pensiero cattolico – del resto la DC avrà a lungo il dicastero della P.I – alla tradizione dell’attivismo pedagogico e a un autore come John Dewey a lungo estromesso dal discorso educativo durante il ventennio fascista.
Occorrerà comunque attendere un diverso scenario politico e sociale perché il discorso sull’attuazione della scuola prevista dalla Costituzione si realizzi.
Sul finire degli anni Cinquanta, infatti, il quadro economico e politico dell’Italia muta profondamente, determinando anche un cambiamento degli orientamenti delle forze politiche nei confronti della scuola. Proprio il “boom economico” avvenuto tra il ’58 e il ’62, innesca rapide trasformazioni sociali che portano a ripensare la funzione della scuola in un Paese a capitalismo maturo.
Sono, inoltre, questi gli anni di grandi trasformazioni economico-sociali, quelle che cambieranno il volto del paese, il quale sostanzialmente da agrario e contadino diventa sempre più industrializzato, nonostante la questione meridionale sia ancora drammaticamente aperta, così come la piaga dell’analfabetismo. Già nel 1954 “l’inchiesta parlamentare sulla miseria e la disoccupazione” aveva documentato lo stretto intreccio fra disoccupazione e analfabetismo, denunciando come il 70% dei lavoratori italiani fossero sprovvisti della licenza elementare[17].
Il pedagogista Massimo Baldacci fa risalire a questa stagione l’inizio della fase relativa al “riformismo scolastico contraddittorio” che si protrarrà fino allo spartiacque del ’68. Esso si intreccia con le vicende che portano alla nascita del Centro-sinistra, con l’ingresso del Partito socialista nella compagine governativa.
Un simile equilibrio politico più avanzato rende possibile affrontare per la prima volta la necessità di dare finalmente corso al dettato costituzionale che sul piano scolastico, come abbiamo visto, indicava l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 14 anni.
Senza dubbio vi è da dire che l’istituzione della media unica fu un’innovazione senza precedenti che scardinava, almeno nelle intenzioni, l’assetto fortemente classista che il sistema scolastico italiano aveva ereditato dal fascismo. Con l’abolizione dell’avviamento professionale e l’innalzamento dell’obbligo scolastico “ai bambini non fu più imposto quell’orientamento precoce tra studio e lavoro che, di fatto, fino a quel momento, ne aveva subordinato la maggior parte ai condizionamenti deterministici del contesto familiare, culturale e socioeconomico di provenienza”[18].
Anche se va parimenti sottolineato come si trattò solo in parte di una vittoria per le forze laiche, quelle aderenti al cattolicesimo democratico e quelle comuniste, che intorno alla “questione del latino” avevano costruito un fronte per l’istituzione di una scuola finalmente democratica. La legge infatti istituì infine che lo si sarebbe insegnato nel secondo anno come “integrazione” dell’italiano, tornando poi facoltativo nella terza. Esso però rimase requisito fondamentale per l’accesso al liceo classico fino al 1979. Andando a sancire ancora una volta una cesura innanzitutto di classe tra scuole professionali e licei.
Sembrerebbe esserci qui un’assonanza con i nostri tempi recenti e per cui ancora una volta anche nelle parole dell’attuale ministro della pubblica istruzione la reintroduzione dello studio del latino, prospettato, addirittura, dalle sue intenzioni, fin dalle scuole elementari, sarebbe il baluardo a difesa di una scuola di qualità. Occorrerebbe chiedersi se nell’attuale contesto nel quale ci troviamo immersi e caratterizzato da una rapidissima rivoluzione digitale, un simile discorso non rischi di configurarsi come una battaglia di retroguardia, ma su questo aspetto torneremo alla fine.
Tornando invece al contesto storico politico degli anni sessanta, occorre anche ricordare come la riforma della scuola media unica si iscrive nella fase di maggiore spinta propulsiva del centro-sinistra già in crisi con il 1963-64. [19] Al principio del 1966, al varo del terzo governo Moro, era ormai evidente come la spinta riformatrice si fosse spenta. Nello specifico del caso italiano poi all’esaurirsi dell’azione di riformismo dall’alto che, sul piano strettamente scolastico, non riuscì a dare seguito ad un processo di allargamento realmente democratico come l’istituzione della legge sulla media unica avrebbe previsto, primo fra tutti una uguaglianza nelle condizioni di accesso, tramite una massiccia opera di finanziamento pubblico delle infrastrutture scolastiche che avrebbero dovuto, tra l’altro, rispondere alla tumultuosa ondata di ingressi che si verificò all’indomani dell’innalzamento dell’obbligo scolastico[20], rispose una spinta riformatrice dal basso. Essa permetterà, sull’onda d’urto prodotta dalla contestazione studentesca che presto si unisce alle rivendicazione dell’ “autunno caldo” degli operai[21], anche sul piano scolastico, nella prima parte degli anni settanta di raggiungere l’apice di quella che è stata definita la stagione delle riforme. Abbiamo così, nel volgere di uno stretto giro di anni, l’introduzione della materna statale nel 1968[22], l’istituzione del tempo pieno nel 1971, fino ad arrivare al varo delle 150 ore del 1973, ai Decreti delegati del 1974, e alla legge 517/77 sulla programmazione e la valutazione che abolisce i voti e erige un argine alla selezione nella scuola elementare.
Va detto più in generale che gli anni settanta non riuscirono a scardinare l’assetto classista della struttura scolastica italiana, come misero in luce le denunce che giungevano da esperienze di “frontiera”, dalla “Scuola di Barbiana” di Don Lorenzo Milani, alle pratiche radicali messe in campo da Albino Bernardini, Mario Lodi e Don Roberto Sardelli, solo per fare alcuni esempi tra i più celebri[23].
Del resto lo scenario geo-politico nella seconda metà degli anni settanta, muta radicalmente. In particolare, come è noto, l’avvento di un neo-conservatorismo aggressivo, capeggiato dalle politiche neoliberiste promosse da Margaret Thatcher nel Regno Unito e da Ronald Reagan negli Stati Uniti intendevano muoversi nel senso di risospingere indietro le pressioni del mondo del lavoro che avevano raggiunto traguardi contrattuali giudicati ormai insostenibili[24]. Nel loro insieme questi fenomeni costituiranno aspetti essenziali della globalizzazione, dando una forma specifica all’internazionalizzazione dell’economia, già in atto da tempo. Ebbe inizio così quel logoramento del “compromesso socialdemocratico” tra capitale e lavoro che, specie nel nostro Paese, produsse una progressiva marginalizzazione delle forze di sinistra che avevano guidato il processo di modernizzazione negli anni sessanta. Basti ricordare come nel 1979 il PCI subisce una grave emorragia di voti e il sindacato viene battuto nella vertenza della Fiat del 1980[25].
Per quanto attiene l’’interesse specifico del nostro discorso, tale mutamento del quadro sociale e politico venne a determinare ripercussioni significative sul terreno delle riforme scolastiche andando a caratterizzare quel modello di scuola funzionale al “dominio del mercato”. Si tratta di un mutamento di paradigma di cui in Europa si hanno ricadute a partire dal celebre “Rapporto Delors sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo”, promosso dall’Unesco, il quale propone un’astratta conciliazione di elementi “socialdemocratici e neoliberisti, di sviluppo umano e di produzione di capitale umano”[26], che si iscrivono totalmente nella cornice neoliberista.
Le stesse politiche formative dell’Unione Europea saranno, da lì in poi, in linea con la nuova temperie politico-culturale: da un lato il “Libro Bianco”, curato dalla Cresson (1995), mette in primo piano il problema dell’adeguamento dell’istruzione alle “dinamiche di un’economia globale basata sulla conoscenza”[27], dall’altra “la Strategia di Lisbona” (2000) indica una serie di traguardi formativi comunitari, giocati sul nuovo paradigma dell’efficienza del mercato e della valorizzazione della competizione, da raggiungere entro un decennio, per fare dell’Unione Europea una delle economie più avanzate del pianeta.
È a partire da questa mutata cornice storico sociale che, come hanno sottolineato bene molti interpreti, andrebbero rilette le riforme scolastiche avutesi negli ultimi vent’anni nel nostro paese. Senza poterci addentrare in un resoconto analitico delle stesse, giacché questo compito travalicherebbe di molto i limiti imposti a questo lavoro, quello che dobbiamo far emergere è l’idea complessiva di scuola, nonché la visione della sua funzione nella società, che si è andata affermando[28]. Nella concezione neo-liberista, infatti, la scuola si pone, innanzitutto, come “fabbrica del capitale umano”, come un’agenzia di formazione di produttori dotati dell’equipaggiamento cognitivo necessario alle aziende. Si tratta di una visione in linea con il paradigma delle “competenze” da acquisire e spendere nel mercato del lavoro, secondo il modello del neo-liberismo, a discapito di una scuola che, seguendo il dettato della carta costituzionale, era incentrato, come abbiamo ricostruito, sullo sviluppo di un indirizzo formativo unitario della persona e del pensiero critico.
Tale scenario, sempre stando all’analisi di Baldacci assolutamente condivisibile, avrebbe contribuito a mutare il senso comune diffuso, per utilizzare una categoria gramsciana, sempre più impregnato, ad ogni livello, da una subalternità culturale all’ideologia neoliberista, anche a partire da una diversa funzione attribuita al ruolo della scuola nella società, la quale sempre più schiacciata in una visione riduttiva del processo formativo, perde di vista l’importanza della formazione “globale”, mente e corpo, dell’essere umano; su questo punto potremmo rievocare una lunga tradizione del pensiero pedagogico che parte dalla antichità greco-classica e arriva alle riflessioni di Marx sull’educazione “onnilaterale”[29].
Un simile impoverimento di un bagaglio formativo “complesso” a nostro avviso risulta assolutamente controproducente in uno scenario nel quale l’ingresso massiccio delle tecnologie elettroniche nella società e nella scuola rendono l’abilitazione dei soggetti allo sviluppo di “multi-aree cognitive” della mente sempre più urgente e necessario, come del resto intuiva già qualche decennio fa il grande mass-mediologo Marshall McLuhan. In particolare in uno scritto della fine degli anni sessanta del secolo scorso, tradotto, tra l’altro, da poco in italiano dal bel lavoro di Simone di Biasio, dal titolo Education in the Electronic Age, il filosofo canadese sottolinea come la caratteristica dei nuovi media, ovviamente all’epoca prevalentemente visivi, stava determinando un processo di “ri-tribalizzazione” dei processi di apprendimento, che lungi dal riferirsi ad un giudizio etico, alludeva al fatto che l’immagine, come in altri momenti della storia dell’umanità, tornava ad essere l’ambiente di apprendimento preponderante rispetto alla scrittura[30].
Quella dimensione della “simultaneità” che lo scorrimento di immagini imprime nella mente a cui più di quaranta anni fa McLuhan faceva riferimento è oggi plasticamente rappresentata dalla velocità dello scorrimento delle informazioni scrittorie e visive insieme che attraversa le nostre vite e quelle degli studenti anche nelle aule scolastiche. Un flusso di dati che la scuola fatica a gestire nonostante più di un pedagogista rifletta da tempo su come riuscire a integrare nella didattica tradizionale le nuove tecnologie audiovisive o anche su come utilizzare e quindi gestire positivamente l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in un normale “setting d’aula”[31].
Si tratta di questioni di cruciale importanza oggi rispetto alle sfide che la scuola ha di fronte. La stessa Unione Europea già nel 2018 con il Communication Artificial Intelligence for Europe, poneva una prima disciplina sul futuro del lavoro così come sulle competenze necessarie a una simile transizione tecnico-economica con un’attenzione particolare rivolta al ruolo cruciale dei sistemi educativi e formativi[32]. Così come nel 2020 il World Economic Forum (2020) annunciava come nel volgere di pochi anni “il mercato del lavoro avrebbe richiesto nuove professioni parlando di Data Analyst e di Data Scientist, di IA e Machine Learning Specialist”; del resto “le ricerche internazionali evidenziano come le applicazioni di AI nell’industria 4.0 stiano già cambiando il modo di produrre”[33], di fatto una professione su due rischia di diventare automatizzata, così come molte cambieranno radicalmente.
In un simile scenario il ripensamento del sistema educativo e formativo dovrà essere orientato a un “approccio umano-centrico che, partendo dalle capacità dei singoli soggetti, costruisca dei percorsi formativi individuali offrendo un set di skill da aggiornare costantemente”[34]. Tra queste competenze che ciascun individuo dovrà progressivamente sviluppare trasversalmente, indipendentemente dal percorso specifico di specializzazione formativa e lavorativa, risulta particolarmente significativo il richiamo, indicato tra gli altri obiettivi necessari allo sviluppo di abilità digitali necessarie all’alfabetizzazione “consapevole” , dal Digital Education Plan (2021-2027), allo sviluppo del pensiero critico (Critical Thinking) che si basi su una reale comprensione “dei concetti di alfabetizzazione digitale e capacità di utilizzare algoritmi per costruire le proprie convinzioni”[35].
In buona sostanza l’innesto sempre più massivo dell’IA pone domande che riguardano diversi ambiti dell’essere umano: “Truth, Experience, Creativity e Intelligence[…]”[36]. Ciò condurrà ad una nuova definizione dell’intelligenza umana intesa come struttura reticolare.
Torna qui molto chiaramente il discorso prima accennato. Non si tratta di abdicare alla funzione ordinatrice della mente umana, che risulterebbe assoggettata al dispotismo esteriore di accumulo di enormi quantità di dati (algoritmi)[37]. Piuttosto occorre guardare ad una soggettività intesa come attore collettivo di rete, dotato di “capabilities per l’esercizio di una leadership strategico-progettuale diffusa”[38] e capace di apertura mentale, visione sistemica e adattativa, capacità di accogliere e valorizzare le diversità per cogliere le trasformazioni in atto.
Ciò che in conclusione di questo discorso vale la pena ricordare riguarda un apparente paradosso che attraversa la vita scolastica nel nostro paese. Di fronte a uno scenario nel quale la tecnologia fa il suo ingresso massiccio anche nelle aule scolastiche, con nuovi dispositivi elettronici, lavagne intelligenti ed altro, le indagini e i monitoraggi relativi ai dati sulla valutazione scolastica, sui successi formativi degli studenti nonché sulla durata dei percorsi scolastici stessi continuano ad essere, come una lunga letteratura sul tema ci ha consegnato da tempo, molto preoccupanti.
Il nostro paese continua, pur esibendo una disomogeneità per regioni nella distribuzione della dispersione scolastica anche questa figlia di una lunga storia, ad essere il fanalino di coda in Europa, come documentano molte indagini[39].
In un simile scenario allora occorrerebbe davvero rilanciare quella funzione “connettiva” e “etica” della scuola come luogo di socializzazione fondamentale e palestra di democrazia , per dirla con John Dewey, in cui ciascun essere umano impara a stare con gli altri, ad acquisire quell’habitus che può condurlo al di là, come direbbe Gramsci, del proprio “idiotismo”. Si tratta di una sfida oggi non più eludibile, come abbiamo visto, in uno scenario nel quale la complessità dei processi in atto richiede conoscenze, spirito critico e quell’apertura “ad apprendere” che solamente una personalità sviluppatasi in maniera “integrale” può avere l’opportunità di fare.
NOTE
[1] L. Pennacchi, “fine dell’ordine neoliberale. Ma resilienza del neoliberismo?, In “Critica Marxista. Analisi e contributi per ripensare la sinistra”, settembre-dicembre, 2024, p. 7.
[2] Giacomo Marramao, Contro il potere. Filosofia e scrittura, La nave di Teseo, Milano, 2025, p. 30.
[3] E. Fornari, Cybercapitalismo. Fine del legame sociale? , Bollati-Boringhieri, Torino, 2024, p. 11.
[4] Ibid.
[5] P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano, 2015.
[6]E. Fornari, Cybercapitalismo, cit. p.12.
[7]R. Finelli, Filosofia e tecnologia. Una via di uscita dalla mente digitale, Rosemberg& Sellier, 2022, p. 12.
[8] Ivi, p. 35.
[9] Ivi, p. 36.
[10] Cfr. A. Arendt, Vita activa. La condizione umana, tr. It., Bompiani, Milano, 2019.
[11] Mi riferisco soprattutto ad un celebre testo proposto di M. Benasayag e G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, tr. It., Feltrinelli, Milano, 2013.
[12]B. Chulhan, Contro la società dell’angoscia. Speranza e rivoluzione, tr. It., Einaudi, Torino, 2025, p. 8.
[13] Ibid.
[14] D. De Masi, Conversazioni sul futuro, Paper First, Roma, 2024.
[15] M. Galfrè, Tutti a scuola. L’istruzione nell’Italia del Novecento, Carocci, Roma, 2017.
[16] M. Baldacci, La scuola al bivio. Mercato o democrazia? Franco Angeli, Milano, 2019, p. 167.
[17] Cfr. Galfrè, Tutti a scuola, cit., pp. 120-126.
[18] A. Angelucci, G. Aragno, Le mani sulla scuola. La crisi della libertà di insegnare e di imparare, Castelvecchi, Roma, 2020, p. 94.
[19] In merito alla valutazione relativa alla stagione del centro-sinistra vedi Y. Voulgaris, L’Italia del centro-sinistra. 1960-1968Carocci,Roma, 1998 e G. Vacca, L’Italia contesa. Comunisti e democristiani nel lungo dopoguerra. 1943-1978,Venezia, Marsilio, 2018, in particolare pp. 209 e seg.).
[20] E’ stato sottolineato come anche se la crescita è evidente, il tasso di frequenza scolastica continua ad essere preoccupante per tutti gli anni sessanta: «95% alle elementari, 74% nei bambini tra gli 11 e i 14, contro il 98-99% dei principali paesi europei[..]in sostanza il salto decisivo della scolarizzazione media e superiore inizia senza che si sia consolidata quella di base né che sia stato sconfitto l’analfabetismo» (M. Galfrè, La scuola media unica, il ritardo scolastico e gli “alunni disadattati”. I primi bilanci, in A. Ascenzi, R. Sani (a cura di), Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall’Unità ad oggi, Franco Angeli, Milano, 2020 p. 253).
[21] A partire dalla seconda metà del 1968 in Italia, unico tra i paesi occidentali, si verifica l’incontro tra il movimento studentesco e le rivendicazioni portate avanti dal sindacato specie Metalmeccanico, il quale per la prima volta riunisce le diverse sigle sindacali in una organizzazione ora comune (Federazione Lavoratori Metalmeccanici-FLM). Fu proprio in forza di questo sodalizio, secondo molti storici, che furono varate alcune delle leggi più significative di tutela del lavoro nel nostro paese: furono abolite le cosiddette “gabbie salariali” che avevano creato una sperequazione retributiva e fu introdotto un contratto di lavoro unico su scala nazionale; così come, a sottolineare l’impatto esercitato dal movimento studentesco, furono approvate le 150 ore intese come permessi studio retribuiti per i lavoratori che possono essere considerate all’origine del grande programma di educazione degli adulti, che decollerà nel corso degli anni Ottanta. (Sul tema imprescindibile B. Trentin, Autunno caldo. Il secondo biennio rosso (1968-1969), Editori Riuniti, Roma, 1999; vedi anche S. Turone, Storia del sindacato in Italia dal 1943 al crollo del comunismo, Laterza, Bari, 1976).
[22]La legge sulla materna statale (‘68/444) recepisce, almeno dal punto di vista formale, la rivoluzione copernicana messa in campo dal movimento femminista basata, tra le altre istanze, anche sul superamento di genere nella divisione del lavoro di cura e sul principio dell’universalizzazione dei servizi; anche se il fatto che si continuasse a chiamarla “materna” e non “di infanzia”, come sottolineò Elena Gianini Belotti, significava che esisteva ancora, specie nell’educazione, una forte introiezione del ruolo ascritto all’universo femminile (cfr. E. Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano, 1971).
[23]Come è noto l’opera educativa di Don Milani è fortemente caratterizzata da una ripresa dei valori di uguaglianza evangelici e da una riattualizzazione delle istanze di democrazia sociale espresse nella Carta costituzionale (Cfr. Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1967). Sull’esperienza di maestro elementare di Albino Bernardini in una borgata romana: cfr. Un anno a Pietralata, La Nuova Italia, Firenze, 1968; per quanto riguarda invece la figura e l’esperienza di recupero portata avanti da Don Sardelli con i figli dei baraccati dell’Acquedotto Felice a Roma: cfr. da ultimo R. Sardelli, M. Fiorucci, Dalla parte degli ultimi, prefazione di A. Portelli, Roma, Donzelli, 2020; imprescindibile: Scuola 725, Non tacere, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1971.
[24] Cfr. P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989, pp. 280 e seg.
[26] M. Baldacci, La scuola al bivio, cit.
[27] Ibid.
[28] In questo quadro la fase della scuola neoliberista, nel nostro paese, ha iniziato a muovere i primi passi con gli anni della cosiddetta Seconda Repubblica, caratterizzati da un inedito bipolarismo e dall’alternanza dei governi. Fin dal programma elettorale di Silvio Berlusconi (1994) le famose “tre i” (impresa, internet, inglese) annunciavano un disegno di modernizzazione della scuola secondo i dettami dell’aziendalismo neo-liberista. Tale ispirazione attraversa per tutti gli anni Novanta le riforme messe in campo sia dal centro-destra sia dal centro-sinistra. Dalla autonomizzazione amministrativa degli istituti scolastici favoriti dalla riforma Bassanini(1997), alla vera e propria ristrutturazione neoliberista identificabile con i governi di centro-destra dal 2001 in poi, fino a giungere, dopo la parentesi del governo tecnico di Monti nel 2021, ai governi guidati dal Partito democratico, dove la ristrutturazione neoliberista si presenta «senza paludamenti di sorta» (M. Baldacci, La scuola al bivio, cit., p. 177) . In questo quadro, la legge 107/2015 voluta dal Governo di Matteo Renzi, ribattezzata Buona Scuola, rappresenterebbe il compiuto allineamento della concezione della scuola alle posizioni neoliberiste. La scuola stessa è vista in un’ottica prettamente funzionalista, come subordinata al sistema economico-aziendale: «deve servire alle imprese e farsi impresa essa stessa» (Ibid. Su questo aspetto vedi anche A. Angelucci, G. Aragno, Le mani sulla scuola, cit.).
[29] Mario Alighiero Manacorda ha dedicato molta parte della sua riflessione educativa a rintracciare questo nesso dell’educazione integrale dell’essere umano nel pensiero di Marx e Gramsci. Su questo aspetto da ultimo vedi. L. Silvestri, Una vita onnilaterale. La riflessione pedagogica di Mario Alighiero Manacorda (1914-2013), Milano, Unicopli, 2024.
[30] Si tratta di una conferenza che McLuhan tenne in Ontario, Canada, nel 1967, tradotta ora per la prima volta in italiano. Cfr. M. McLuhan, L’educazione nell’età elettronica, a cura di S. Di Biasio, Edizioni ETS, Pisa, 2023.
[31] Per un quadro d’insieme sulle proposte didattiche nonché sulle questioni di ordine etico e formativo che l’ingresso dell’IA nelle scuole chiama in causa, sono da vedere, tra gli altri: C. Panciroli, P. Cesare Rivoltella, Pedagogia algoritmica. Per una riflessione educativa sull’Intelligenza Artificiale, Scholè, Brescia, 2023; B. Di Bello, Intelligenza Artificiale per la scuola. Un approccio umanistico all’uso didattico dell’IA generativa, Hoepli, Milano, 2023.
[32] C. Panciroli, P. Cesare Rivoltella, Pedagogia algoritmica, pp. 30-31.
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid. La rivista Europa 2028. The European Magazine, promossa dal Centro studi La Parabola ha dedicato l’ultimo numero del 2024 ad un approfondimento normativo legato alle prospettive di sviluppo future nella politica degli stati membri dell’UE sui temi dell’IA in un quadro volto mettere sempre più a sistema “la complessità delle sfide legate allo sviluppo e all’attuazione delle politiche di governance dell’ IA, quali la protezione dei diritti fondamentali, la gestione dei rischi etici e la promozione dell’innovazione responsabile”, in un quadro di necessario coordinamento e collaborazione tra gli stati membri, così come indicato anche dai Programmi Horizon Europe e Digital Europe (cfr. ivi, pp. 152-54).
[36] Artificiale per la scuola. Un approccio umanistico all’uso didattico dell’IA generativa, Hoepli, Milano, 2023.
[36] C. Panciroli, P. Cesare Rivoltella, Pedagogia algoritmica, p.34.
[37] R. Finelli, Filosofia e tecnologia, cit.
[38] Ibid.
[39] Basta scorrere alcuni numeri e ricerche. A partire da quella offerta dall’economista, nonché direttore della Fondazione Giovanni Agnelli, Andrea Gavosto, non sempre condivisibile nelle sue ricette, ma la cui analisi ha il pregio di offrirci uno sguardo davvero impietoso sul nostro paese in merito a risorse impiegata nel campo dell’istruzione. L’Italia, spiega, è in ritardo a partire dalle scarse risorse economiche (investimento del 3,8% del Prodotto interno lordo contro la media del 4,5% dei Paesi avanzati). Così come è del 3% il numero degli studenti che non finisce la scuola superiore, soprattutto nelle regioni del sud dove questo dato tende a impennarsi (cfr. A. Gavosto, La scuola bloccata, Laterza, Bari, 2022).Per un ulteriore aggiornamento dei dati sulla dispersione scolastica nell’ultimo biennio: Report- Istat. Livelli di istruzione e ritorni occupazionali, 2023. Il report oltre a mettere in luce come nonostante un leggero trend di crescita, il nostro paese continua ad avere uno dei più bassi di conseguimento del titolo superiore di studio: 35,1% ed è circa la metà di quella registrata in Francia e Spagna 42,4% e 41,4% rispettivamente, evidenzia un ulteriore ritardo competitivo del mezzogiorno rispetto al centro-nord: nella popolazione (25-64 anni) il 39,6% ha un titolo secondario superiore e solo il 18,1% ha raggiunto un titolo terziario; nel Nord e nel Centro la quota dei diplomati supera il 45% (rispettivamente il 46,5% e il 45,2%) e quella dei laureati il 22% (22,4% e 25,6%) (cfr. www.istat/report Livelli di istruzione e ritorni occupazionali, 2023).