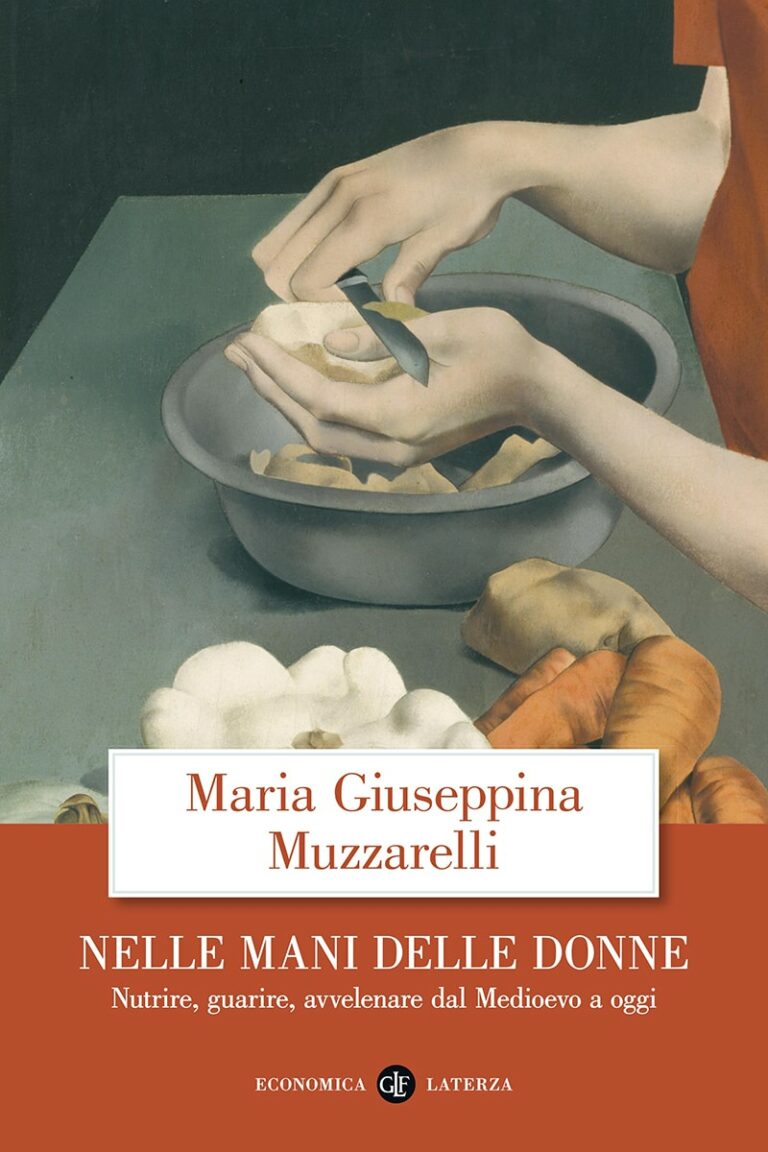Nell’articolo precedente sono partito da una celebre espressione di Feuerbach: «L’uomo è ciò che mangia», una massima che ci offre un dato antropologico di base, che la civilizzazione ci fa dimenticare, e ci dice anche, più implicitamente, che il cibo va considerato in rapporto al quel vivente particolare che lo consuma, che lo mangia. Qual è questa dimensione primordiale che ci caratterizza?
Nel mito greco delle origini c’è un tempo prima del tempo, un’età dell’oro, quando dèi e uomini non erano ancora separati, prima che si scatenasse la lotta fra Crono e i Titani da una parte, e Zeus e gli Olimpici dall’altra, quando ancora il mondo non era in balia della violenza pura e semplice. Una volta conclusa la prima spartizione (con la cacciata dei Titani ad opera degli Olimpici) Zeus si trova a dover ripartire sorti e onori fra gli dèi e gli uomini, e per trovare una soluzione dà l’incarico al Titano Prometeo[1]. Quello che alla fine risulterà è che gli umani potranno entrare in contatto con la divinità solo attraverso il sacrificio (come quello compiuto da Prometeo macellando l’animale) e che, nella spartizione delle due parti della bestia fra dèi e uomini, a quest’ultimi Prometeo farà riservare la parte migliore del sacrificio, quella commestibile. Ma questo privilegio conterrà un carattere di ambiguità che segnerà tutta la differenza di condizione fra uomini e dèi. Ricevere le parti commestibili della bestia sacrificata significherà per gli umani (d’ora in poi i mortali) aver bisogno di mangiare: essi non possono vivere senza nutrirsi di continuo, altrimenti deperirebbero. Ciò che definisce gli umani è infatti proprio la necessità di mangiare il pane e la carne dei sacrifici, e bere il vino della vigna, mentre gli dèi non ne hanno bisogno.
A partire da questa memoria (e trasmissione) ancestrale rappresentata dal mito, di questo racconto venuto dalla notte dei tempi, ho distinto tre livelli di esperienza nel nostro rapporto col cibo: un primo livello, materialistico, per il quale non esiste un’essenza umana diversa dalla materia che compone il nostro corpo, costruito proprio grazie al cibo ingerito. Siamo fatti di proteine, carboidrati, grassi, insomma del cibo che ci mantiene in vita. L’”essere”, l’oggetto filosofico per eccellenza, si rivela innanzitutto alla sensazione di ciò che altera il mio stato, nel momento in cui percepisco ciò di cui ho bisogno per la conservazione e la riproduzione della vita. La nostra prima esperienza è la fame che ci spinge a nutrirci, è quella sensazione di vuoto che ci fa fare l’esperienza concreta del pieno dell’essere reale. Il mangiare è ciò che ci riporta alla nostra dimensione antropologica originaria e che impedisce le fughe alienanti nel tentativo di trascendere la nostra condizione spesso dolorosa (è la nostra parte “divina”!). Al primo grado del nostro sviluppo siamo desiderio (Begierde) che non ha ancora alcun altro carattere che quello dell’impulso (Triebes) non ancora determinato dal pensiero, una spinta che si rivolge ad un oggetto esterno nel quale cerca soddisfazione. Pura assimilazione, fame animale: «mangio dunque sono».
Se ci distacchiamo dalla condizione che condividiamo con gli altri animali, per far sì che la nostra realtà di esseri umani si costituisca, è necessario che il nostro conatus si manifesti oltre la sola necessità biologica. Come ogni altro vivente l’essenza dell’uomo è appetitus, che però, quando ricomprende la mente, si traduce come desiderio (cupiditas), in quanto l’essere umano è conscio del suo appetito. Passando da Spinoza ad Hegel, questo significa non tanto di conoscere le cose fuori di me, ma di riconoscermi in esse (l’essere umano è “autocoscienza”). L’oggetto del fare dell’uomo è anche specchio in cui si conosce e si trasforma, e trasforma, assimilandolo, tutto ciò con cui viene in contatto. Ciò vale anche quando l’uomo mangia. Insieme al cibo l’essere umano si nutre dei simboli, del linguaggio, dei desideri, dei paesaggi emotivi, delle immagini che ad esso si legano, passando da un livello ambientale di stimoli e risposte univoche alla “culturalità” di un mondo di esperienze polivoche. La cultura può moltiplicare le diversità e dunque le forme dell’esperienza. La ricchezza, la varietà, la raffinatezza della cucina permette alla sensorialità di esprimersi e di educarsi valorizzando la differenza dei gusti, che sono il lusso indispensabile della vita. C’è un legame inscindibile tra le funzioni legate al parlare, al relazionarsi e quelle alimentari. E questo lo vediamo nell’utilizzo delle metafore (quindi linguaggio) che intrecciano il digerire della mente e il digerire dello stomaco. Nel mangiare assieme il rapporto dell’uomo con il cibo acquista una complessità maggiore dovuta alla «doppia oralità del parlare e del mangiare». Se il proprio dell’uomo risiede nel movimento di rispecchiamento in ciò con cui entra in rapporto (dal cibo al dio), allora ciò che ciascuno è, la sua identità, si costruisce specchiandosi tanto in quello che si dice, nelle parole del linguaggio che dalla bocca escono, quanto nei cibi che nella bocca entrano.
A questa dimensione, come abbiamo visto, se ne sovrappone una terza, espressione di un “noi”, un bisogno etico di convivialità, di ricomposizione delle individualità separate nell’unità impersonale, in cui il proprio si rovesci nell’improprio, l’immune nel comune. Questa esigenza si è realizzata storicamente nell’esperienza del sacro e nel fenomeno collettivo complesso della religione. Nei suoi rituali abbiamo individuato il “sacrificio” come un momento nel quale la presenza dei cibi è così essenziale che, studiando la loro trasformazione culturale, si può osservare il processo di civilizzazione delle istituzioni umane. Attraverso l’approccio critico disalienante feuerbachiano, “gastroteologico” (ricondurre al bisogno concreto la tendenza ad alienarci), abbiamo potuto cogliere nel pane e nel vino eucaristici – il corpo di Cristo (simbolizzato dall’ostia) fatto a pezzi, mangiato e il sangue bevuto – questo aspetto del noi, del bisogno di comunione, di partecipazione corale di tutti i membri della comunità. Nell’atto del mangiare quotidiano si celebra implicitamente un piccolo sacrificio poiché il figlio di Dio si offre come cibo[2]. La centralità dell’atto di mangiare nel sacrificio e la condivisione degli alimenti nel pasto comune diventano potenzialmente forieri di una società conviviale, pacificamente gioiosa e egualitaria.
Ma non ci si può fermare qua. Abbiamo bisogno di conoscere meglio la nostra natura, che rivela tratti ancestrali che solo il ricorso al mito (la «storia più lunga» la chiamava Nietzsche) può mettere in luce. Quella di Cristo non è altro che la simbolica ripetizione, a sua volta meno cruenta, di un mito originario, del “primo” sacrificio. Un mito che la tradizione orfica identifica con la passione, la morte e la resurrezione del fanciullo divino – Dioniso – una divinità fatta a pezzi dai Titani, che per questo vengono puniti da Zeus che su di loro scaglia un fulmine. I frammenti smembrati di Dioniso sarebbero stati successivamente ricomposti, e la divinità sarebbe risorta: Dioniso è il primo dio che muore e rinasce.
Prima di venire inceneriti da Zeus, i Titani avevano mangiato la carne cruda di Dioniso e dalla cenere della loro carne bruciata nasce la nostra stirpe che conserva qualcosa di divino (l’anima umana concepita come sostanza dionisiaca sopravvissuta alle ceneri). Dioniso stesso ha una natura in parte titanica, quella natura terribile e ribollente che si esprime nel desiderio di mangiare, di impadronirsi dell’altro per vivere. Egli rappresenta la natura nel suo corso, nel suo divenire, nella sua molteplicità dinamica che vive della morte dell’altro, della frantumazione dell’unità della vita nella particolarità selvaggia dei desideri. Dioniso in quanto eros, violenta cupiditas, è il dio della mobilità affine alla vegetazione e ad ogni forma di eccesso di vitalità, non a caso rappresentato come toro, leone, serpente. Nel suo nome gli antichi esprimevano l’unità di vita e morte, l’unità degli opposti. Ricomposto dalla frantumazione si mostrerà nel manifestarsi del mondo, da lui generato come divisione di un’unità originaria che rimarrà sempre e comunque indivisibile.
In questo nuovo articolo cercherò di intrecciare tutti questi diversi aspetti, analizzando l’esperienza del mangiare dalla prospettiva particolare di una coppia. Che tipo di esperienza fanno gli amanti quando vengono in contatto con altre culture?
Come si modifica la relazione attraverso le nuove sensazioni sperimentate nel corso di un viaggio che porta i protagonisti di un racconto in un paese esotico, a contatto con cibi e gusti diversi, che recano in sé le tracce di un passato ancestrale? A guidarci in questa esplorazione è un racconto di Calvino, Sotto il sole giaguaro (dedicato a tre dei cinque sensi), che lo scrittore dedica al gusto.
Vale la pena riportare la motivazione dello scrittore a scrivere queste pagine, così come lui stesso la riferisce nella Prefazione, dove scrive che l’uomo contemporaneo, avendo che fare con il mondo scritto, non ha più dimestichezza con la dimensione dei sensi, o meglio con la conoscenza degli oggetti attraverso i sensi. È possibile infatti che la nostra cultura ci abbia portato a sviluppare le sensazioni che la vista o l’ascolto ci offrono, dimenticando l’importanza delle informazioni che ci possono venire dal tastare qualcosa, sentirne l’odore, assaporarne il gusto. Così, ad esempio, può essere che l’uomo del futuro rimarrà senza naso, perché avrà dimenticato l’alfabeto dell’olfatto, e i profumi potranno rimanere senza parola, illeggibili. Da una parte, allora, dobbiamo ritrovare un rapporto più immediato con l’insieme di sensazioni confuse che si generano nel nostro rapporto diretto con il mondo, per poi dar loro una forma di realtà intellegibile. Forse il nostro rapporto con il mondo è troppo mediato dal linguaggio (oggi potremmo dire dalle informazioni) e dovremmo ritrovare una maggiore capacità di fare esperienza in un contatto immediato con il mondo dei sensi. E tuttavia per conoscere il mondo non basta mangiare, perché questo mangiare deve farsi, a sua volta, parola e racconto.
Calvino prosegue dicendo che il suo scopo principale quando scrive è di modificare sé stesso, e dunque l’esperienza non può essere posseduta dall’inizio. La spinta a scrivere «è sempre legata alla mancanza di qualcosa che si vorrebbe conoscere e possedere, qualcosa che ci sfugge». Ciò che apprezziamo nei grandi scrittori, continua Calvino, «è il senso dell’approccio all’esperienza, più che il senso dell’esperienza raggiunta; il loro segreto è saper conservare intatta la forza del desiderio». Questo dovrebbe essere il senso della scrittura, non solo in letteratura ma anche, per quello che ci riguarda, in filosofia, anche se a volte il testo sembra giungere dalla «cima di un’esperienza assoluta», dal vertice di un sapere assoluto. La scrittura raggiunge una certa intensità se sa custodire la forza del desiderio (di capire): scriviamo per dare forma, «per rendere possibile al mondo non scritto di esprimersi attraverso di noi».
In questo secondo racconto, che dà il titolo al libro, marito e moglie si ritrovano in viaggio attraverso il Messico, in una fase della loro storia in cui, come dice il marito, «l’intensità fisica» sta «attraversando una fase di rarefazione se non d’eclisse». Un fatto che doveva trovare una nuova soluzione, tanto più che, per entrambi, solo nell’unità della coppia le soggettività potevano trovare «amplificazione e completezza». I due sono differenti ma complementari, accomunati e divisi dalla stessa passione per i sapori che vivono però in modo diverso, in rapporto ai loro temperamenti. La moglie, «Olivia, più sensibile alle sfumature percettive e dotata di una memoria più analitica dove ogni ricordo restava distinto e inconfondibile»; il marito, consapevole che il suo rapporto con il mondo passa attraverso la moglie, che sa cogliere molte più cose di lui, si sente anche «più portato a definire verbalmente e concettualmente le esperienze, a tracciare la linea ideale del viaggio compiuto dentro di noi contemporaneamente al viaggio geografico».
All’inizio del racconto i due restano colpiti da un quadro esposto all’interno dell’albergo che ritrae una giovane monaca e un vecchio prete, raffigurati insieme per lo straordinario amore che li aveva legati. Un grande amore che sublimava ma non cancellava l’emozione corporea. Questa immagine li porta a desiderare con maggiore intensità di mangiare piatti locali. Si rendono conto di aver gustato per giorni vivande preparate seguendo le antiche ricette delle monache, le cui vite intere erano state dedicate alla ricerca di combinatorie uniche d’ingredienti e alla trasmissione di questo sapere minuzioso. Ricette che esprimevano fantasie di donne raffinate, con bisogni d’assoluto, «donne con contrastanti richiami nel sangue, genealogie in cui la discendenza dei Conquistadores si mescolava con quella delle principesse indie, o delle schiave […]». Le due civiltà s’erano fuse, e così la cucina della nuova civiltà ispano-india esprimeva questa tensione tra la ferinità aggressiva degli antichi dèi dell’altopiano e la sovrabbondanza sinuosa della religione barocca. La presenza di Dio era identificata in un delirio di sensazioni eccessive e il bruciore della varietà indigena di peperoncini traboccanti apriva la via ad un’estasi fiammeggiante. Questa idea evocava i sapori di una cucina portata a far vibrare sapori estremi, in accordi e dissonanze che s’imponevano in un’esperienza unica, quasi una possessione sulla ricettività di tutti i sensi.
Marito e moglie cominciano a comunicarsi tutto ciò che sentono attraverso i sapori, o meglio comunicano coi sapori attraverso il loro «doppio corredo di papille». «Senti? Hai sentito?», dice l’una all’altro, come se i loro incisivi avessero triturato lo stesso boccone. Anche se l’intesa fisica era diminuita tra loro, la carica vitale di Olivia non era venuta meno, notava il marito. I suoi palpiti continuavano a dispiegarsi senza perdere «nulla della loro intensità, con una sola variante di rilievo: l’aver per teatro non più il letto dei nostri abbracci ma una tavola apparecchiata». Questa accensione del palato avrebbe dovuto trasmettersi a tutti i sensi. Invece no, questa cucina così afrodisiaca stimolava sì desideri e passione fisica, ma «solo nella sfera di sensazioni che li aveva fatti nascere, dunque mangiando sempre nuovi piatti che rilanciassero e ampliassero quegli stessi desideri». Ora potevano capire che tipo di passione era stata vissuta tra la badessa e il cappellano: un amore «casto, e nello stesso tempo di una carnalità senza limiti in quell’esperienza dei sapori raggiunta per mezzo d’una complicità segreta e sottile».
Così il rapporto che sembrava essersi rarefatto, riprende vigore attraverso una cucina in sé e per sé afrodisiaca, attraverso sensazioni che potevano essere soddisfatte solo assaggiando nuovi cibi. Tutta l’esperienza di conoscenza della coppia durante il viaggio passa attraverso il comune interesse per il cibo, che diventa lo strumento e il veicolo della loro comunicazione. Di esso parlano sempre i due protagonisti e la loro conoscenza avviene sempre attraverso un ricco vocabolario culinario. Al mangiare corrisponde un conoscere: da una località all’altra il lessico gastronomico variava proponendo sempre nuovi termini da registrare e nuove sensazioni da distinguere: dal corpo alla mente e dalla mente al corpo. Un desiderio irrefrenabile portava Olivia ad esprimere al marito ciò che sentiva. E questo era possibile solo attraverso i sapori, in una identificazione talmente potente da immaginare di mangiare appunto lo stesso boccone. Se la tavola finì per sostituire il letto, allora il mangiare poteva soddisfare la stessa spinta ad inglobare l’altro presente nell’atto amoroso.
Il cibo diventa così conoscenza, cibo della mente, un modo di definire il rapporto personale. Mentre osserva la moglie, il marito ha la sensazione che i denti di lei affondino nella sua carne, addirittura di essere sollevato contro la volta del palato e poi dilaniato nelle fibre … e mentre viene masticato immagina anche di provocare in lei ogni sua vibrazione, «sensazioni che si propagavano dalle papille della bocca per tutto il suo corpo». Un rapporto ormai che si identificava pienamente con un pasto, che però la moglie trovava scipito, senza sapore. «Ecco ero insipido pensai, e la cucina messicana con tutta la sua audacia e fantasia era necessaria perché Olivia potesse cibarsi di me con soddisfazione; i sapori più accesi erano il complemento, anzi il mezzo di comunicazione indispensabile come altoparlante che amplifica i suoni perché Olivia potesse nutrirsi della mia sostanza». Questa similitudine tra cibo e suono sposta la percezione del cibo dal piano sensibile a quello simbolico, intelligibile. Da una parte il conoscere diventa una metafora del rapporto fisico, dall’altra appare evidente come il rapporto fisico possa essere comunicato solo attraverso le parole, in una indistinzione tra i corpi e i nomi delle pietanze.
E così i due vivono in un clima di complicità la conoscenza[3] del paese, che diventa gusto, tensione ad assaporare, a capire attraverso i sapori. La conoscenza del paese diventa gusto, tensione ad assaporare, a capire attraverso i sapori. Tramite il cibo può prendere corpo una particolare idea del viaggiare, del conoscere, in un mondo in cui «tutto ciò che è visibile lo puoi vedere anche alla televisione [oggi diremmo dal tuo pc] senza muoverti dalla tua poltrona». «Il solo modo di viaggiare che abbia un senso», «il vero viaggio», la vera esperienza, «in quanto introiezione d’un “fuori” diverso dal nostro abituale, implica un cambiamento totale dell’alimentazione, un inghiottire il paese visitato, nella sua fauna e nella sua flora e nella sua cultura […] facendolo passare per le labbra e l’esofago». Il viaggio si configura così come una conoscenza di tipo alimentare.
Ad un certo punto, però, fanno una nuova esperienza: visitando le rovine del monte Albán, vedono i bassorilievi dove è rappresentata la storia dei popoli che si sono succeduti in quel luogo ed i riti sanguinari che accompagnavano una concezione del tempo ciclica e tragica, con sacrifici umani a cui era destinato, come segno di gran privilegio, chi vinceva e non chi perdeva, nell’offerta al sole d’un cuore umano palpitante, affinché l’aurora tornasse a illuminare il mondo ogni mattino. Mentre pongono ripetute domande alle guide per sapere se quei popoli praticassero il cannibalismo, marito e moglie sono trascinati in un’atmosfera surreale, quasi a farne metaforicamente esperienza: l’uomo osserva i denti della moglie non più «come il lampo luminoso di un sorriso ma come gli strumenti più adatti alla propria funzione: l’affondare nella carne, lo sbranare, il recidere». Il cannibalismo diventa l’idea fissa dei loro pensieri. Dall’atteggiamento reticente delle guide nel rispondere alle loro domande capiscono che i resti dei sacrifici venivano cucinati in modo da non attutirne il sapore ma addirittura esaltarlo in una cucina sacra che doveva celebrare la terribile armonia degli elementi raggiunta attraverso il sacrificio. Capiscono che quei popoli vivevano le loro esperienze in modo assoluto, per cui ciascuno era potenzialmente sacrificatore e vittima, anzi poteva essere mangiato proprio perché lui stesso aveva mangiato altri uomini. Comprendono che la guida sta parlando «del serpente come simbolo di continuità della vita e del cosmo». L’uomo capisce che il suo torto con la moglie era di considerarsi mangiato da lei, mentre era stato colui che la mangiava. «La carne umana di sapore più attraente è quella di chi mangia carne umana. Solo nutrendomi voracemente d’Olivia non sarei più riuscito insipido al suo palato». Si potrebbe dire che solo esprimendo questo aspetto terribile del desiderio di impadronirsi dell’altro sarebbe potuto diventare l’artefice di una nuova intensità amorosa.
La risposta alla loro curiosità ed al loro desiderio di un’esperienza assoluta[4], i due la trovano infine nel territorio dei Maja di fronte al bassorilievo del Sole-giaguaro, dove è raffigurato il re sacerdote nell’atto del sacrificio, a sua volta rappresentato come una discesa del corpo sacrificato agli dei sotterranei e una rinascita nella vegetazione. Di fronte al bassorilievo l’uomo rivive la scena in un’esperienza unica: «Discesi, risalii alla luce del sole-giaguaro, nel mare di linfa verde delle foglie. Il mondo vorticò, precipitavo sgozzato dal coltello del re-sacerdote giù dagli alti gradini sulla selva di turisti con le cineprese […] l’energia solare scorreva per reti fittissime di sangue e clorofilla, io vivevo e morivo in tutte le fibre di ciò che viene masticato e digerito e in tutte le fibre che s’appropriano del sole mangiando e digerendo».
Mangiare ed essere mangiato sembrano atti reversibili all’interno di questa corrente di vita impersonale. Quando ritorna al ristorante dove la moglie lo attende, come se avesse anche lei partecipato all’esperienza del marito, i loro denti cominciano a muoversi con pari ritmo, mentre i loro sguardi si fissano con un’intensità di serpenti immedesimati nello spasimo di inghiottirsi a vicenda, coscienti a loro volta di essere inghiottiti dal serpente che tutti digerisce e assimila incessantemente nel processo d’ingestione e digestione del cannibalismo universale, che impronta di sé ogni rapporto amoroso e annulla i confini tra i nostri corpi e la sopa de frijoles, lo huacinango a la veracruzana, le enchiladas…. Nell’ossessione di un abbandono alla natura e alla carne torna infine, nella scrittura di Calvino, qualcosa di mentale che passa per il cibo, laddove anche la fisicità del rapporto sembra poter essere comunicato solo con le parole, attraverso l’elenco di nomi di pietanze con cui si chiude il racconto.
C’è un senso di orrore e insieme di liberazione in questo racconto: orrore di fronte ad una sorgente di vita, il sole, vista come giaguaro che dà la morte, di fronte alla vita dell’universo sentita come cannibalismo universale, processo di ingestione e digestione sul quale si modellano i rapporti tanto tra i gruppi quanto tra i singoli nella relazione d’amore; liberazione nel senso che l’orrore della morte, della discesa nel buio, è inteso come preludio di una rinascita, di una armonia, una nuova aurora, una vegetazione rigogliosa, succulenta e densa di fermenti, una continuità della vita e del cosmo, una rete di fibre viventi alimentate dal sole e dal cibo. L’orrore della morte è superato dalla possibilità di annullare i confini dei corpi ed entrare in un’armonia universale, dove vita e morte, mangiare ed essere mangiato, sono due aspetti di quell’unico universo di cui l’uomo fa parte.
Questo era anche il messaggio che doveva e deve ancor’oggi essere compreso, il fondo drammatico e misterioso della vita. Dobbiamo sapere che l’unità della vita vive solo del conflitto, che l’unità dell’amore vive solo della separazione. Tale verità iscrive, oggi come un tempo, l’essenza costitutiva dell’essere umano nella natura selvaggia, titanica, della frantumazione. Del resto il “fumo” dei resti dei Titani fulminati da Zeus non significa solo cenere ma anche” ira”, “rabbia”, da cui ne deriva che il motore della vita è quell’istinto aggressivo che ritroviamo in tutti i viventi verso tutti i viventi, di cui il mangiare è la manifestazione più evidente.
Potremmo chiederci se a questo livello nel mondo delle parole, della cultura, il “cotto” ormai prevalga sul “crudo” e il contatto diretto con la realtà non sia più possibile, per cui abbiamo a che fare con un cibo verbalizzato, filtrato dall’esperienza intellettuale; oppure se non sia piuttosto la parola ad essere restituita al corpo, al sapore, al gusto che se ne prova in un contatto immediato con il cibo, nel mangiare l’altro, all’interno di un fantasmatico circolo cannibalico in cui ciascuno è allo stesso tempo predatore e predato. Così abbiamo, da una parte, il linguaggio umano costruito sull’interruzione del flusso continuo di vibrazioni, che introduce nel dinamismo del flusso dell’esperienza un blocco, uno stacco. Qui il flusso percettivo è interrotto, non c’è più risonanza con l’ambiente, il che è anche ciò che consente di far entrare nel nostro campo mentale un mondo dettagliato e ricchissimo[5]. Dall’altra parte, l’abbandono ad una situazionalità non più affaticata dal peso del proprio io, capace di risuonare con l’ambiente di cui è parte integrale: «Ciò che è individuale è la relazione, l’anima, non l’io. L’io tende a identificarsi con il mondo, ma appartiene già alla morte, mentre l’anima tende il filo delle sue “simpatie” e “antipatie” viventi. Smettere di pensarsi come un io, per viversi come un flusso, un insieme di flussi, in relazione con altri flussi, fuori di sé in sé. E anche la scarsità è un flusso, anche il prosciugamento, anche la morte può diventarlo. Sessuale e simbolico – in realtà è uguale – non hanno mai voluto dire altro: la vita delle forze o dei flussi» (Deleuze).
NOTE
[1] Al fine di sistemare la questione con gli umani Zeus incarica Prometeo perché anche se è un Titano, non ha combattuto contro Zeus a fianco degli altri Titani, ma è rimasto neutrale. La condizione di Prometeo è simile a quella umana in quanto anche gli esseri umani sono creature ambigue che possiedono sia un aspetto divino – in origine convivevano con gli dèi -, che un aspetto animale. Tra Prometeo e gli umani c’è un rapporto di complicità perché in entrambi coesistono aspetti contraddittori.
[2] Nell’eucarestia la teologia cristiana affronta il problema dell’effettiva trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Mentre per il cattolicesimo vale il dogma della concreta riconversione di una sostanza nell’altra, con le Chiese riformate viene meno il carattere concretamente sacrificale della messa, quel fare a pezzi e mangiare Dio che alla ragione illuministica non poteva non apparire scandaloso e sconvolgente per la sua evidente parentela con i sacrifici umani dei popoli antichi e selvaggi.
[3] Calvino riporta in esergo al racconto una citazione del Dizionario dei sinonimi di Niccolò Tommaseo, che rimanda al valore conoscitivo (cioè intellettuale) dell’esperienza di gustare: «Gustare, in genere, esercitare il senso del gusto, riceverne l’impressione, anco senza deliberato volere o senza riflessione poi. L’assaggio si fa più determinante a fin di gustare e di sapere quel che si gusta; o almeno denota che dell’impressione provata abbiamo un sentimento riflesso, un’idea, un principio d’esperienza. Quindi è che sapio, ai Latini, valeva in traslato sentir rettamente; e quindi il senso dell’italiano sapere, che da sé vale dottrina retta, e il prevalere della sapienza sopra la scienza».
[4] Attraverso le vestigia di questa antica cultura i due protagonisti vogliono fare un’esperienza intensa della corrente di vita impersonale che rompe i confini dell’io. Per questo devono disfarsi della loro identità di turisti perché «l’orrore, il sacro e il mistero, vengono inglobati dal turismo, che ci detta comportamenti preordinati, modesti succedanei di quei riti». E così, contemplando i gradini delle grandiose scalinate e le piattaforme per i sacrifici umani cercano di immaginarsi il sangue caldo zampillante dei petti squarciati dalle lame di pietra dei sacerdoti.
[5] Il linguaggio può alienarmi, proiettando ciò che sono fuori di me (la proiezione alienante era il cuore della critica feuerbachiana, che aveva assegnato al mangiare questa funzione decostruttiva), ma può anche disalienarmi riportandomi alla dimensione diretta della vita e alla singolarità della mia situazione concreta proprio attraverso la ricchezza dei simboli.