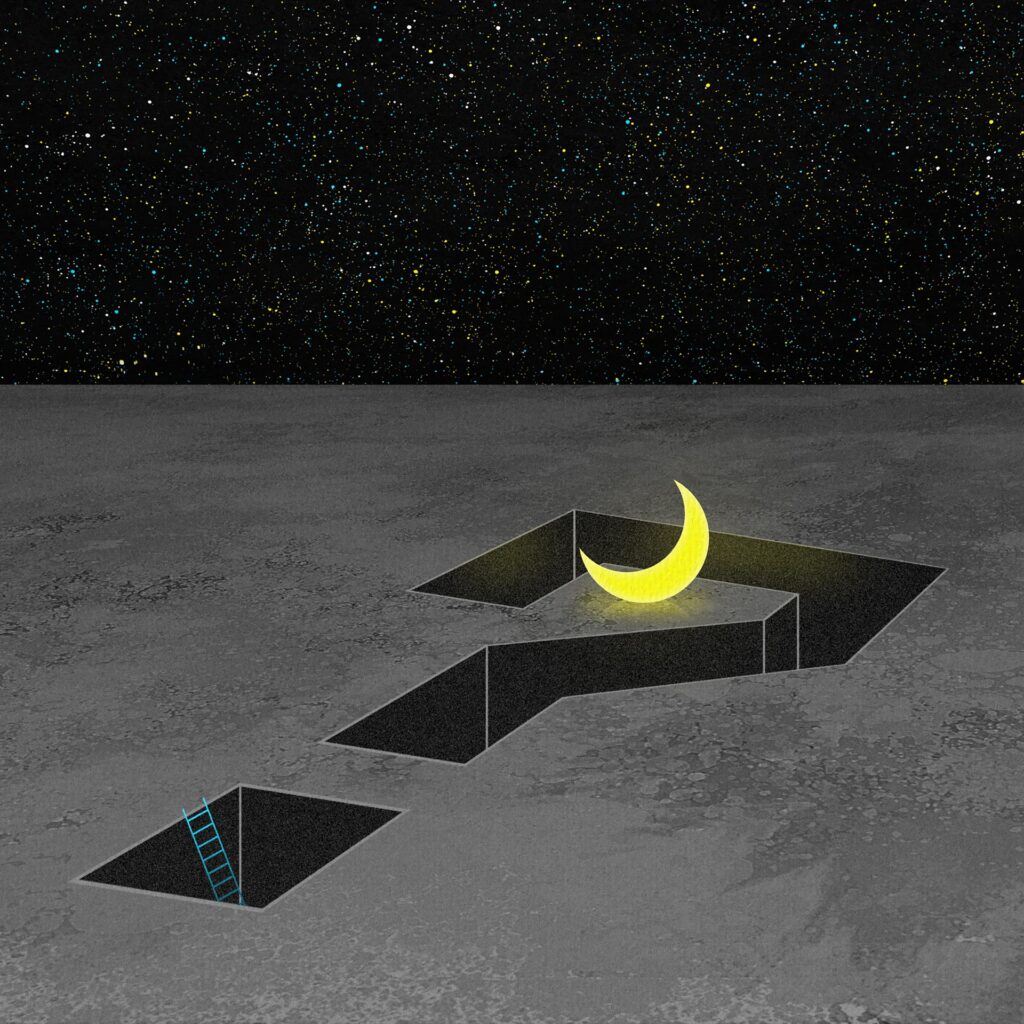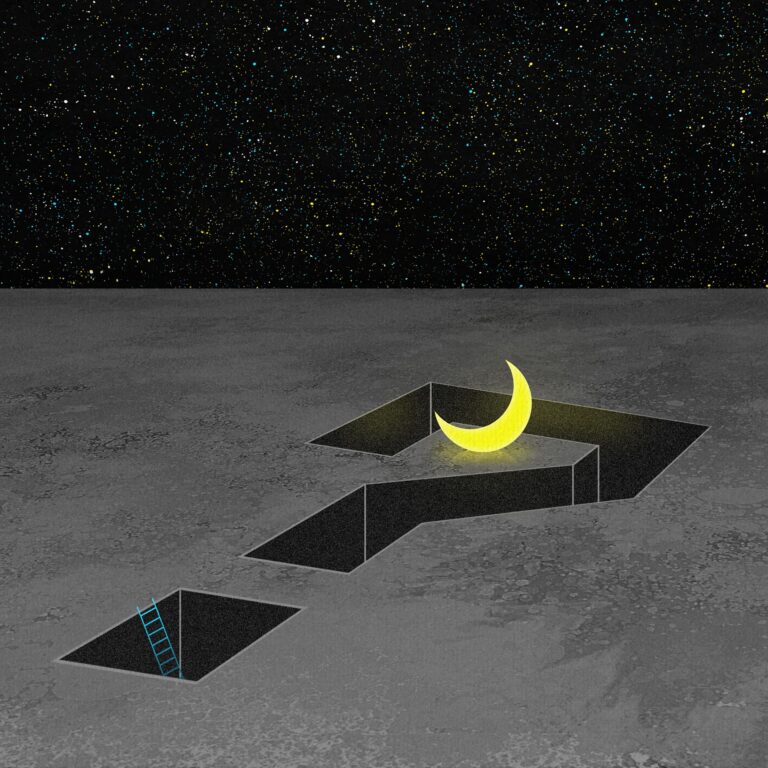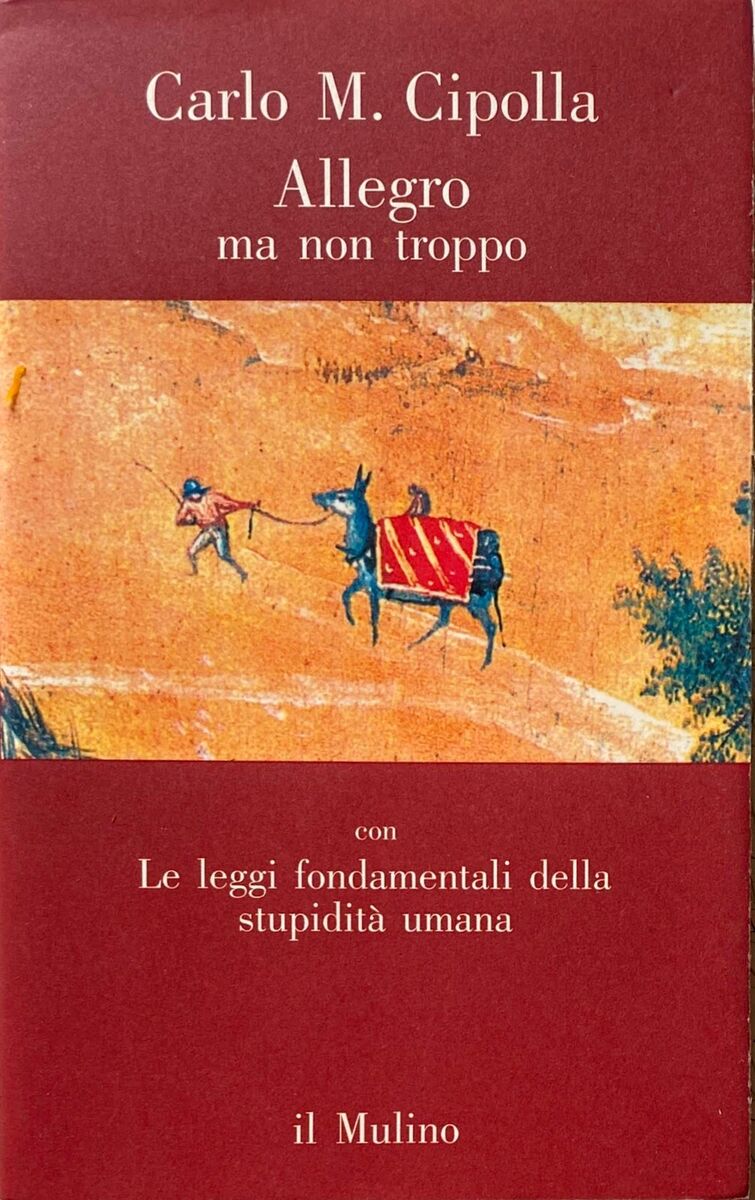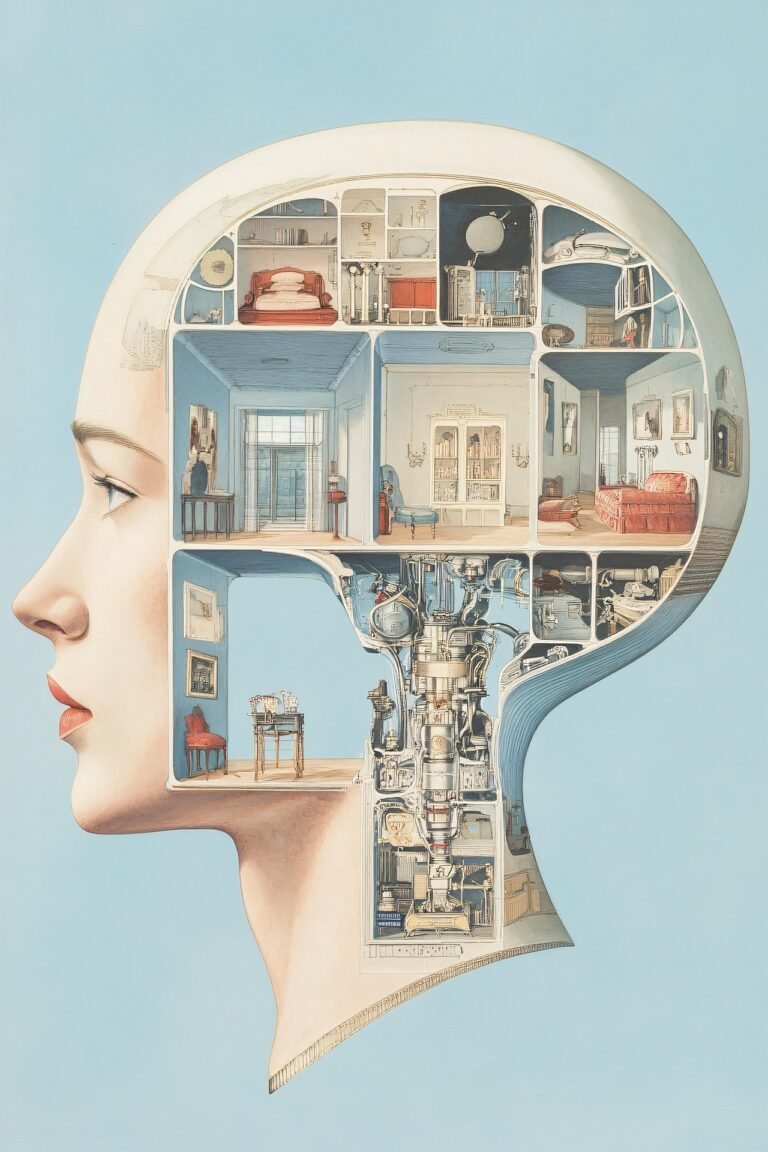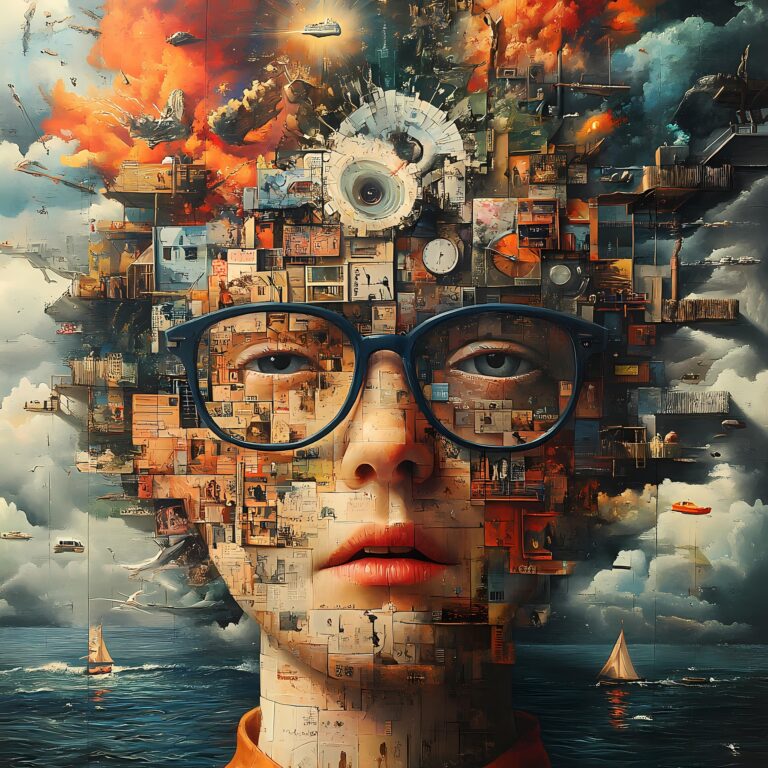L’effetto Dunning Kruger è una distorsione cognitiva che prende il nome dai due psicologi che lo hanno primariamente studiato. Si tratta di una relazione inversamente proporzionale tra l’oggettiva conoscenza di un argomento e la soggettiva percezione di padroneggiare lo stesso argomento. Un esempio recente riguarda la pandemia da Covid, quando numerosi strati di popolazione non esperta di vaccinazioni e microbiologia si ritenevano in grado di esprimere anche legittimamente la propria opinione ma non sentendosi da meno rispetto agli studiosi dell’ambito; al contrario, numerosi sanitari – e il sottoscritto con loro – sentivano, pur essendo “del settore”, di non potersi sbilanciare adeguatamente, consci dei limiti della scienza stessa e dei propri studi. Tale effetto ricalca perfettamente una nota massima del filosofo Bertrand Russell che, sconsolato, soleva dire «il problema di questo mondo è che gli intelligenti sono pieni di dubbi e gli stupidi pieni di certezze».
Russell non era certo uno che le mandava a dire, un aristocratico britannico abituato a guardare tutti dall’alto in basso: si può dire che, invece, più elegantemente i due studiosi abbiano riassunto un concetto che pare avere anche origini lontane e più umili, probabilmente cugino di secondo grado del detto popolare “la ragione si dà ai fessi”.
Date queste premesse quindi, sembra pacifico accettare l’idea che probabilmente intelligenza e dubbio siano come le due eliche del DNA: legate l’una all’altra.
«l dubbio è uno dei nomi dell’intelligenza» sosteneva Borges.
Difatti, quella “sottile arte del dubbio” che è la filosofia è stata considerata per secoli la massima espressione del “cervellone”, del “sapientone”. Il padre in Occidente, a sua volta, della madre di tutte le scienze è considerato infatti Socrate, un uomo che ha fatto della propria filosofia la sua stessa vita e della sua stessa vita la propria filosofia. Viveva NEL dubbio e viveva IL dubbio, contestando con fermezza le certezze che i sofisti ateniesi propinavano alle giovani menti del tempo, nel pieno della Guerra del Peloponneso, quando lo splendore dell’Atene classica iniziava a scemare e l’insinuatore di dubbi non poteva che essere un pericoloso ramo da estirpare anziché un’apprezzata risorsa sociale.
Una certezza in questo mare di insicurezze è che nell’esercizio del potere, infatti, il dubbio facilmente addiviene il principale nemico. Anche al di fuori dell’ambito democratico, l’Uomo ha sovente mostrato di necessitare di certezze ferme e ha espresso innumerevoli volte apprezzamento per i decisionisti, i sofisti che sanno ammaliare con la parola e la retorica, antitetici al catoniano Rem tene, verba sequentur.
Persone anch’esse intelligenti, i decisionisti, a saper cavalcare gli umori delle piazze per venire a capo dei problemi comuni. Per farsi eleggere servono voti, e li si ottengono con poche frasi ad effetto, slogan diretti e non con le lezioni accademiche e non certo stimolando la folla a portarsi a casa meno certezze di quante ne avessero prima. La piazza cerca le sicurezze, un contenimento al proprio continuo ondeggiare. Poco importa quanto siano robusti questi argini e di che materiale siano fatti, l’importante è che ci siano.
Antitetici a questi uomini di polso ci appaiono però i simboli dell’uomo intelligente par excellence, come la statua del pensatore di Rodin: una figura che si contorce nel dubbio, nel porsi questioni, che si arrovella per venire a capo del problema che ha di fronte.
E un altro emblema di intelligenza viene dalla mitologia, l’Ulisse dantesco, l’uomo dal multiforme ingegno (polytropon), che mette in dubbio il confine delle colonne d’Ercole, imposto da un semidio ma in realtà dagli uomini stessi, per portare il sapiens oltre i confini delle terre conosciute. Cos’altro è poi l’intelligenza, se non l’esplorazione di terre sconosciute per arrivare a vecchie e nuove mete?
L’intelligenza è la capacità di superare le sfide imposte dal mondo, intimamente connessa alla legge di un’altra pietra miliare della storia occidentale, quella di Charles Darwin.
In natura a perpetuare la propria esistenza non è il più forte, o il più sicuro, ma colui che meglio si adatta, colui che sa mettere in dubbio i cliché. Darwin seppe questionare la certezza del creazionismo, che pure era così intuitivo – d’altra parte, chi aveva mai visto un grosso lucertolone trasformarsi in una gallina?
E ancora Galileo, che mise in dubbio la realtà autoevidente del movimento degli astri attorno alla Terra: non facile pensare che ci stiamo muovendo continuamente intorno al Sole, e manco un po’ di nausea.
Val la pena accennare allora anche a Cartesio che, volendo costruire il metodo perfetto d’indagine, affermò che tutto è dubitabile, a parte la propria esistenza come essere che si interroga persino sul suo stesso esistere. Cogito ergo sum, sono pieno di dubbi, perciò esisto, o esisto almeno come un misero essere che dubita.
Si potrebbe affermare allora che intelligenza è saper sguisciare nelle paludi dell’incerto. Se il mondo fosse “terra già nota”, non ci sarebbe probabilmente la spinta adeguata per muoversi, e svegliarsi ancora un nuovo giorno. Beato colui che si sveglia col dubbio ogni mattina perché ha almeno un ottimo motivo per iniziare a camminare.
Ovviamente, est modus in rebus, non ci si dimentichi dell’«aurea mediocritas», lezione di Orazio. Occorre mettersi in guardia anche da un suo esercizio indiscriminato. Dubitare senza prove per il gusto di distruggere le impalcature, le linee guida, «gli strumenti umani», con le parole poetiche di Vittorio Sereni. Avere, cioè, l’ardire di sentirsi sempre Sherlock Holmes in un mondo di Watson. Si ricadrebbe così, di nuovo, nell’effetto Dunning Kruger, sopravvalutando stavolta le proprie capacità investigative.
E allontanando lo sguardo dai sapienti del passato, si apre dunque un futuro di vertiginosi timori e perplessità, horror vacui per i comuni mortali, frontiera per le persone c.d. «intelligenti», lontane dal positivismo ottocentesco che credeva di poter spiegare tutto con scienza e ragione, tranello in cui cadde persino Marx per delineare la storia del mondo e oracolare sul destino delle classi sociali.
Ben venga che ad oggi la scienza abbia sentenziato la bontà del falsificazionismo di Karl Popper, per cui una teoria scientifica è valida se di essa si può dubitare, metterla in discussione e confutarla. Probabilmente, uno dei più grandi traguardi ottenuti nel XX secolo, il secolo delle certezze muscolari, delle dittature, delle guerre da decine di milioni di morti, delle pulizie etniche, del me contro te a prescindere da tutto.
Evviva il dubbio sano allora, e il suo esercizio morigerato, evviva l’incertezza di ogni passo che porti con sé la ragionevole speranza della progressione in prospettiva.