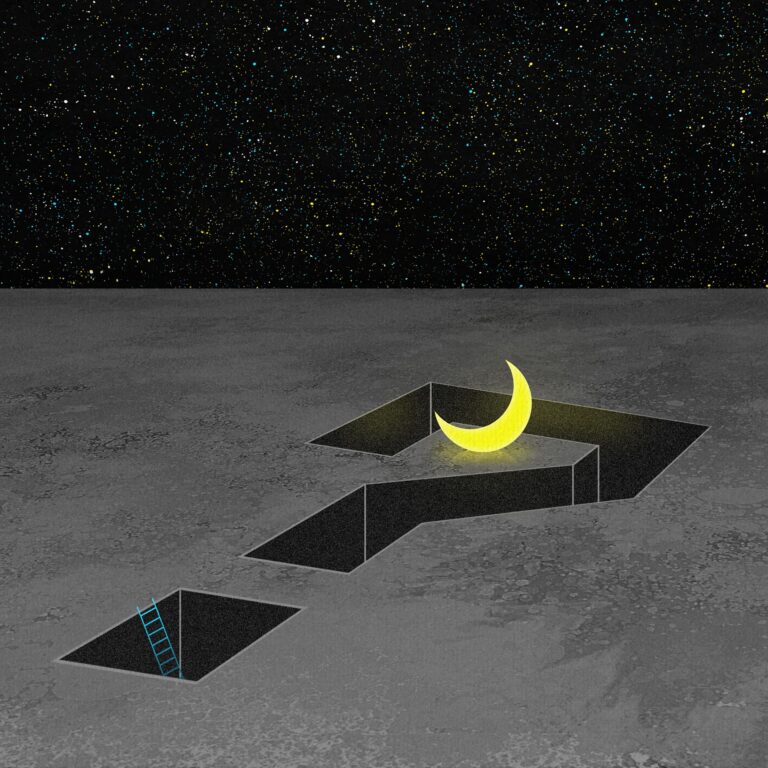Tabù. È questo il termine eloquente che Piers Paul Read scelse nel 1974 per il suo libro che narrava una delle vicende più stranianti mai capitate ad anima viva.
Era il 13 ottobre 1972 e un Fokker F27 stava sorvolando le Ande, cercando di arrivare in Cile a partire dall’Uruguay. Non ci arrivò mai. Si schiantò invece tra quelle selvatiche e impervie montagne.
Si sa, nei disastri aerei di solito non ci sono sopravvissuti. Lì invece ve ne furono. Ma erano nel Nulla, lontani dalla civiltà o, peggio ancora, non sapevano quanto lontani da una qualsiasi forma di civiltà.
Chiunque venga a contatto con questa storia non rimane colpito dai cruenti dettagli dell’incidente, dai tristi particolari della valanga successiva, dalle speranze illuse, dal miracoloso salvataggio. Ci si ricorda solo di un aspetto, macabro, indicibile.
Non soffermiamoci quindi su tutti i risvolti di questa nota vicenda, delle speranze infrante, del freddo, della morte. Affrontiamo invece il tabù.
16 persone sopravvissero alla fine di 72 giorni di tremenda agonia.
Ma come si può restare aggrappati alla vita dopo tutto quel tempo ad altissima quota? Il cibo presente nell’aereo non bastava e la montagna a quelle altezze non offre di che sostentarsi.
Ebbene sì. Quei 16 uomini lo fecero. Infransero il tabù. Le civiltà umane sono tante, diverse tra loro. In alcune è prevista la schiavitù, in altre no. In alcune la pena di morte, in altre no. Ma tutte concordano che una civiltà evoluta, non selvaggia, si mantenga su un vincolo sacro. E quei 16 oltrepassarono il limite. Il loro cibo furono esseri umani.
Gente che condivideva lo stesso viaggio, forse conoscenti, in alcuni casi parenti.
La civiltà era morta, o meglio in coma, sospesa, in quei 72 giorni. Lo sappiamo bene dalla piramide dei bisogni di Maslow. Affetti, realizzazione, stabilità sono basilari per l’uomo nel contesto sociale. Ma i primi bisogni elementari sono quelli fisiologici. E se mancano, gli altri al di sopra smettono di contare. Ci si doveva sfamare, e null’altro era commestibile.
Ma proviamo a scandagliare la mente di quei sopravvissuti.
Cosa vuol dire nutrirsi con carne umana? Si può semplicemente cibarsene utilizzando quel meccanismo di difesa noto in psicologia come dissociazione? “Dimenticare” quindi per un po’ che quella non fosse carne di maiale, pollo o qualsivoglia animale d’allevamento o di selvaggina? Oppure si può accettare, razionalizzando, di diventare per un po’ una bestia carnivora che si nutre della carne che trova disponibile intorno a sé, a qualunque essere appartenga?
E di conseguenza, il “dilemma morale”. Come posso io continuare a vivermi come essere umano se per tutta la mia esistenza, tra i miei album di ricordi mentali, dovrò annoverare un episodio in cui ho sospeso la mia umanità e mi sono trasformato in una belva?
Difficile a dirsi. Quello che è certo che i più coraggiosi tra noi hanno sicuramente provato a immaginare cosa avrebbero fatto in quelle stesse condizioni. Ci saremmo piegati? E se sì, dopo quanto tempo? Resta complicato rispondere, poiché la nostra mente fatica a concepire questo totale stato di necessità.
Erano in condizioni primitive e sono tornati primitivi. L’iconografia occidentale, nel periodo della colonizzazione ha sempre stigmatizzato i “selvaggi” soffermandosi sulla pratica del cannibalismo, vera o presunta che fosse, data la scarsa vena di conoscenza antropologica dei più avidi esploratori del Vecchio Continente. Ironicamente ciò è avvenuto quasi in maniera ciclica.
Difatti la società occidentale che nel periodo delle grandi esplorazioni e in quello coloniale ha cannibalizzato il resto del mondo, ha tra le sue radici fondamentali la religione cristiana. E proprio i paleocristiani furono tacciati in modo denigratorio di cannibalismo dalla cultura pagana che in quel momento era dominante. Una delle tante modalità con cui si espresse il tentativo di repressione del nuovo culto fu proprio il bollare come primitivi coloro che praticavano (e praticano tuttora) un rito fondante in cui ci si nutre del corpo e persino, quasi vampirescamente, del sangue del Dio fatto Uomo. Ed è singolare che la civiltà che si ritiene più evoluta attualmente si basi sul ricordo rituale di una cena in cui un Uomo offre cannibalescamente il suo corpo e il suo sangue per il rinnovo definitivo dell’alleanza già costruita tra Dio e la sua creatura più nobile. Così forse ai nostri occhi il tabù sembra digeribile.
Dunque, il “cannibalismo rituale” esiste nella nostra cultura in maniera figurata, e ciò ci permette di continuare a guardare con aria di superiorità quelle società, per esempio in Guinea, in cui il cannibalismo vero è parte integrante di questi codici rituali. Ben noto è il caso degli indigeni Fore che si cibavano del cervello (e quindi dell’anima) dei defunti della loro tribù, permettendo così la diffusione del kuru, patologia prionica incurabile simile al morbo della mucca pazza. Una sorta di contrappasso per chi decide di oltrepassare il “limite invalicabile”.
La Storia invece non tramanda molti esempi di cannibalismo, eppure tutti sono rimasti ben incisi nella memoria collettiva, dal Conte Ugolino di Dante alla Zattera della Medusa ritratta da Gericault. Storie di conti imprigionati durante le guerre tra guelfi e ghibellini, o di naufraghi in salvo su zattere di fortuna sono numerosissime, ma il particolare vero o presunto di un pasto umano permette a queste vicende di scavalcare tutte le altre nel nostro immaginario.
Tutti questi casi aneddotici sono però legati dal filo conduttore dello stato di necessità, ma uno stato che nelle nostre calde cucine provviste di ricolmi gelidi frigoriferi non riusciamo a concepire. Uno stato di completa indigenza e indisponibilità di risorse, dove possedere tutto il denaro del mondo in quel frangente è totalmente inutile perché non commestibile. Accade questo quando le leggi della civiltà cadono. Può essere ciò l’orrore più grande? Che nemmeno Kurtz di “Cuore di Tenebra” o “Apocalypse Now” poteva immaginare? Cioè quando alla base della piramide di Maslow si pone l’uomo stesso senza più dignità ma nella sua unica accezione di ammasso di carne e interiora? Può essere ciò più orribile della morte? Ovvero evitarla nutrendosi del proprio simile? Forse è vero, peggio della morte esiste solo l’essere posti di fronte alla necessità di evitarla ricorrendo al superamento del tabù definitivo, in altre parole rendere il più letterale possibile la lapidaria massima latina “mors tua, vita mea”.